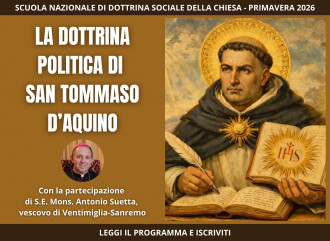Suicidio assistito, il Ddl della destra rimane contro la vita
Approdato alle competenti commissioni del Senato il Ddl Zanettin-Zullo che richiama i criteri di accesso al suicidio assistito indicati dalla Corte costituzionale, pur con delle differenze, dalle cure palliative all’assenza di spese per il Servizio Sanitario Nazionale. Ma al netto dei paletti il testo favorisce la deriva eutanasica.
- «Le cure palliative non riguardano solo i malati terminali», di Fabio Piemonte

Il 2 luglio è arrivato sui tavoli delle commissioni Giustizia e Affari sociali del Senato il testo del disegno di legge, proposto da Pierantonio Zanettin di Forza Italia e da Ignazio Zullo di Fratelli d’Italia, dal titolo Modifica all'articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019.
Come già facevamo notare lo scorso maggio, il disegno di legge richiama i criteri di accesso al suicidio assistito indicati dalla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale (qui un approfondimento), ma non è un copia e incolla della stessa. L’art. 2 del Ddl va a modificare l’art. 580 del Codice penale, che sanziona l’aiuto al suicidio. La modifica è del seguente tenore: «Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui ai commi precedenti, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato Nazionale di Valutazione […]».
Le differenze in merito ai criteri indicati dalla Consulta sono le seguenti. Quest’ultima prevedeva che l’iter del suicidio assistito fosse inserito nell’alveo degli artt. 1 e 2 della legge 219/2017 che ha legalizzato l’eutanasia. Nel Ddl questo rimando è assente, ma poco rileva dato che la legge 219, anche se non espressamente richiamata, deve essere comunque rispettata. In secondo luogo nella sentenza della Consulta non si faceva riferimento a persona maggiorenne. In terzo luogo il Ddl prevede, a differenza della Corte costituzionale, che la persona debba essere già inserita in un percorso di cure palliative. In quarto luogo per il Ddl le sofferenze intollerabili devono essere congiuntamente fisiche e psicologiche, per la sentenza invece potevano essere, in modo disgiunto, o fisiche o psicologiche. In merito poi ai trattamenti di sostegno vitale, il Ddl non recepisce le specifiche della sentenza della Consulta n. 135/2024 (qui un approfondimento), successiva a quella del 2019.
Altra differenza notevole sta nel fatto che la sentenza del 2019 prevedeva che «tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente», invece nel Ddl la verifica della sussistenza delle condizioni è demandata ad un unico Comitato Nazionale di Valutazione. Infine, a differenza di quanto aveva lasciato ad intendere la Consulta, nessuna spesa può essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Chi vorrà morire dovrà farlo di tasca propria.
Ma, procediamo. Come già avevamo sottolineato nel 2019 a commento della sentenza della Consulta, questi criteri presenti nel Ddl sono problematici. Esemplifichiamo. Dato che il Ddl, come appuntato, non si rifà alle specifiche della sentenza del 2024, nei trattamenti di sostegno vitale possono essere inclusi non solo la nutrizione, l’idratazione e la ventilazione assistita, ma anche le cure chemioterapiche, i pacemaker cardiaci, la dialisi, etc. Il bacino di utenti dell’aiuto al suicidio così si amplia. Il concetto poi di irreversibilità della patologia spalanca le porte all’eutanasia a tutti i malati cronici affetti da patologie di per sé letali se non sottoposti a cure. Proseguiamo: l’intollerabilità delle sofferenze fisiche e psicologiche si rifà ad un criterio soggettivo e non oggettivo. La prima e ultima parola spetta dunque solo e unicamente al paziente. In tal modo potranno accedere al suicidio assistito anche i depressi che, se non curati, possono rischiare il suicidio (sì, è un cortocircuito paradossale, ce ne rendiamo conto) e affetti da qualsiasi patologia anche lieve ma ritenuta da loro fonte di sofferenza fisica insopportabile: affaticamento, dolori muscolari e articolari, disturbi del sonno (insonnia o ipersonnia), variazioni dell'appetito e del peso, mal di testa, problemi digestivi. Va da sé che il cumulo di questi disturbi concorre all’insopportabilità della propria condizione fisica.
Ma veniamo al punto centrale. Il titolo dell’art. 1 di questo Ddl è il seguente: «Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita». E così recita: «Il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona […]». La contraddizione è evidente. L’art. 1 sancisce che la vita è bene indisponibile. L’art. 2 indica, all’opposto, come aiutare una persona a togliersi la vita eliminando il presidio della sanzione penale che è stato posto dall’art. 580 C.p. proprio perché la vita è considerata bene indisponibile. L’antinomia è evidente quanto l’ipocrisia.
Ma, tornando al tema del suicidio assistito permesso, anzi legittimato dal Ddl, domandiamoci: per il nostro ordinamento giuridico – e non per i giudici – la vita è un bene disponibile o indisponibile? Su un primo fronte abbiamo una serie di norme che confermano che la vita è bene indisponibile. In primis abbiamo l’art. 2 della Costituzione concernente l’inviolabilità dei diritti umani al cui fondamento non può che esserci il diritto alla vita, inviolabilità che nel testo costituzionale deve essere intesa erga omnes – e quindi comprendente anche il titolare del diritto alla vita stesso – dato che non vi sono espresse eccezioni alcune al riguardo. Inoltre rammentiamo l’art. 32, 1° co. della Costituzione, il quale «statuisce che la Repubblica “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. In quanto tale esso non può logicamente contenere il suo contrario, come avverrebbe se il suo oggetto consistesse indifferentemente tanto nel bene della salute quanto nel suo annientamento» (M. Ronco, Eutanasia, in Digesto discipline penalistiche, Utet, 2010, n. 5).
Sul fronte codicistico citiamo innanzitutto l’art. 579 C.p. concernente l’omicidio del consenziente: se la vita fosse disponibile perché mettere in carcere chi ti ha ucciso con il tuo consenso? L’indisponibilità è confermata poi proprio dall’art. 580 C.p. che ritiene illecito aiutare qualcuno a togliersi la vita. Poi citiamo l’art. 5 del Codice civile che vieta gli atti di disposizione di parti del proprio corpo. Se l’indisponibilità riguarda parte del proprio corpo – eccettuate finalità terapeutiche – a fortiori non potrà che interessare l’intero organismo. Possiamo desumere anche da altre norme che la vita sia indisponibile: l’apparato normativo contro gli stupefacenti, la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, le vaccinazioni obbligatorie, i trattamenti sanitari obbligatori, i periodi coattivi contumaciali per esigenze profilattiche, l’obbligo delle cinture di sicurezza, tutte normative che tutelano la salute e la vita dei singoli anche contro la volontà degli stessi.
Di contro abbiamo la legge 219/17 che ha legittimato in alcuni casi l’eutanasia. In sintesi il Ddl si ispira a quest’ultima legge e non a tutte quelle norme anche di rango costituzionale che qualificano la vita come bene indisponibile. L’opzione eutanasica in questo Ddl è evidente.