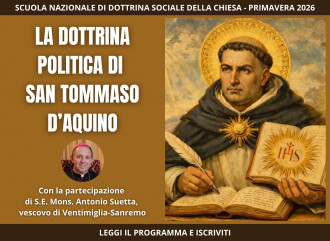Congo, l’M23 diserta l’incontro per la pace con il governo
Ascolta la versione audio dell'articolo
La delegazione del gruppo ribelle M23 non si è presentata per la firma della pace con il governo della RDC. Un accordo che Trump ha cercato di favorire, non considerando però abbastanza l’inaffidabilità degli interlocutori e la complessità della guerra, che coinvolge anche gli interessi del Ruanda.

Il 18 agosto a Doha, nel Qatar, il governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC) e il gruppo armato ribelle M23 avrebbero dovuto firmare un accordo di pace, atto conclusivo di un processo di pacificazione attuato per gradi, iniziato il 23 aprile scorso quando governo ed M23, a seguito di colloqui intercorsi nelle precedenti settimane, si erano dichiarati pronti a cessare immediatamente le ostilità. Invece, il 18 agosto, la delegazione M23 a Doha non si è neanche presentata.
L’M23 è il principale braccio armato di una coalizione antigovernativa, l’Alleanza del Fiume Congo (AFC), e negli ultimi tre anni, con il determinante sostegno militare del vicino Ruanda, ha conquistato porzioni crescenti di territorio nell’est del Paese finché a gennaio è riuscito a impadronirsi anche di Goma e Bukavu, le capitali di due province, il Nord e il Sud Kivu. Adesso controlla vasti territori, ambiti per le loro immense risorse minerarie: uno dei motivi, per alcuni osservatori il principale, per cui il Ruanda sostiene l’M23, grazie al quale ingenti quantità di minerali possono essere contrabbandati oltre confine. Lo scorso anno il Ruanda ha esportato minerali per oltre due miliardi di dollari, il doppio rispetto a due anni prima, e si ritiene che molti provenissero dalla RDC.
Trump ha deciso di intervenire per mettere fine anche a questa guerra e ha ottenuto che i contendenti prendessero in considerazione le sue proposte. Nel corso degli anni RDC e Ruanda hanno firmato diversi accordi di pace, mai però rispettati. Quello formulato dal presidente americano si differenzia dai precedenti perché ha come chiave di volta l’impegno dei due Paesi a creare una partnership per sfruttare insieme le preziose risorse della regione con la partecipazione anche di investitori privati statunitensi. Potrebbe essere un accordo risolutivo, vantaggioso per tutti. In effetti, RDC e Ruanda, che peraltro continua a negare (come ha sempre fatto) di fornire aiuti e truppe all’M23, hanno accettato, e l’accordo è stato firmato il 27 giugno a Washington.
Il presidente Trump, dopo aver aggiunto la sua firma a quelle dei ministri degli esteri congolese e ruandese, aveva definito l’accordo di pace «un glorioso trionfo», una «svolta straordinaria». In effetti ha reso possibile che RDC ed M23 il 19 luglio firmassero a loro volta un cessate il fuoco. L’intesa convenuta, i cui termini sono stati – o avrebbero dovuto essere – ulteriormente definiti il 29 luglio, comportava l’impegno a sottoscrivere un accordo di pace definitivo il 18 agosto e, nel frattempo, a sospendere i combattimenti e la propaganda ostile e ad astenersi da qualsiasi tentativo di conquistare con la forza nuove posizioni.
Ma gli analisti che affiancano il presidente americano, se pure hanno considerato la complessità della situazione e le molteplici incognite, non hanno tenuto sufficientemente in conto gli interlocutori, può darsi che non li conoscano o non li capiscano appieno. Sta di fatto che, come era del tutto prevedibile per chi ha familiarità con gli scenari africani, gli impegni non sono stati rispettati. Le FARDC (Forze Armate della RDC) hanno continuato gli attacchi alle postazioni M23. E l’M23 non ha mai smesso di colpire le basi militari governative; inoltre si è reso responsabile di ripetuti attacchi ai civili.
Un rapporto pubblicato il 20 agosto dall’organizzazione non governativa Human Rights Watch sostiene, a conferma di quanto già denunciato dall’agenzia di stampa Reuters e dall’Onu, che nel solo mese di luglio i combattenti M23 hanno ucciso almeno 300 persone, donne e bambini inclusi, molte delle quali dopo il 19 luglio. Secondo molti testimoni, la maggior parte delle vittime sono di etnia Hutu. Questo chiama in causa uno dei fattori sottovalutati dai mediatori e dal presidente degli USA. Il Ruanda sostiene l’M23 anche perché è composto prevalentemente da combattenti Banyamulenge, i Tutsi congolesi, tuttora minacciati, a distanza di 31 anni, dagli Hutu, l’etnia che nel 1994 in Ruanda, quando era al governo, scatenò il genocidio dei Tutsi ruandesi. In Congo tuttora vivono quel che resta degli Hutu fuggiti in RDC quando il leader Tutsi Paul Kagame riuscì a prendere il potere che tuttora detiene e i loro discendenti. Hanno formato un gruppo armato, le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR), un pericolo per i Banyamulenge e per lo stesso Ruanda. È impensabile che l’M23 deponga le armi e accetti di consegnarle se non faranno altrettanto le FDLR, cosa che finora il governo della RDC ha provato a fare più volte senza risultato.
Altre questioni, cruciali e irrisolte, avrebbero dovuto essere affrontate prima di decantare una «svolta straordinaria» e ancora attendono una soluzione: l’M23 accetterà di ritirarsi dai territori che ha conquistato e che continua a occupare? Il Ruanda ritirerà le truppe – si stima circa tremila soldati – che combattono con l’M23 in territorio congolese? Ma l’incognita vera è se davvero Trump è riuscito a convincere congolesi e ruandesi che è più conveniente, perché così diventeranno più ricchi e potenti, collaborare tra di loro e con gli Stati Uniti nello sfruttamento delle risorse minerarie della RDC piuttosto che continuare come hanno fatto finora a contendersele. Può darsi che per Trump sia più facile far finire la guerra in Ucraina che quella in Congo.