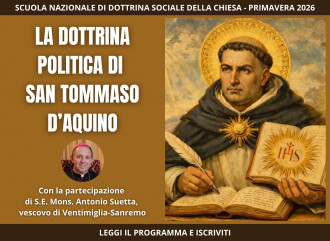Trump e il Paradiso? Tutto sommato ha un suo perché
Ascolta la versione audio dell'articolo
Battuta? Bravata? Atto di superbia? Quali che siano le vere ragioni che hanno spinto Trump a parlare della sua volontà di andare in Paradiso, è innegabile che anche Cesare debba essere soggetto a Dio. Un concetto evangelico che la Riforma ha interrotto.

In questi giorni, diversamente dai suoi predecessori, Donald Trump ha detto di non potere andare in vacanza, perché deve “guadagnarsi il Paradiso”. Lo ha ripetuto un paio di volte, da ultimo in una intervista a Fox News. Ha detto di aver impedito sei guerre e di voler salvare 7000 persone al giorno, sperando che questo possa essere sufficiente. Per questo, per guadagnarsi il Paradiso, non andrà in vacanza ma rimarrà al suo posto e seguirà in questi ultimi giorni di agosto gli eventi per la pace in Ucraina.
È stata una battuta? Una bravata? Un atto di superbia velato da ironia? Una teatralità da primo attore che si trova in questi giorni sul proscenio in attesa del mazzo di fiori per la sua brillante recita? Un atto di propaganda? Come per tutti gli interventi di Trump che hanno riguardato la religione, anche questa volta si sono moltiplicate le interpretazioni. Però di due aspetti bisogna tenere conto: prima di tutto che la coscienza di una persona è inaccessibile e solo Dio la vede in trasparenza; secondariamente che quanto uno dice ha un valore in sé, indipendentemente dalle sue intenzioni. Solo Trump, e forse nemmeno lui dato che spesso fatichiamo anche a conoscere noi stessi, sa cosa intendesse veramente dire e, soprattutto, quanto egli stesso vi credesse. In ogni caso quanto ha detto ha la propria importanza, contiene un significato autonomo, chiede di essere interpretato per quello che è e che vale. E siccome non è frequente sentire un politico parlare di Paradiso, Trump o non Trump, quell’uscita merita il nostro interesse.
“Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. Questa frase di Gesù tramandataci dai Vangeli sembra indicare una separazione tra politica e fede, però subito dopo, riflettendoci, vien da pensare che anche Cesare è soggetto a Dio. Allora quello che Cesare fa, il suo livello operativo, ha una sua autonomia e non coincide col piano della fede in Dio, però non ne può stare senza dato che, alle fine, ciò che dà un senso ultimo a quell’azione politica non può essere solo la politica. Per essere buoni politici non bisogna necessariamente essere santi, anche se ci sono stati e forse anche oggi ci sono, politici santi, ma non si può essere buoni politici fermandosi alla sola politica e cercando solo in essa le motivazioni dell’agire politico, senza guardare più in là. Il principiato non può stare senza il principio, e la politica certamente non è il principio. Questo lo dicevano addirittura i Greci.
Nel febbraio 2011, Benedetto XVI tenne il suo discorso al Parlamento tedesco sul fondamento della politica e sulla natura del potere politico. Lesse di Salomone che chiese a Dio la sapienza per svolgere bene il proprio lavoro regale alla guida di Israele. Non chiese risorse materiali, chiese questa sapienza che possiamo chiamare religiosa. Benedetto chiarì il senso di questa richiesta di Salomone: la legittimazione del potere politico sta nel diritto naturale, nel bene comune, nell’ordine e nella giustizia che rappresentano i fini della politica al proprio livello. Tuttavia, senza una sapienza superiore che viene da Dio, chi gestisce il potere facilmente si indebolisce anche a quel livello e perde la giusta via. La politica è politica e non è fede, ma la fede può renderla meglio politica. Certo, non ogni fede, non una fede qualsiasi.
In un passaggio dell’enciclica Caritas in veritate (2009), Benedetto XVI dice che “senza la prospettiva di una vita eterna, il progresso umano in questo mondo rimane privo di respiro. Chiuso nella storia, esso è esposto al rischio di esporsi al solo incremento dell’avere; l’umanità perde così il coraggio di essere disponibile per i beni più alti, per le grandi e disinteressate iniziative sollecitate dalla carità universale” (n. 11). Non c’è dubbio che l’impegnativa riconquista della pace dopo anni di guerra rientri nelle casistiche qui adombrate. Parlare di Paradiso è parlare di vita eterna e non c’è altro di più concreto e vitale a muovere le azioni umane, anche e soprattutto quelle dei politici.
La frase di Donald Trump suona con una sua stranezza e provoca un certo stridore perché il campo della politica è stato completamente invaso dalla secolarizzazione da intendersi come emancipazione della politica dalla religione. Nessun leader politico europeo, per esempio, potrebbe rifarsi in qualche modo alla religione e se lo facesse verrebbe bandito dalla comunità dei sani di mente. La secolarizzazione è storicamente dipesa soprattutto dalla Riforma protestante e il principio Cuius regio erius religio se da un lato fondava lo Stato confessionale, dall’altro faceva del ruolo della religione in politica una questione di scelta.
La Riforma fondò la secolarizzazione perché non ammetteva un collegamento tra la ragione politica e la fede e non assegnava al potere politico un ruolo in ordine al bene comune. Al contrario del pensiero cattolico il quale, assegnando al potere questo compito del bene comune poteva poi spiegare che esso aveva bisogno del Bene ultimo, ossia di Dio. Trump non si dice cattolico, ma evangelico, però è attorniato da molti cattolici nel suo stesso Gabinetto.
C’è oggi in America una certa intesa tra gli evangelici non più disponibili a spingere la secolarizzazione verso il nulla della cultura Woke e i cattolici tradizionali (o tradizionalisti). Le motivazioni non sono le stesse, e andranno chiarite, ma intanto certe prese di posizione si assomigliano. Come anche questo accenno di Trump al Paradiso.