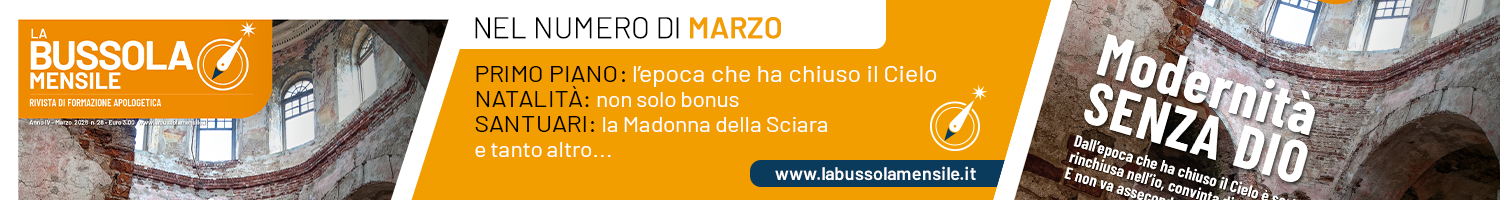Libano e Siria, tra guerre interne e ambiguità internazionali
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’inviato USA, Tom Barrack, è tornato in Libano dove tiene banco il disarmo di Hezbollah, questione su cui il Paese rischia un conflitto interreligioso. Resta nel caos anche la Siria, ma prosegue la normalizzazione del governo jihadista ad opera della comunità internazionale.

Il 18 agosto scorso l'inviato degli USA per la Siria e il Libano, Tom Barrack, è nuovamente volato a Beirut per conferire con le istituzioni libanesi, accompagnato dalla sua vice, Morgan Ortagus. Secondo fonti ufficiali, Barrack si è concentrato sulla questione del disarmo di Hezbollah, mentre Ortagus si è occupata di UNIFIL, il cui mandato è in scadenza il prossimo 31 agosto. I due diplomatici americani hanno altresì invitato Rodolph Haykal, comandante dell'esercito libanese, a portare a termine il disarmo della milizia sciita, come precondizione al ritiro delle forze armate israeliane dal Libano, alla cessazione delle loro aggressioni e anche ai finanziamenti internazionali per la ricostruzione del sud del Paese. Barrack ha lodato le iniziative libanesi per disarmare Hezbollah e garantito che, per ogni decisione «giusta» presa dal governo libanese, Israele farà un passo di conseguenza.
 Gli inviati americani hanno raggiunto Beirut pochi giorni dopo un clamoroso discorso televisivo del segretario di Hezbollah, Naim Qassem, che ha invitato il governo libanese a «non consegnare il Paese all'insaziabile aggressore israeliano o al tiranno americano», dichiarando che la milizia sciita è pronta a ribellarsi nel caso le fosse imposto il disarmo con la forza e «lotterà per mantenere le armi». Ambienti vicini a Hezbollah hanno letto il precipitoso viaggio di Barrack e Ortagus a Beirut come un tentativo di rassicurare i libanesi dopo il dirompente – sebbene non inaspettato – discorso dell'anziano segretario.
Gli inviati americani hanno raggiunto Beirut pochi giorni dopo un clamoroso discorso televisivo del segretario di Hezbollah, Naim Qassem, che ha invitato il governo libanese a «non consegnare il Paese all'insaziabile aggressore israeliano o al tiranno americano», dichiarando che la milizia sciita è pronta a ribellarsi nel caso le fosse imposto il disarmo con la forza e «lotterà per mantenere le armi». Ambienti vicini a Hezbollah hanno letto il precipitoso viaggio di Barrack e Ortagus a Beirut come un tentativo di rassicurare i libanesi dopo il dirompente – sebbene non inaspettato – discorso dell'anziano segretario.
Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha replicato a Qassem che la decisione di disarmare Hezbollah è prettamente libanese, che non c'entrano le pressioni americane, che le sue parole sono «inaccettabili» e rappresentano «una velata minaccia di guerra civile», guerra che «nessuno in Libano vuole». In realtà, la miccia del conflitto interreligioso sembra già accesa: l'ex ministro della giustizia e attuale deputato sunnita Ashraf Rifi ha dichiarato che intenterà una causa contro Qassem e che i suoi sono pronti a scendere in strada se il Partito di Allah deciderà di sfidare il Paese: «Metto in guardia Naim Qassem contro una scelta sconsiderata della quale pagherà il prezzo. Scenderemo nelle strade se ci sarà bisogno di difenderci, e siamo capaci di farlo». La dichiarazione insinua qualche dubbio sul fatto che, come si dice, Hezbollah sia l'unica milizia armata del Paese. Che la nuova fioritura jihadista in Siria offra nuove possibilità di revanche al sunnismo libanese, messo in ombra negli ultimi quarant'anni dall'espansione sciita guidata da Hezbollah, è una certezza.
In Libano le opinioni della gente comune sul disarmo di Hezbollah sono fortemente contrapposte a seconda delle zone di residenza, delle affiliazioni politico-religiose e dei danni subiti dall'aggressione israeliana. «Dovunque vada, la gente è ansiosa e pessimista su quello che accadrà a breve» afferma Fadi (il nome è di fantasia), venticinque anni, di Saida (Sidone). «Tra pochi giorni è il mio compleanno e l'unica cosa che mi viene in mente è che presto il Libano sarà finito, a meno che non accada un miracolo».
«Il disarmo non significa pace» sostiene Ali (nome di fantasia), commerciante sessantenne originario di Nabatiye. «Non si arriverà mai alla pace deponendo le armi davanti ad un aggressore che vuole apertamente la nostra distruzione. Il disarmo non sarebbe pace, ma suicidio nazionale. Israele ha occupato un terzo del Libano dal 1978 al 2000, ha tentato una nuova occupazione nel 2006 e dall'autunno scorso occupa territori al sud e viola quotidianamente la nostra sovranità con sorvoli e bombardamenti». Gli fa eco il compaesano Mohamed (nome di fantasia): «La storia dimostra che il disarmo non ha mai fermato l'aggressione israeliana, anzi. L'esercito regolare libanese, per volontà dell'Occidente alleato di Israele, è male equipaggiato e incapace di resistere ad una eventuale invasione. Solo un deterrente credibile come la Resistenza (portata avanti da Hezbollah, nda) impedisce a Israele di occupare l'intero Libano o di trasformarlo in una nuova Gaza. Se il Libano si disarma, Israele non ci lascerà in pace, come sostengono alcuni, ma ci sottometterà».
Nawal (nome di fantasia), quarantenne di Junie, è di un altro avviso: «Israele ha fatto sapere che non lascerà i territori che ha occupato al sud [vedi qui]: ebbene, diamoglieli. Meglio perdere un po' di territorio che veder morire ogni giorno un nostro connazionale centrato dai droni israeliani. Lo so che così viene sminuita la nostra sovranità, ma il Libano è da sempre al centro degli interessi altrui, meglio ammetterlo e limitare i danni in termini di vite umane».
Mentre l'opinione pubblica è monopolizzata dalla questione, in Libano si riscontra un trend in crescita di fenomeni inquietanti, sintomo della vulnerabilità di un popolo stremato da un quinquennio di crisi, povertà e guerre. Il sito della polizia registra un incremento di rapimenti, in particolare di donne e bambini, che richiama l'onda di sparizioni che negli ultimi mesi sta attraversando la Siria. Le forze dell'ordine indagano su una non improbabile matrice comune del fenomeno nei due Paesi levantini.
Frattanto, in Siria procede spedita la normalizzazione del governo di Hayat Tahrir al-Sham da parte del resto del mondo. L'autoproclamatosi presidente Ahmad al-Sharaa ha incontrato nelle scorse ore a Damasco alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti per discutere, a quanto si apprende, di cooperazione in campo economico e di questioni di sicurezza: insomma, business e nemici comuni. Mentre il Paese sprofonda nel caos e le minoranze religiose sono prede di milizie fuori controllo che in pochi mesi hanno eliminato migliaia di persone, la comunità internazionale si appresta ad investire in Siria in maniera massiccia. Si parla di progetti importanti, come la ricostruzione di interi quartieri di Damasco e la realizzazione di una metropolitana. Ciascun Paese investirà secondo i propri interessi strategici: come si apprende da investing.com, Turchia e Siria hanno firmato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa «sulla formazione e consulenza militare, a seguito dei colloqui ad Ankara tra i ministri della difesa di entrambi i Paesi».
Anche l'Italia, con apripista il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non rinuncerà alla propria fetta di torta; a questo proposito, una inchiesta di Luca Gambardella sul Foglio dà conto di una operazione italo-siriana tanto spregiudicata quanto, forse, paradigmatica di cosa significhi “fare affari con al-Sharaa”.
Delle elezioni, previste per metà settembre, che dovranno rinnovare il Parlamento siriano non si parla più, dopo l'annuncio del luglio scorso; del resto, un terzo dei parlamentari sarà scelto per chiamata diretta dallo stesso al-Sharaa, e i restanti due terzi saranno eletti tra candidati organici all'entourage di Hayat Tahrir al-Sham. Dunque, sembra improbabile che la tornata elettorale riveli sorprese. In politica estera le cose viaggiano più spedite: il sito americano Axios annuncia un incontro imminente a Parigi, dopo quelli del luglio scorso, tra il ministro israeliano degli affari strategici, Ron Dermer, il ministro siriano degli esteri, Asaad al-Shaibani, e l'inviato statunitense Tom Barrack.