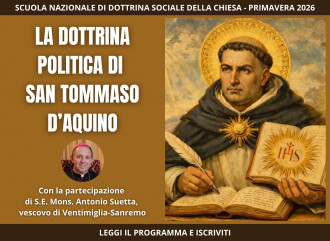Trump usa la minaccia di dazi come clava contro il Brasile di Lula
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trump minaccia dazi del 50% sulle importazioni dal Brasile. Un paese con cui la bilancia commerciale degli Usa è in attivo. Il motivo è il trattamento che il Brasile riserva all'ex presidente Bolsonaro e agli oppositori. Ma perché i dazi e non le sanzioni?

Negli Stati Uniti, l’agenda protezionista è tornata in primo piano. Il presidente Donald Trump, dopo una pausa di tre mesi, nei quali sono stati negoziati accordi commerciali, ha spedito lettere di minaccia di nuovi dazi che verranno applicati dal 1 agosto, se le richieste americane non dovessero essere soddisfatte. Molti governi sono rimasti esterrefatti per la missiva che hanno ricevuto, a partire da Giappone e Corea del Sud, da sempre partner commerciali, che rischiano di veder applicate tariffe del 25% alle loro esportazioni negli Usa. Ma uno in particolare è il paese che rischia di essere colpito dai dazi: il Brasile. Se tutto dovesse andar male, vedrà applicate tariffe del 50% sui suoi prodotti, le seconde più alte dopo la Cina.
Non è possibile valutare questi dazi solo come misure economiche, neppure a voler entrare nella stessa logica di Trump. Il presidente americano, infatti, ragionando in termini puramente mercantilistici, ritiene di essere danneggiato dai paesi con cui la bilancia commerciale statunitense è passiva. Quindi dove le importazioni sono superiori alle esportazioni, lì Trump mira a “riequilibrare” il mercato con dazi proporzionali al disavanzo commerciale. È questo il caso del 25% minacciato per il Giappone e la Corea del Sud. Paesi che ora si trovano in difficoltà a trovare un accordo realistico con gli Usa, dato che già vige un regime di libero scambio fra i sudcoreani e gli americani e per quanto riguarda il Giappone è “nazione favorita” da decenni.
Per il Brasile il discorso cambia ancora. Perché la bilancia commerciale è in attivo con il paese sudamericano: i brasiliani importano dagli Usa più di quanto esportino. Non per nulla, quando Trump aveva proclamato il “Liberation day” il 2 aprile scorso, il Brasile era soggetto ad un blando 10%. Cosa è cambiato? La politica. Un primo avvertimento, il presidente americano lo aveva lanciato il 7 luglio, all’indomani del vertice dei Brics di Rio de Janeiro, dove il Brasile è stato protagonista nel cercare di formare un blocco contro il G7 e soprattutto rivale degli Usa. Trump aveva minacciato un 10% di tariffe aggiuntive per tutti i paesi che avessero aderito al Brics o avessero intrapreso politiche filo-Brics. Poi è partita, sempre via lettera, la minaccia specifica al Brasile. Come si spiega però una possibilità di applicare dazi così alti?
Trump li sta usando come arma di pressione. Minaccia tariffe doganali, così come i suoi predecessori minacciavano o applicavano sanzioni economiche ai danni di nazioni ostili. Il Brasile è considerato da Trump come nazione ostile perché ha censurato X (reo di non aver oscurato i profili di politici di destra nel mirino della magistratura) e perché sta proseguendo la “caccia alle streghe” nei confronti dell’ex presidente di destra Jair Bolsonaro e dei suoi sostenitori.
Bolsonaro, presidente brasiliano dal 2019 al 2023, è stato sconfitto con elezioni combattute fino all’ultimo voto e dai contorni sorprendenti. Lula, all’inizio del mandato del suo acerrimo nemico, era ancora in carcere (per un’inchiesta di corruzione del suo Partito dei Lavoratori), e la magistratura lo ha scagionato e reso rieleggibile, giusto in tempo per il voto del 2022. La destra brasiliana è tuttora convinta che si sia trattato di un complotto, in cui la magistratura di sinistra ha svolto un ruolo centrale. Per questo, non accettando la vittoria del presidente di sinistra, l’8 gennaio 2023, i più estremisti fra i brasiliani di destra hanno dato l’assalto alle sedi del parlamento e della corte suprema, una riedizione di quel che era avvenuto al Campidoglio, dopo la sconfitta di Trump, il 6 gennaio 2021.
Trump, oltre ad essere un alleato storico di Bolsonaro, quando sia l’uno che l’altro erano presidenti dei rispettivi paesi, si immedesima nella sua vicenda. Anche l’ex presidente brasiliano e tutti i suoi sostenitori sospettati di aver partecipato ai fatti del 6 gennaio, sono stati processati e stanno subendo un ostracismo integrale, a partire dall’esclusione dai social media. Qui si inserisce anche la vicenda di X: il social network di Elon Musk, rifiutandosi di censurare i politici indicati dalla magistratura del Brasile, è stato chiuso, finché non ha accettato tutte le condizioni poste da Lula. Un caso unico in una democrazia occidentale di un governo che chiude un social network. Nella sua missiva, in cui annuncia i nuovi dazi, Trump denuncia sia la persecuzione subita dalla destra brasiliana, sia la censura sui social network americani.
Se la causa politica dell’ostilità verso il Brasile è comprensibile, molto meno lo è la scelta degli strumenti di lotta: perché i dazi e non le sanzioni? Perché uno strumento puramente commerciale e non politico? Trump pensa evidentemente che i dazi siano più efficaci, se si vuole intimidire un paese. Ed è convinto che comunque l'economia americana non ne risentirà. Così facendo, però, sta ancora una volta sfidando gli altri poteri americani: spetterebbe al Congresso decidere sulle tariffe doganali. Ancora una volta lo fa perché usa la carta dell’emergenza che assicurerebbe al governo la possibilità di intervenire a gamba tesa, senza passare dal Congresso. Ma è difficile pensare che il Brasile costituisca un'emergenza nazionale. Per cui anche questo caso finirà alla Corte Suprema, se privati danneggiati o oppositori democratici decidessero di far ricorso.
Le reazioni che i dazi potrebbero provocare nell’opinione pubblica del paese sudamericano non sono controllabili: Lula ha già sfoderato la sua retorica della difesa di un paese sovrano dall’imperialismo yankee e potrebbe avere successo. Ma quel che preoccupa di più è l’impatto di questi annunci, anche a lungo termine, sulla fiducia degli investitori nel sistema americano. Se non valgono più le vecchie regole del commercio e un presidente può cambiarle a piacimento, dall’oggi al domani, per motivi puramente politici, chi potrà ancora fidarsi degli Usa, di quelli che finora erano il perno del sistema economico globale?