I luoghi sacri dei primi cristiani, la testimonianza degli apologeti
Già i cristiani pre-Costantino avevano dei luoghi dedicati esclusivamente al culto. La conferma di questa realtà si può trovare negli scritti di apologeti, da Minucio Felice a Lattanzio. E anche nell’Editto di Gallieno, citato da Eusebio di Cesarea.
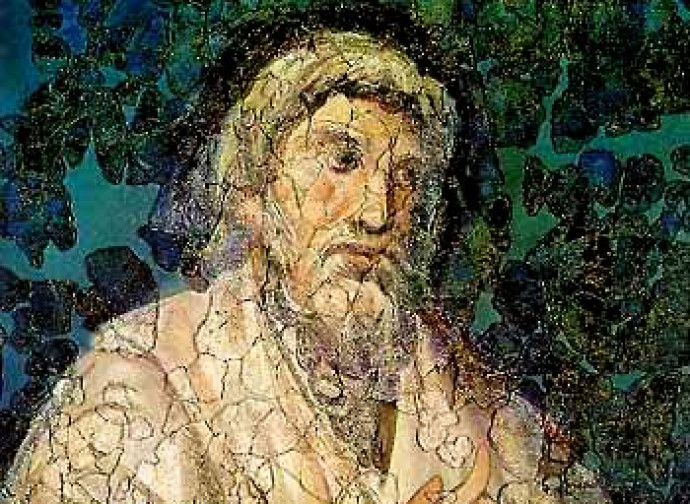
Nel precedente articolo, abbiamo visto come una certa interpretazione della spiritualizzazione del culto, e più in generale della religione, negli scritti dei Padri apologeti abbia condotto decisamente fuori strada. La comprensione spirituale del culto, dell’altare, del sacrificio non ha comportato l’abolizione del sostrato materiale, ma al contrario la sua comprensione più pura e profonda.
Che il termine ekklesìa significasse la convocazione dei fedeli rigenerati nel battesimo e riuniti per adorare il vero Dio in spirito e verità, non comporta che questo termine non connotasse anche un luogo ben preciso (talvolta denominato anche “casa di Dio”), dedicato in modo esclusivo al culto. Che i cristiani debbano offrire i propri corpi come sacrificio spirituale, vivente, santo e gradito a Dio (cf. Rm 12, 1) non significa che il cristianesimo dei primi secoli avesse abolito l’offerta materiale di oblate. Che il cristiano sia il tempio di Dio (cf. 1Cor 3, 16), non ha come conseguenza che si debbano abolire i templi sacri. E si potrebbe continuare.
Il contesto di polemica con i culti pagani, nel quale si collocano gran parte degli scritti degli Apologisti, fornisce una chiave di lettura estremamente importante e dev’essere ulteriormente preso in considerazione. L’Octavius di Marco Minucio Felice, scrittore cristiano della prima metà del III secolo, è spesso preso come esempio del fatto che i cristiani pre-costantiniani non avessero luoghi sacri, né statue, né altari. Nel dialogo, l’interlocutore pagano di Ottavio, Cecilio, domanda appunto all’amico, non senza polemica, perché mai i cristiani non abbiano come i pagani (e come i giudei), templi e altari; ma il senso di questa domanda non può prescindere da quanto chiede poco prima: «perché [i cristiani] non professano alla luce del sole?» (Octavius, X, 4). Anzi, essi «disprezzano i templi quasi fossero sepolcri, sputano sulle divinità, irridono i sacrifici» (VIII, 4).
Il senso dell’obiezione di Cecilio sta nel fatto che i cristiani disprezzano quanto caratterizza il paganesimo, e non hanno, come i pagani, delle cerimonie visibili da tutti, dei luoghi aperti come i loro templi. Ma, attenzione, egli afferma anche (cf. IX, 1-4) che le riunioni dei cristiani avvengono in sacraria taeterrima (santuari ripugnanti) che crescono in tutto il mondo; che le loro ceremoniæ, i loro sacrifici (sacra) sono così segreti da far pensare che essi immolino dei bambini sui loro altari (altaria). Come si può vedere, il pagano riconosce che anche i cristiani hanno in realtà i loro luoghi di culto, i loro altari e i loro sacrifici, che però sono “segreti” e ben differenti da quelli pagani. Non è dunque la testimonianza di chi nega in assoluto la presenza di santuari, altari e sacrifici, ma di chi ne fa notare la “stranezza”.
La risposta di Ottavio si fonda tutta sul fatto che Dio, creatore del mondo, non è contenuto in un tempio, che la sua immagine è impressa non in statue ma nell’uomo, che tutto quanto gli viene sacrificato è in realtà già suo; e tuttavia, ancora una volta, questo non significa che i cristiani non avessero per nulla santuari, sacrifici, altari. Si può pensare ad un’analogia con la polemica dei profeti nei confronti del culto nel Tempio di Gerusalemme. Le Sacre Scritture riportano i rimproveri vigorosi di Jahvè per bocca dei profeti, con Dio che ha quasi nausea dei sacrifici che gli vengono offerti; eppure le medesime Scritture attestano che è lo stesso Jahvè ad aver voluto l’edificazione del Tempio, gli altari e i sacrifici prescritti. È dunque evidente che la polemica dei profeti non era contro il culto o il Tempio in sé, e nemmeno contro l’osservanza dei dettagli con cui il Tempio era stato edificato o i sacrifici che venivano offerti. Il bersaglio è invece il fraintendimento del senso profondo del culto esterno, a causa di una condotta morale che va nella direzione opposta a quanto significato dai riti. La realtà significata non corrispondeva più al segno, ma andava nella direzione opposta.
Un’ulteriore conferma del fatto che i cristiani avevano i loro luoghi sacri e il loro culto sembra provenire anche dall’Editto di Gallieno (262 ca), che restituì ai cristiani i beni confiscati dal padre, l’imperatore Valeriano. Eusebio di Cesarea cita il rescritto che l’imperatore aveva inviato ai vescovi d’Egitto: «Ho ordinato che si espanda in tutto il mondo il beneficio della mia generosità, affinché siano riaperti i luoghi di culto e perciò anche voi potete avvalervi della disposizione del mio rescritto, in modo che nessuno vi molesti» (Storia Ecclesiastica, VII, 13). Il rescritto testifica sia che i cristiani avevano i propri «luoghi di culto», sia che questi luoghi non erano delle semplici stanze all’interno delle abitazioni, utilizzate per le assemblee religiose, perché non erano le case dei cristiani ad essere state confiscate, ma quei luoghi che dall’autorità erano riconoscibili come luoghi di culto. Sia Valeriano che li aveva confiscati, sia Gallieno che li aveva restituiti, riconoscevano pertanto la presenza di veri e propri luoghi sacri, utilizzati per il culto cristiano.
Ancora più chiaro è un passo tratto dal De mortibus persecutorum dell’apologeta romano Lattanzio († 325 ca), che in riferimento all’imperatore Costanzo I (250 ca - 306) scrive: «Quanto a Costanzo, non voleva apparire in disaccordo con gli ordini dei superiori. Così lasciò che si distruggessero i luoghi di riunione – cioè le mura –, che si possono ricostruire. Ma il vero tempio di Dio, che è negli uomini, lo conservò intatto» (XV, 7). Il testo non solo testifica ancora una volta la presenza di edifici in cui i cristiani si trovavano per il culto, ma mette in luce il modo corretto di approcciare queste testimonianze dei primi secoli della storia della Chiesa. Nella sua affermazione c’è infatti un assunto implicito, che manifesta il senso del simbolo: i luoghi sacri sono segno di una realtà spirituale; Costanzo aveva distrutto ciò che è segno (il luogo di culto), ma non aveva steso le mani su coloro di cui il luogo è segno (i cristiani). La spiritualizzazione che i cristiani avevano operato li aveva decisamente allontanati dal culto pagano, ma non aveva dissolto quegli elementi della religione che cadono sotto i sensi.
Cristo Giudice – Il testo del video
Il potere giudiziario è proprio di Cristo anzitutto perché è Dio, ma anche in virtù dell’unione ipostatica, della grazia capitale e dei suoi meriti. La conseguenza è che esso si estende a tutte le realtà umane (nessuna esclusa) e agli angeli. La forma del giudizio: la sapienza.
La spiritualizzazione del cristianesimo, una tendenza errata
C’è una tendenza a spiritualizzare il cristianesimo per la quale si rigetta la dimensione materiale, rituale, fisica quale residuo di una religiosità imperfetta. Ma questa è un’ideologia che comporta una comprensione errata del principio sacramentale e, in definitiva, dell’Incarnazione.
Una chiesa, un vescovo, un altare: la verità sui primi cristiani
Le testimonianze antiche ci parlano di un unico culto pubblico in ogni città, presieduto dal vescovo, in un edificio sacro, esclusivamente dedicato a questo scopo. Nessuna “chiesa domestica”, quindi, ma un’unica, ampia chiesa per celebrare l’Eucaristia.
Altari mobili = altari profani? Un’equazione sconfessata dalla storia
Gli altari mobili dei primi secoli cristiani non erano destinati a usi profani, come molti hanno ritenuto in epoca contemporanea. Essi erano trasportabili sia per proteggerli da eventuali profanazioni sia soprattutto perché erano legati al vescovo.


