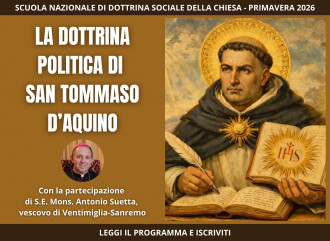«Detassare le madri sarebbe una svolta, ma servono molte risorse»
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il MEF studia una maxi detrazione per le madri lavoratrici. «Sarebbe un'alternativa al Quoziente famigliare, ma è interessante perché agirebbe sia sulla leva della natalità che su quella dell'occupazione femminile. Le risorse sono la grande incognita». Parla alla Bussola il docente di Politica Economica Rizzolli.

L’ipotesi del Governo è stata fatta circolare in questi giorni come indiscrezione: il MEF starebbe studiando una maxi-detrazione per le mamme lavoratrici che, partendo da 2.500 euro al primo figlio, salirebbe fino a 20mila euro con 4 figli. Si tratterebbe di una misura corposa per sostenere la Natalità attraverso l’incentivazione del lavoro femminile. Ma è anche un’ipotesi molto costosa ed è questo il primo scoglio che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si troverebbe ad affrontare: una valutazione sui fondi necessari, che al momento non ci sono. Specchietto per le allodole o inizio di una politica strutturale fiscale in chiave famigliare?
Lo scopriremo con le prossime notizie relative alla manovra 2026.
Intanto però il dibattito è aperto e la Bussola ne parla con Matteo Rizzolli (in foto), ordinario di Politica Economica alla Lumsa e docente di economia della famiglia al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia .
Professore, una corposa detrazione per le mamme lavoratrici. Sembra essere una proposta nuova…
Premesso che ancora stiamo parlando di cose che non ci sono, ma non è completamente nuova nel dibattito, era già affiorata. Certamente è nuova nel senso che a livello internazionale è stata praticata solo dall’Ungheria, ma la cosa interessante è che trova sostenitori trasversali anche di economisti con altro orientamento politico. 
In che misura possiamo parlare di un inizio di quoziente famigliare?
Direi che è un’alternativa, non sono compatibili. Il Quoziente Famigliare o il Fattore Famiglia guardano al nucleo famigliare come nucleo da tassare, non ai singoli individui. Qui si fa una distinzione precisa rispetto allo schema di famiglia classica e si guarda al reddito della mamma in maniera differente. Difficile iniziare con una misura di questo tipo e concludere poi col Quoziente Famigliare.
Se verranno confermati questi intenti quindi il QF si allontanerebbe?
Secondo me si, se davvero il Governo volesse percorrere questa strada dovrebbe dire che ha deciso di non percorrere la strada del Quoziente. Ciononostante, è una proposta ugualmente molto interessante.
Lei la sosterrebbe?
Io non mi immolo sugli schemi. Prendo atto che vorrebbe dire che c’è una strada che punta su un’idea precisa e cioè che c’è una correlazione positiva tra lavoro femminile e natalità, cosa peraltro che emerge dai dati in occidente: laddove la partecipazione femminile al mercato del lavoro è alta, c’è una fertilità più alta. La proposta di detassare il lavoro femminile quindi tenta di prendere due piccioni con una fava: da più soldi alle famiglie con figli e allo stesso tempo favorisce la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Entrambi i meccanismi dovrebbero smuovere positivamente la natalità. Incrocio le dita e speriamo che abbiamo ragione. Sul primo aspetto abbiamo una vasta evidenza che gli incentivi economici hanno un alquanto modesto, ma comunque positivo impatto sulla natalità, sul secondo aspetto dobbiamo aspettare e verificare che sia così.
Ma i numeri che trapelano sono molto alti: 2500 euro al primo figlio fino a un massimo di 20mila di detrazione al quarto. Molte donne che lavorano non avrebbero nemmeno la capienza fiscale necessaria…
È vero, sono numeri importanti, ma è solo con i numeri importanti che forse muoviamo la natalità. Non è con le limature sull’Isee o con qualche decina di euro in più o in meno che convinciamo davvero le persone a fare più figli. Ci vogliono numeri importanti. Per quanto riguarda il fatto che molte donne non avrebbero nemmeno la capienza fiscale necessaria, è proprio questo il punto: per molte donne diventerebbe estremamente attraente lavorare perché sarebbe sostanzialmente esentasse. Ma c’è un aspetto da decidere prima di tutto.
Quale?
Il Governo dovrebbe chiarire preliminarmente se vuole applicare questo regime per tutte le donne anche retroattivamente o solo per le scelte di natalità in futuro.
Cambia?
Cambia nei costi e negli effetti. Oggi le donne lavoratrici con quattro figli in Italia sono una rarità, quindi la spesa iniziale sarebbe bassa, ma se in prospettiva una famiglia sa che passando da 1 a 2 o da 2 a 3 figli avrebbe una detassazione importante, allora sarebbe una leva decisiva.
Però come si concilierebbe con l’Assegno unico che invece tiene conto del reddito di tutta la famiglia?
E qui veniamo a uno degli ostacoli da risolvere: io sono diventato nel tempo uno scettico dell’assegno, ma ero un suo grande sostenitore, ne ho visto i limiti nella sua natura paternalistica perché lo Stato ti consegna questo assegno come politica di assistenza. Invece questa norma, che è una norma fiscale, è molto meno paternalista dal punto di vista simbolico perché riconosce il ruolo della famiglia prima del prelievo. Lo Stato fa un passo indietro rispetto alla tassazione perché riconosce alla famiglia un ruolo fondamentale nella natalità.
E quindi come si concilierebbe?
Si potrebbe dare alle famiglie la possibilità di decidere a quale regime accedere, oppure prevedere l’Assegno solo per alcune tipologie di famiglie in stato di bisogno. In una situazione ideale immagino la convivenza di entrambi gli strumenti: maxi-detrazione fiscale per le famiglie capienti e Assegno per le famiglie incapienti e bisognose come in Germania e in Francia. In Francia la leva fiscale è quella del quoziente famigliare, ma accanto c’è comunque un regime di assegni che aiuta quelli che rimangono incapienti o per i quali la leva fiscale non funziona. Stessa cosa accade in Germania dove invece del quoziente usano lo splitting combinato con le detrazioni per i figli. Se si arrivasse ad un sistema misto fatto di una generosa leva fiscale e un assegno solo per i casi di assistenza avremmo fatto la rivoluzione delle politiche famigliari in Italia.
A proposito di Francia, il quoziente però funziona e forse è meglio nel complesso famiglia…
La Francia ha scelto la leva fiscale su base famigliare. Sarebbe interessante cercare di capire perché l’Italia sembra orientata a scegliere una leva fiscale diversa. Non lo so, ma posso dire che in Italia si è parlato per molto tempo di quoziente, ma il discorso non ha mai attecchito anche per colpa di un pregiudizio.
Quale?
Ad esempio, si dice che per come funziona, il quoziente agevola i ricchi. L’argomento è il seguente: quando si calcola l’aliquota con il quoziente e la si confronta con quella di una famiglia di pari reddito senza figli, l’aliquota rimane più bassa. Quindi, nonostante si mantenga la progressività della tassazione, il vantaggio fiscale in termini assoluti cresce. Ora, in Italia c’è chi dice che questo agevola i ricchi, ma non è così, non è vero. Il dibattito italiano purtroppo è permeato di questa lente assistenzialista verso la famiglia per cui è del tutto normale per noi che l’assegno unico abbia un fortissimo decalage e sia generoso con le famiglie povere mentre si riduca ad una somma risibile di 50€ per figlio per le famiglie appena benestanti. Nel dibattito italiano questo è normalissimo, ma nessuna delle norme pro famiglia in Europa è fatta così. Tipicamente le misure sono piatte (una somma fissa per ciascun figlio indipendentemente dal reddito dei genitori), oppure come nel caso francese, addirittura, il QF “si permette” di aumentare via via che aumentano i redditi. Inaudito per il dibattito italiano che ragiona in termini assistenziali.
Se è per questo in Italia abbiamo anche l’esclusione del figlio post maggiorenne dall’Assegno, che a 21 anni, anche se è ancora nel nucleo famigliare, viene escluso…
E’ vero anche che abbiamo il problema a invogliare i giovani a uscire dalla famiglia. Io ritengo che sia legittimo e auspicabile che la titolarità dell’Assegno passi direttamente al ragazzo: se l’assegno fosse piatto e non determinato dall’Isee dei genitori, i 250 euro al mese (cifra auspicata all’inizio, ma mai raggiunta ndr.) li diamo al ragazzo che può utilizzarli per rendersi indipendente. Questo non sarebbe paternalistico.