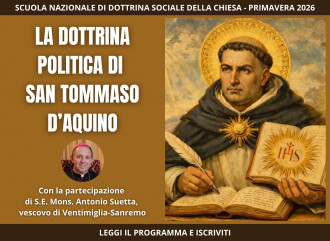Conceição e i gesti antisportivi, si dica basta
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il mister del Milan che rifiuta di indossare la medaglia d'argento dopo la sconfitta in Coppa Italia è il risultato di un ambiente sempre più avvelenato, in cui il tifo lascia spazio all’odio, il confronto sportivo si trasforma in guerra verbale, e la passione degenera in fanatismo.

Lo sport, che da sempre dovrebbe essere espressione di lealtà, rispetto reciproco, fair play e sana competizione, sembra aver smarrito progressivamente la sua essenza originaria, cedendo il passo a una spirale di comportamenti antisportivi, atteggiamenti aggressivi e tensioni crescenti che si manifestano tanto sul campo quanto fuori, negli stadi, nei palazzetti e perfino negli studi televisivi.
Un panorama desolante, in cui episodi di maleducazione, scarsa sportività e veri e propri gesti di sfida diventano sempre più frequenti, normalizzati e, cosa ancor più grave, spesso giustificati o minimizzati da chi dovrebbe invece rappresentare modelli positivi. L’ultimo episodio in ordine cronologico è avvenuto mercoledì sera, e ha visto protagonista l’allenatore del Milan, il portoghese Sergio Conceição, che al termine della finale di Coppa Italia persa allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna non si è fatto mettere al collo la medaglia d’argento della competizione e l’ha tenuta in mano. Inoltre, ha evitato di dare la mano ai calciatori del Bologna in fila al momento della premiazione, al contrario dei suoi calciatori che si complimentavano con gli avversari.
Un comportamento che non può essere archiviato come un semplice scatto d’orgoglio o una reazione a caldo, ma che rappresenta invece un chiaro sintomo del progressivo deterioramento dei valori sportivi che dovrebbe guidare ogni attore coinvolto nel mondo dello sport.
E se è vero che episodi simili si sono verificati anche all’estero, come ad esempio in Inghilterra in occasione di alcune finali sentite o partite molto tese, è in Italia che questi atteggiamenti sembrano trovare terreno particolarmente fertile, diventando quasi la norma in determinati ambienti. Non è raro assistere a sceneggiate plateali da parte di calciatori che si lasciano cadere a terra simulando falli inesistenti, rotolandosi con eccessiva enfasi per ingannare gli arbitri e ottenere calci di rigore, espulsioni o semplicemente vantaggi tattici. Tali comportamenti, oltre a svilire lo sport in sé, alimentano una cultura della furbizia e del sotterfugio, che va in netta contrapposizione con i principi fondanti dello sport stesso. Il problema è che questo modo di agire non si limita al campo di gioco: si insinua anche nella narrazione sportiva, nei commenti post-partita, nelle discussioni televisive, dove spesso i giornalisti, invece di contribuire a una lettura equilibrata e distesa degli eventi, preferiscono gettare benzina sul fuoco, amplificando polemiche, insinuazioni e contrasti.
Il risultato è un ambiente sempre più avvelenato, in cui il tifo lascia spazio all’odio, il confronto sportivo si trasforma in guerra verbale, e la passione degenera in fanatismo. I talk show sportivi sono diventati palcoscenici di urla, accuse reciproche, interruzioni continue e attacchi personali, con ospiti che si esibiscono più per aumentare gli ascolti che per offrire analisi competenti. Peraltro anche i conduttori, soprattutto se giornalisti, dovrebbero apertamente prendere le distanze da simili atteggiamenti, nel rispetto della loro deontologia professionale.
È un circolo vizioso: gli atteggiamenti scorretti dei protagonisti in campo vengono amplificati e normalizzati dai media, che li trasformano in spunti per l’indignazione collettiva o per l’ennesimo teatrino televisivo, e ciò finisce per legittimare questi comportamenti anche tra i tifosi, soprattutto quelli più giovani, i quali interiorizzano una concezione distorta dello sport.
I gesti come quello di Sergio Conceição non sono dunque episodi isolati ma si inseriscono in un contesto più ampio e pericoloso: quello della perdita del rispetto, del senso della misura e dell’onore sportivo. Rifiutare la medaglia del secondo classificato non è solo mancare di rispetto agli avversari, ma anche al proprio gruppo, ai propri tifosi, e più in generale all’idea stessa che una sconfitta, se onorata con dignità, può essere altrettanto importante di una vittoria. La storia dello sport è piena di esempi di atleti e allenatori che hanno saputo accettare la sconfitta con classe e che proprio per questo sono rimasti nella memoria collettiva come figure esemplari.
Oggi, invece, si ha spesso l’impressione che la sportività venga vista come una debolezza, che il rispetto venga considerato un optional e che solo chi urla di più, chi si lamenta per primo o chi inscena il gesto più clamoroso ottenga attenzione. In questo contesto, la figura dell’arbitro è diventata bersaglio costante e ingiustificato. L’arbitro, che dovrebbe rappresentare la figura super partes, è ormai sistematicamente delegittimato, messo sotto accusa, contestato ancora prima che il fischio iniziale risuoni. Gli allenatori fomentano le polemiche, i giocatori protestano su ogni decisione, i dirigenti rilasciano dichiarazioni infuocate e i giornalisti costruiscono narrazioni polarizzanti che alimentano una tensione continua. Si parla spesso di VAR, di errori arbitrali, di moviole e frame al rallentatore, come se il risultato sportivo dipendesse unicamente da una chiamata dubbia e non da tutto ciò che una squadra mostra sul campo.
In tutto questo i giovani, che dovrebbero ispirarsi ai protagonisti del grande calcio per imparare i veri valori dello sport, si trovano invece a emulare atteggiamenti scorretti, esultanze provocatorie, proteste plateali, mancanze di rispetto. Il degrado non è solo tecnico o tattico: è prima di tutto etico. Ed è un degrado che parte dall’alto, dalle figure che dovrebbero essere guida e modello, e che invece troppo spesso preferiscono l’ego, l’immagine, la costruzione del personaggio alla sobrietà, all’equilibrio e al senso del dovere.
La responsabilità è diffusa: tocca ai dirigenti che non sanzionano i comportamenti sbagliati, ai giornalisti che speculano sulle polemiche, agli opinionisti che cercano il titolo ad effetto, ai tifosi che giustificano tutto in nome del tifo, agli atleti che dimenticano cosa significhi essere un esempio.
È doveroso iniziare una riflessione profonda e collettiva sul senso dello sport oggi, partendo proprio da quei gesti che sembrano piccoli ma che in realtà sono rivelatori di un clima generale: il rifiuto della medaglia, l’insulto all’arbitro, la simulazione in area, l’intervista polemica, il silenzio stampa usato come arma, la conferenza stampa usata come sfogo personale. È da lì che bisogna ripartire per ricostruire un’idea di sport che non sia solo spettacolo e business, ma anche educazione, rispetto e cultura. Perché se lo sport perde la sua funzione educativa, allora resta solo un’arena in cui vince chi grida più forte e perde chi ha ancora il coraggio di rispettare le regole.