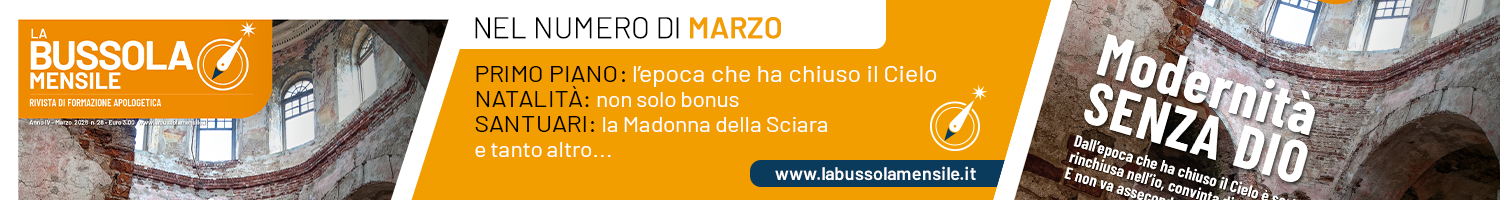11 settembre, 22 anni dopo in Africa il jihadismo è vivo e attivo
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Africa è il continente in cui Al Qaeda ha fatto proseliti, prima che bin Laden si trasferisse dal Sudan all'Afghanistan. Ed è in Africa che ha compiuto i primi mega-attentati a Nairobi e Dar es Salaam. Ventidue anni dopo l'11 settembre, il jihadismo infesta una ventina di Paesi africani.

Ancora una volta, ieri 11 settembre, gli Stati Uniti e gran parte del mondo hanno ricordato gli attentati che 22 anni fa hanno cambiato la storia. I tre aerei che hanno colpito le Torri gemelle e il Pentagono e quello che i passeggeri hanno fatto precipitare in Pennsylvania per evitare che raggiungesse il bersaglio – forse la Casa Bianca o il Congresso – erano pilotati da uomini di al Qaeda, il gruppo armato jihadista fondato nel 1988 da Osama bin Laden.
All’epoca bin Laden guidava la sua organizzazione terroristica dall’Afghanistan, ospitato dai talebani. Ma fino al 1996 la sua base operativa era il Sudan che lo aveva accolto per volontà di Hassan al-Tourabi, l’influente leader fondamentalista islamico che chiamava gli Stati Uniti “l’incarnazione del demonio”. Dal Sudan bin Laden aveva iniziato a reclutare in Africa, soprattutto nei paesi del Sahel ma non solo, uomini disposti a combattere la guerra santa, finanziando la costituzione di cellule dormienti e operative. Il 7 agosto è stato un altro anniversario, il 25°, degli attentati dinamitardi alle ambasciate Usa di Nairobi, in Kenya, e di Dar es Salaam, in Tanzania, nei quali persero la vita centinaia di persone.
Anche dopo aver lasciato il Sudan, bin Laden aveva continuato ad arruolare combattenti in Africa e, approfittando dell’inerzia dei governi, della corruzione, della facilità di superare le frontiere nazionali, si era impegnato nella creazione di reti transnazionali di cellule. Al Qaeda non è nato in Africa, ma è in quel continente che ha trovato le condizioni favorevoli per insediarsi, proliferare, imporre il proprio controllo e la propria legge su estensioni anche vaste di territorio e compiere migliaia di attentati e attacchi terroristici.
Dopo l’11 settembre gli Stati Uniti hanno provato a contrastare la diffusione del jihad in Africa. Hanno negoziato l’installazione di nuove basi militari in punti strategici del continente e il consolidamento di quelle esistenti, hanno realizzato programmi miliardari di aiuti allo sviluppo e hanno quasi subito avviato due progetti, il Pan Sahel Initiative, destinato a Chad, Mali, Mauritania e Niger, e l’East Africa Counterterrorism Initiative, rivolto a Kenya, Tanzania, Uganda, Etiopia, Eritrea e Gibuti, entrambi con la missione di fornire ai governi africani addestramento militare, armi, mezzi di trasporto e di comunicazione per combattere le attività terroristiche e per prevenirle con sistemi di controllo dei movimenti di persone e beni alle frontiere e nei territori incustoditi dalle autorità governative. Negli anni successivi sono intervenuti l’Unione Europea e alcuni Stati europei, la Francia in particolare nelle ex colonie, inviando missioni militari composte da soldati europei e dando sostegno finanziario, logistico e tecnologico ad alcune forze regionali, come quella creata da Nigeria, Ciad, Benin, Mali e Niger per combattere il gruppo jihadista nigeriano Boko Haram. Le Nazioni Unite a loro volta sono intervenute con missioni di peacekeeping.
A distanza di 22 anni, il bilancio è deludente. Sicuramente la presenza di forze militari internazionali in alcuni stati, l’assistenza militare e finanziaria offerta ad altri sono servite a contenere la diffusione e la violenza dei gruppi jihadisti. Il Mali forse non esisterebbe neanche più come Stato se a partire dal 2012, quando i jihadisti hanno occupato tutto il nord approfittando di un golpe militare, non fossero intervenute la Francia con le missioni Serval e Barkhane, poi la forza europea congiunta Takuba, alla quale ha partecipato anche l’Italia, e la missione di peacekeeping Onu Minusma. Ma i Paesi africani coinvolti in qualche misura nel jihad sono ormai una ventina, su un totale di 54: tanti quelli colpiti da attentati (Senegal, Kenya, Tunisia, Uganda…) e anche tanti, sempre di più, quelli in cui dei gruppi jihadisti sono riusciti a insediarsi: Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Somalia, Repubblica democratica del Congo, Mozambico...
Dal 2016 inoltre anche l’Isis, lo Stato Islamico, è riuscito a penetrare nel continente. L’allora leader del Califfato, Abu Bakr al-Baghdadi, aveva deciso di spostare parte dei propri combattenti e delle proprie risorse in Africa e di fare del continente il teatro delle sue principali operazioni. Ne aveva annunciato l’intenzione con un video intitolato Dalla terra dell’Iraq ai leoni dell’Africa. È riuscito nell’intento, tanti hanno risposto all’appello a unirsi a Califfato. Boko Haram, in Nigeria, affiliato ad al Qaeda, si è addirittura diviso e nel 2016 è nato l’Iswap, la Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico, che opera nell’area del lago Chad dove ha creato una vera e propria zona di “jihad governance”, imposta, ma anche accettata dalla popolazione abbandonata a se stessa, priva di servizi e infrastrutture e lasciata alla mercé di bande criminali che agiscono incontrastate. L’Iswap offre agli abitanti della regione più di quanto ricevano dalle strutture di parentela e dai rispettivi governi. Protegge dai furti di bestiame, costruisce pozzi, garantisce quel tanto di ordine e sicurezza necessari perché la gente possa lavorare e condurre una vita sociale, assicura persino dei servizi sanitari di base.
Succede anche altrove e questo fa riflettere sulle cause della proliferazione di gruppi jihadisti in Africa nonostante decenni di impegno internazionale. I governi africani ne favoriscono la diffusione e il radicamento perché sono inefficienti, corrotti, brutali nel reprimere il dissenso, perché fanno mancare ai cittadini infrastrutture, servizi di base e tutele essenziali, perché non creano opportunità e prospettive, soprattutto per i giovani. “È tempo di rivedere il ruolo della comunità internazione in contesti simili e di ammetterne i limiti – spiegava l’Ird, un Istituto di ricerche per lo sviluppo, dopo l’annuncio della Francia, lo scorso anno, di porre fine alle proprie missioni in Mali, seguita poi dagli altri stati europei – oggi il successo della lotta al terrorismo dipende prima di tutto dalla volontà, più ancora che dalla capacità, dei leader politici africani di stipulare un nuovo contratto sociale con i loro connazionali”. Senza questo, ogni impegno esterno può solo contenere i danni e in definitiva fallire.