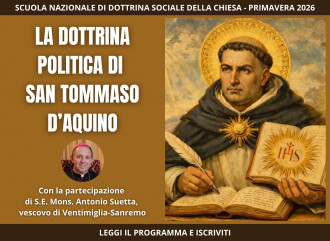L’uomo moderno, da educare alla liturgia
Si dice che l’uomo moderno non è più capace di liturgia, ma questa idea non tiene conto dell’apporto di una sana educazione religiosa. La capacità liturgica deve essere comunicata, risvegliata, promossa e guidata, così da trasmettere il senso e la bellezza del culto di Dio.

Ida Friederike Görres (1901-1971) è stata un’acuta scrittrice cattolica, sensibile e reattiva di fronte alle rivoluzioni che hanno scosso la Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. Di fronte ai deliri teologici, liturgici e disciplinari, Ida Görres ha saputo custodire la lucidità nel giudicare, alimentare la fortezza nel reagire, esprimere saggezza nel prendere posizione. Proponiamo un suo scritto del 1966 (rilanciato da One Peter Five) sull’uomo moderno capace di liturgia. Con troppa frequenza si sente affermare che l’uomo moderno non è più capace di liturgia, perché travolto da una mentalità tecnico-scientifica assolutista. L’affermazione non è priva di verità, ma rimane il fatto che la capacità liturgica, come può essere dissolta, può e dev’essere alacremente coltivata e trasmessa. La soluzione non sta nel cambiare la liturgia per venire incontro all’uomo “post-liturgico”, ma tornare ad educare l’uomo alla liturgia. (L.S.)
L’uomo moderno è capace di liturgia?
I.
[…] Preferirei formulare la domanda in questo modo: quando l'uomo moderno ha una capacità liturgica?
La prova che le persone oggi possiedono questa capacità è, a mio avviso, sufficientemente dimostrata dalla Chiesa nel blocco orientale. Vescovi, sacerdoti e laici di quell’area riferiscono all'unanimità come la liturgia sia letteralmente «ciò di cui la gente vive», ciò che unisce, sostiene, plasma e nutre la comunità. «Da lì, si può ora vivere per un altro anno», diceva un operaio al vescovo Otto Spülbeck dopo la celebrazione della Veglia pasquale [...].
Dal poco che si sa della “Chiesa del silenzio”, sembra che anche la liturgia completamente non riformata, interamente in latino, ancora sovraccarica da tutto ciò che qui è stato meticolosamente scacciato, rappresenti una vera forza, nel mezzo del governo autocratico di una civiltà tecnocratica e religiosamente ostile e coercitiva.
Nel nostro Paese, le persone sembrano mostrare una immutata capacità di esperienze e attività comunitarie, anche in occasione di eventi sociali, sportivi e politici, che sarebbe almeno un requisito psicologico e sociologico minimo per vivere pienamente la liturgia.
II. Quando una persona è capace di liturgia?
1. Quando considera il culto di Dio come una componente essenziale, necessaria, insostituibile e centrale della sua fede e della sua esistenza religiosa: importante almeno quanto il servizio agli altri.
2. Quando considera l'adorazione di Dio non solo come un bisogno privato, ma piuttosto come un dovere della comunità dei credenti; quindi, non per mera convinzione personale e interiorità, ma piuttosto come un atto traducibile in parole, gesti e simboli.
3. Quando è disposta a esercitare questa adorazione comunitaria secondo il rituale della Chiesa.
4. Quando comprende e accetta che questo culto, personale e collettivo, richiede un linguaggio espressivo adeguato al soggetto in parole e gesti, comprensibile e psicologicamente attuabile; quando comprende e accetta che proprio per questo motivo non può dipendere da idee spontanee e stati d'animo personali, ma deve essere ordinato, vincolante e allo stesso tempo suscettibile di elementi variabili, cioè mutevole e adattabile, ma impermeabile all'arbitrarietà e agli espedienti.
5. Quando accetta e riconosce un officiante e una guida del rituale competente e responsabile ed è pronta a sottomettervisi.
6. Quando comprende la comunità che prega e offre il sacrificio non solo geograficamente in quanto comunità riunita localmente, come temporanea [...] – e forse anche limitata a una fascia d'età o alla mentalità di un gruppo il cui gusto deve dominare – ma come l'intera Chiesa del mondo e come la Chiesa storica, da Cristo ad oggi, cioè “di molte epoche” e tuttavia identica alla Chiesa stessa.
7. Quando è pronto e disposto a riconoscere e accettare il suo legame con questa Chiesa anche nella liturgia e a sentirsi solidale con essa, cioè a portare avanti ciò che è stato tramandato dal passato come una vincolante eredità e come qualcosa che costruisce un ponte verso il futuro di questa Chiesa, a trasmetterlo a mani fidate, con sviluppi organici laddove è significativo e necessario farli.
8. Quando ha un rapporto religioso con la Sacra Scrittura come rapporto con la Parola di Dio e con le interpretazioni e spiegazioni maturate nel corso della vita della Chiesa, come un tesoro spirituale che valuta in relazione al tutto e vuole nutrire dal tutto.
III. Una persona non ha capacità liturgica:
1. Quando considera il culto di Dio come un cimelio della storia religiosa ormai superata, nella migliore delle ipotesi come un ornamento marginale della vera vita di fede, che consiste esclusivamente ed essenzialmente nel servire gli altri.
2. Quando essa stessa pratica il culto di Dio solo occasionalmente, a sua discrezione, secondo il suo umore soggettivo e le sue motivazioni del momento, e rivendica questa libertà anche per tutte le altre persone.
3. Quando le sembra impossibile e fondamentalmente inaccettabile unirsi ad altri, se non a piccoli gruppi di persone che la pensano esattamente come lei e hanno un’indole simile alla sua.
4. Quando inoltre ritiene che il rituale, se proprio deve esserci, debba essere modellato il più possibile secondo le idee spontanee e i suggerimenti individuali del celebrante o dei singoli fedeli, e che la liturgia, se proprio deve esserci, debba essere una sperimentazione perpetua.
5. Quando non riesce a immaginare un officiante legittimo e rubriche obbligatorie, e disprezza quelle esistenti perché non valide per lui.
6. Quando pensa alla “chiesa” solo come a qualcosa “appartenente a un'epoca”, cioè che riguarda solo la sua generazione, e non vuole conoscere o rifiuta i legami storici, o li tratta in modo eclettico e puramente privato, per esempio, decidendo che un certo momento storico è l'unico modello vincolante.
7. Quando considera il rituale in generale come un retaggio della storia religiosa e quindi rifiuta i giorni sacri (domeniche, festività, l'anno liturgico!), gli spazi sacri (santuario, altare, tabernacolo), così come le tradizioni e le pratiche quasi fossero fossili incantati.
8. Quando per lei le Sacre Scritture non sono più “sacre” in senso teologico, ma piuttosto un testo letterario da trattare puramente in termini di filologia, cultura e storia. Dopo tutto, perché le persone normali dovrebbero riunirsi appositamente per ascoltare o leggere ad alta voce testi che fondamentalmente le riguardano tanto quanto i cantici babilonesi o gli inni egizi al sole?
IV.
Nessuno di questi fattori è innato, ma viene insegnato; si tratta di una “comunicazione”, non di un'attitudine. […] La capacità liturgica deve essere comunicata, risvegliata, promossa e guidata, in particolare nei suoi presupposti, altrimenti tale capacità diviene per sua natura manchevole o si atrofizza.
Nel periodo in cui la “liturgia” era mediamente trascurata, calcificata, corrotta da inutili incrostazioni, spesso era difficile risvegliarla, impossibile coltivarla e tutt’al più alterarla, come dimostra il decadimento di quel tempo, nonostante lo spirito pre-tecnico e tradizionale dell'epoca. Il quarto punto, solitamente anche l'ottavo, era assente, atrofizzato o soppresso.
Tuttavia, quando quelle persone incontravano la realtà della liturgia autentica, sentivano molto rapidamente che essa parlava loro e che avevano “la capacità di rispondere”. Penso che anche oggi sia così. Il clima del nostro tempo è certamente sfavorevole a tali sviluppi, ma non sarebbe un problema insormontabile se si reagisse all'interno della Chiesa. Ma è proprio qui che c'è una mancanza. Perché il vero ostacolo della nostra epoca è l'opposizione alla tradizione; spesso non si tratta di un'atmosfera inconscia o di un semplice epifenomeno, ma piuttosto di una volontà fondamentale focosa e deliberata. [...]
Mi sembra che gli elementi del secondo gruppo si applichino oggi molto più ai teologi e al clero che ai “fedeli”; oppure, quando troviamo questi criteri tra i laici, sembra che a loro siano stati inculcati principalmente dai teologi. Questo atteggiamento, tuttavia, non mi sembra mai nascere spontaneamente dallo spirito tecnico-industriale del tempo, ma sembra piuttosto chiaramente consistere in “posizioni di opposizione” intra-ecclesiali, un mix di proteste fin troppo comprensibili, punto per punto, contro l'eccessiva spinta di certe posizioni tradizionali, insopportabilmente eccessive. Ma il povero laico è ora diventato il campo di battaglia e il soggetto di sperimentazione che i teologi usano per dare sfogo alle loro lotte contro il proprio passato irrisolto. [...]
Per sottolineare solo un aspetto: quando alcuni sacerdoti tentano di instillare nel laico un disprezzo di fondo e totale per la maggior parte dei dettagli del nostro passato ecclesiale, una sfiducia di fondo, una disponibilità sostanziale a deridere, a trovare il più possibile stupido, ridicolo e degno di essere rinnegato quanto è stato tramandato […], allora cosa dovrebbe fare con la liturgia, in qualunque forma essa sia, una persona istruita e guidata in questo modo? Le è impossibile arrivare incontrare il “materiale” con apertura, fiducia e disponibilità ad imparare.
In tal caso, mi sembra che la capacità liturgica sia semplicemente distrutta. Ma ciò non avviene dall'esterno, a causa dell'era tecnologica, bensì dall'interno, attraverso il sacerdote stesso, che fallisce a causa dell'incertezza e della scissione interiore, allorché si trova di fronte al compito di trasmettere la tradizione.
Analogamente, quando i sacerdoti insistono sul desiderio ben intenzionato, comprensibile e giustificabile di riparare precedenti insostenibili pretese clericali basate sullo status, al punto da distruggere la comprensione dottrinale tradizionale del sacerdozio per qualcosa di “magico” e non cristiano, non la sostituiscono con una comprensione oggettivamente approfondita e purificata, ma piuttosto con una mera figura funzionale.
V.
Il rapporto dei fedeli con la liturgia dipende in larga misura e in modo determinante dal comportamento del celebrante. Non si può non rimanere profondamente sorpresi dal fatto che la ben nota sciatteria, apatia e freddezza nella celebrazione della Messa, la mancanza di riverenza e di carità, spesso al punto da rendere la cerimonia quasi del tutto incomprensibile, non abbiano allontanato molti più fedeli dalla Chiesa nel corso di molti decenni: così anche oggi, le riforme liturgiche meglio intenzionate e potenzialmente più fruttuose sono efficaci solo se, prima di tutto, i sacerdoti le attuano dall'interno. Anche le nuove forme possono essere celebrate in modo superficiale, distratto, freddo, meccanico, irriverente, pomposo e teatrale, e allora la situazione del fedele è persino peggiore di prima: mentre durante la Messa silenziosa poteva almeno raccogliersi e aiutare sé stesso, le chiacchiere disordinate e indisciplinate della comunità, la gara tra il celebrante e il popolo per dire la propria, il frastuono dell'altoparlante, gli rendono impossibile farlo. Anche una persona che ha assolutamente la capacità e il desiderio di partecipare alla liturgia può essere dolorosamente scoraggiata da qualsiasi partecipazione, proprio come prima della riforma da altre assurdità. [...]