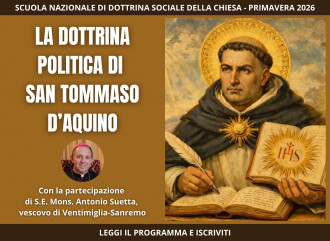Chiese brutte? «Perché è cambiata la funzione della chiesa»
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Se le chiese di oggi finanziate dall'8 per mille sono brutte, è perché la fede che si genera in questi edifici per il culto è innervata dagli interessi momentanei, dalla disaffezione e dalla non appartenenza. Incarnano la rinuncia alla conversione, alla dottrina, al timor di Dio». Intervista all'architetto Andrea Pacciani.

Tempo di dichiarazione dei redditi e tempo di spot della Conferenza episcopale italiana che questua il nostro 8 X mille. Ma dove vanno a finire i soldi dei contribuenti cattolici? Tre sono le voci principali di spesa: le esigenze di culto e pastorale; gli interventi caritativi; il sostentamento del clero. Mettiamo sotto il microscopio la voce “esigenze di culto e pastorale”. Secondo il Rendiconto ufficiale in merito all’anno 2024 il 63,2% dei finanziamenti è stato destinato al restauro degli edifici di culto. Il 25,1% alla costruzione delle nuove chiese. Annotiamo, come ricorda il Rendiconto, che «la CEI interviene con un contributo massimo del 75% della spesa preventivata (70% per gli interventi sugli edifici esistenti)». Dunque le diocesi ci devono mettere del loro per il restauro degli edifici e per la costruzione di nuovi edifici di culto.
Fermiamo la nostra attenzione proprio sulle nuove chiese che al cattolico della Domenica sono costate nel 2024 ben 32.250.000 euro. Non vogliamo qui domandarci se la costruzione di questi nuovi edifici fosse necessaria, visto l’inverno demografico che da anni ha colpito i fedeli praticanti, ma vogliamo domandarci: sono belle o brutte queste chiese? In altri e più precisi termini: sono adeguate ad esprimere il culto dovuto a Dio?
Giriamo le domande all’architetto e designer Andrea Pacciani, vincitore di diversi premi internazionali legati all’architettura classica con predilezione per l’estetica palladiana. Tanto per inquadrare il personaggio, diciamo che l’architettura contemporanea o sperimentale sta all’architetto Pacciani come Al-Qaeda sta alla pace nel mondo.
È esperienza condivisa che le chiese post conciliari, nella maggior parte dei casi, oscillino nell’associazione di pensiero collettiva tra le fabbriche e gli hangar, tra i magazzini e gli opifici. Che Dio ci condoni per queste brutture. Da qui la domanda quasi banale: perché sono così orribili?
Le nostre chiese antiche hanno il difetto di essere troppo belle, dei capolavori artistici assoluti oltre che oggetti architettonici funzionali al culto, e nel XX secolo si decise di abbandonare il modello costruttivo fin ad allora seguito a favore di una architettura contemporanea. Il discrimen forse nasce da lì. Così, purtroppo, all'architettura sacra in epoca moderna si sono fatte perdere le sue funzioni strumentali principali, un po' come è avvenuto per l'arte in genere, con la speranza o la consapevole ingenuità che altri mezzi avrebbero portato gli stessi o migliori risultati rispetto a quelli raggiunti e garantiti dai precedenti storici. Se, per l'arte in generale, il passaggio dall'arte figurativa a quella astratta, e quindi l'abbandono della funzione divulgativa, di informazione e testimoniale dell'arte, avveniva nella consapevolezza del sicuro prossimo successo di fotografia e cinema, in architettura sacra si faceva lo stesso passaggio – un salto nel vuoto – inseguendo gli slanci estetici di successo nell'arte in genere, pensando che le funzioni di contemplazione, conversione, santità e testimonianza avrebbero trovato luogo comunque nell'astrazione figurativa delle chiese moderne. La luce, strumento compositivo dell'architettura moderna, si è ingenuamente associata alla luce divina, all'illuminazione del cammino della chiamata e della conversione. Per fare una battuta, abbiamo inventato le chiese metereopatiche!
Mi tocca sottolineare come quest'errore grossolano non lo hanno invece compiuto le altre religioni monoteiste come l'islam e il buddismo che, anche nelle città più spinte nella architettura sperimentale contemporanea, hanno continuato a costruire i loro templi religiosi nell'ermeneutica della loro continuità estetica e funzionale nella certezza del loro risultato di successo spirituale garantito dalla storia della loro religione. Il risultato di quasi un secolo di architettura sacra sperimentale è aimè quello di edifici in cui, non solo non si riesce ad individuare spesso l’entrata, ma non riesce neanche ad entrarci Gesù Cristo! Figuriamoci i fedeli in ricerca di conversione o di santità. A proposito di santi, non mi risulta nella storia della chiesa cattolica dell'ultimo secolo di santi o beati cresciuti, convertiti e illuminati in una parrocchia o in una chiesa di architettura moderna o sperimentale, ma potrei sbagliarmi
Se lex orandi, lex credendi possiamo anche dire che lex aedificandi, lex credendi?
Sì, purtroppo la fede che si genera in questi edifici moderni per il culto non può che avere la latenza, la tiepidezza, la leggerezza delle cose che cambiano velocemente. È una fede innervata dagli interessi momentanei, dalla disaffezione e dalla non appartenenza. Non so quanto il cattolicesimo abbia a che fare con questi principi, sicuramente queste chiese incarnano la rinuncia alla conversione, alla dottrina, alla disciplina dell’anima, al timor di Dio.
Non gettiamo la croce solo addosso agli “archistar”. Non crede che l’estetica delle chiese rispecchi la temperatura della fede dei credenti? Insomma, magari ci meritiamo questi catto-mostri.
Le archistar fanno il loro mestiere per cui sono profumatamente pagati: esprimere concetti architettonici di stupore che meraviglino le persone. Far diventare davvero la religione l'oppio dei popoli. La missione dei costruttori di chiese è stata da sempre invece quella di costruire il luogo di incontro tra Dio in pane e in vino e chi vuole credere nella propria salvezza dopo la morte. Tutto qui. Il luogo dove fare “questo in memoria di me”. Lo scopo perciò delle chiese è perpetuare non innovare. Difficile farlo con successo nell'esercizio estetico o estatico della novità! Venendo a mancare l'importanza della funzione principale della chiesa sopra descritto, gli altri aspetti più versatili a corredo che la chiesa oggi ricopre (sala-concerti, luogo sicuro e di riparo dalla vita di strada, parcheggio utile perché gratuito sul sagrato) ci fanno accontentare di edifici in grado di assolvere almeno a questi compiti secondari più laici.
Come invertire la rotta? Come intraprendere la via pulchritudinis?
Io credo che ci siano ambiti nella vita dell'uomo – come la fede, la casa, la famiglia, l'alimentazione – in cui l'evoluzione nel tempo di alcuni aspetti essenziali avviene per mutamenti lentissimi o talvolta solo apparenti. I fallimenti di sperimentalismi per rottura con il passato non hanno mai portato a risultati apprezzabili e meritevoli sul lungo periodo. Il mio auspicio è che non solo l'architettura, ma tutto l'approccio sperimentale in genere, in questi contesti sia man mano abbandonato nella consapevolezza dell'importanza del risultato che questi ambiti attendono per i valori che rappresentano: una chiesa alta e riconoscibile da lontano con il campanile, una casa con il tetto a falde, l'unità tra genitori e figli, e gli spaghetti al pomodoro sono le basi da cui non si può prescindere o far finta che siano superati.
La chiesa con il campanile e la casa con le falde non sarebbero esempi di passatismo? Non sarebbero dei falsi storici? La tradizione autentica è dinamica, deve vivere nell’oggi anche se non si identifica con la sua parte deteriore. Ci aiuti a sciogliere questi dubbi.
Fintanto che la tradizione è la ricerca di un modello di riferimento e il percorso per il suo raggiungimento è la contingenza contemporanea, l'autenticità della tradizione è preservata e perseverata. Il falso storico è una miope lettura della realtà con gli occhi della modernità: Brunelleschi, Michelangelo e Palladio a loro tempo fecero i migliori falsi storici dell'architettura classica romana (che fu già greca). Devo ancora conoscerne i detrattori.....