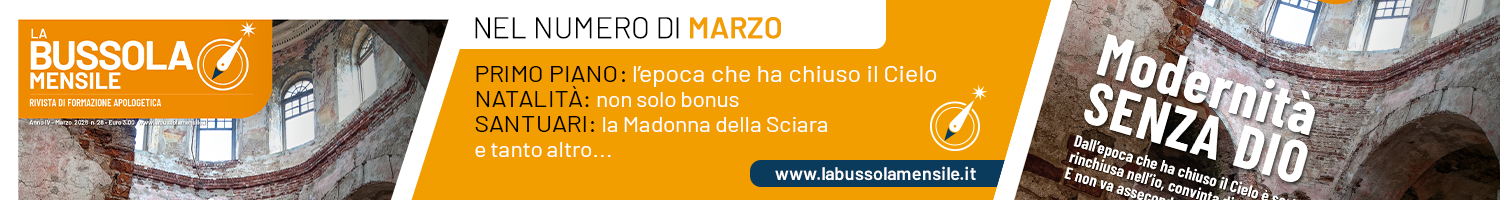Un intervento debole rafforza il Califfato
Pochi raid mirati non servono a indebolire l'Isis, né a smantellare il progetto di espansione del Califfato. Obama ha deciso di intervenire con una mano legata dietro alla schiena. E così facendo rischia di regalare una "medaglia" jihadista al califfo Al Baghdadi.

Non saranno i raid aerei limitati varati dalla Casa Bianca a fermare l’avanzata dello Stato Islamico, né i rifornimenti di armi ai curdi che oggi tutti i Paesi occidentali, improvvisamente, si accingono a inviare. Così come non saranno gli aiuti umanitari paracadutati dagli aerei anglo-americani a salvare dal massacro cristiani, yezidi e curdi.
L’intervento di Barack Obama, dietro il quale si muove lentamente un’Europa inconsistente e codarda, rischia di essere irrilevante per forze impiegate e obiettivi da conseguire mentre sul piano strategico potrebbe addirittura rafforzare lo Stato Islamico e la posizione di leadership di Abu Bakr al-Baghdad nella galassia del jihad globale.
In quattro giorni raid aerei gli statunitensi hanno compiuto poche missioni e distrutto ben poca parte dell’arsenale degli islamisti. La limitatezza dello sforzo è dimostrata dal fatto che vengono impiegati droni Reaper e i cacciabombardieri F/A-18 imbarcati sulla portaerei George H. Bush in navigazione nel Golfo. Non più di 2/4 coppie di jet sono in volo contemporaneamente sul nord Iraq e pur impiegando armi di precisione hanno finora distrutto alcuni lanciarazzi e una dozzina di veicoli uccidendo qualche decina di miliziani. Al confronto sta facendo molto di più la ventina di vecchi Sukhoi 25 forniti all’Iraq da russi e iraniani che, pur non disponendo di armi guidate, attaccano senza sosta i comandi degli islamisti e i grandi depositi di armi che lo Stato Islamico ha catturato all’esercito iracheno in rotta a Mosul, Baji e Tikrit.
I jet americani si limitano invece a colpire le forze nemiche che si avvicinano alla capitale curda Erbil, tutelando così la sicurezza del personale statunitense presente al fianco dei curdi fin da dopo la guerra del 1991. A Erbil non c’è solo un consolato americano, ma anche una grande base della CIA con contractors e consiglieri militari che vengono in queste ore rinforzati con altri 130 uomini delle forze speciali. Lo sforzo militare di Washington, per ora, punta forse a evitare un’altra Bengasi (dove nel settembre 2012 i jihadisti attaccarono il consolato uccidendo l’ambasciatore americano in Libia) non certo a salvare l’Iraq.
Anche le pressioni per indurre Nouri al-Maliki, che pure aveva vinto le elezioni del 30 aprile, a rinunciare a guidare il governo, difficilmente miglioreranno la sicurezza e la stabilità dell’Iraq dal momento che l’élite delle forze militari irachene, cioè i pochi reparti davvero in grado di combattere, sono vicini ad al-Maliki e non è detto che mostrino fiducia nel nuovo premier Haidar al Abadi voluto da Washington, accettato da Teheran e sostenuto, a parole, da europei e arabi.
Obama aveva chiesto la testa di al-Maliki, responsabile, ma non da certo da oggi, dell’emarginazione dei sunniti dalla gestione della cosa pubblica. Rovesciare l’esito del voto per dare il governo a un altro sciita, vice presidente del Parlamento, che secondo gli Usa dovrebbe creare un governo di unità nazionale, rischia però di indebolire ulteriormente il Paese. Soprattutto perché il nemico è alle porte di Baghdad: i terroristi continuano a colpire in città e le milizie islamiche combattono dall’aprile scorso alla periferia ovest della metropoli e stanno avanzando anche da nord e da est dopo aver strappato Jawal ai curdi. I sunniti iracheni stanno vincendo la guerra al fianco degli islamisti e non hanno motivo di negoziare con gli sciiti in rotta e allo sbando sul piano politico. Se l’esercito e parte della comunità sciita non accordasse fiducia ad al-Abadi lo Stato Islamico potrebbe agevolmente penetrare nel cuore di Baghdad con effetti devastanti su tutta la regione che obbligherebbero l’Iran a intervenire in modo massiccio in territorio iracheno innescando così nuove tensioni con le monarchie del Golfo.
Anche sul piano umanitario, lo sforzo messo in campo difficilmente potrà salvare le popolazioni in fuga (oltre un milione di iracheni ) consentendo loro di tornare nelle città occupate dai jihadisti. L’unica operazione militare che potrebbe consentire un rapido successo è un’azione aviotrasportata con elicotteri, fanteria aeromobile e paracadutisti appoggiati da elicotteri e aerei da attacco. Un intervento bellico vero e proprio che non rientra certo nelle opzioni valutate da Obama il quale ha dichiarato che non invierà truppe americane a combattere in Iraq. Senza di esse i raid aerei risultano insufficienti, anche perché troppo limitati, e il loro peso militare potrebbe ridursi ancora se le truppe di Baghdad dovessero subire altri rovesci.
Il presidente americano ha dichiarato di voler impedire la costituzione di uno Stato Islamico tra Iraq e Siria, ma se davvero avesse voluto perseguire questo obiettivo avrebbe dovuto muoversi prima. Possibile che l’intelligence di Washington non avesse previsto l’offensiva delle forze di al-Baghdadi, che pure ha mobilitato decine di migliaia di combattenti per occupare il nord Iraq? Possibile che la CIA non ne sapesse nulla considerato che i miliziani jihadisti imbracciavano le stesse armi che Washington aveva fatto arrivare in Siria per i ribelli “moderati”?
Obama ha detto che gli Stati Uniti non sostituiranno l’aviazione dell’Iraq, ma di fatto è quello che stanno facendo anche se in misura così ridotta da far risultare irrilevanti i loro raid aerei. Mentre gli analisti continuano a criticare le ambiguità della Casa Bianca e gli errori a raffica compiuti da Obama in politica estera, sarebbe forse il caso di domandarsi se ancora una volta (come in Libia, Ucraina e Afghanistan) la politica di questa amministrazione americana non sia volutamente improntata alla completa destabilizzazione delle aree energetiche di cui l’America, a differenza del resto del mondo, non ha più bisogno grazie alle sue immense riserve di gas e petrolio.
Se così fosse, tutta l’analisi sulla politica estera di Barack Obama dovrebbe subire una profonda rivisitazione e andrebbe valutata come un grande successo del presidente di quella che sta diventando la più grande potenza energetica globale a discapito degli interessi dell’Europa e del resto del mondo.
Un’ulteriore conferma giunge anche dalle conseguenze strategiche dei mini-raid sull’Iraq. L’intervento diretto contro lo Stato Islamico, lungi dal cambiare le sorti del conflitto, consegna invece una “medaglia” ad al-Baghdadi che appare come il nuovo paladino dell’islam contro gli infedeli. Il leader dello Stato Islamico ha colto subito l’occasione per minacciare gli Usa di attentati, forte del fatto che la guerra a Washington gli garantirà un massiccio flusso di volontari provenienti da tutte le comunità islamiche di Africa, Asia ed Europa e l’opportunità di emarginare al-Qaeda alla guida del jihad globale emulando Osama bin Laden. La mini-guerra di Obama finirà per rafforzare lo Stato Islamico amplificandone capacità e ambizioni.