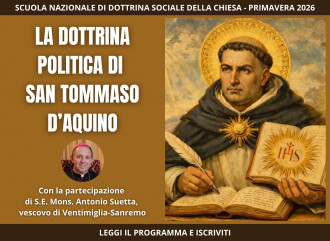Trump e il servilismo delle big tech nei suoi confronti
Ascolta la versione audio dell'articolo
Le Big Tech erano il baluardo della classe dirigente liberal, si occupavano di lotta allo hate speech e alla misinformazione. Oggi con Trump tutto è cambiato. I social sono strumenti politici.

Donald Trump torna a far parlare di sé con toni forti e coloriti, stavolta dal palco dell’Università dell’Alabama, dove si è rivolto agli studenti con la consueta irruenza verbale e ha usato un’espressione destinata a far discutere: “Fanno la fila per leccarmi il c…”. Il riferimento, tutt’altro che velato, era rivolto ai colossi del web, quelle big tech che nel recente passato si erano dimostrate fortemente critiche nei confronti della sua figura e del suo primo mandato da presidente, ma che ora sembrano aver repentinamente invertito la rotta. L’espressione scurrile non è nuova nel lessico del tycoon: solo poche settimane fa Trump l’aveva utilizzata per descrivere l’atteggiamento servile di alcuni Stati esteri disposti a negoziare con lui nonostante l’imposizione dei dazi.
Ma l’uso ricorrente di queste parole non è solo una provocazione comunicativa: è anche il segnale di un cambiamento profondo nei rapporti di forza, un modo di marcare il territorio e rivendicare una centralità politica ed economica che, almeno a giudicare dai movimenti delle grandi piattaforme digitali, si sta già concretizzando ben prima del voto. Fino a pochi mesi fa, durante l’era Biden, le big tech – da Meta a Google, da Amazon all’ex Twitter (ora: X) – sembravano rappresentare un baluardo liberal, un bastione progressista che si ergeva a difesa di certi valori democratici, spesso traducendo questa posizione in un attivismo censorio nei confronti della destra americana e dello stesso Trump. Durante il suo primo mandato, lo scontro era stato frontale: il caso del ban dai social seguito all’assalto al Campidoglio è solo l’episodio più noto, ma l’atteggiamento generale era segnato da una contrapposizione profonda. Eppure oggi quelle stesse piattaforme sembrano aver cambiato pelle: c’è una corsa alla riabilitazione dell’ex presidente, un tentativo evidente di riallinearsi ai suoi interessi, perfino un compiacente desiderio di assecondarlo, come se la storia recente non fosse mai accaduta.
È una metamorfosi che solleva domande inquietanti sul ruolo reale di queste entità nel panorama politico globale, e soprattutto sui criteri con cui decidono di schierarsi. Non è affatto un mistero che la politica delle grandi tech company sia dettata da interessi economici, e che la libertà d’espressione venga tutelata o soppressa a seconda della convenienza del momento. Quando l’opinione pubblica premiava il progressismo e la retorica dell’inclusione, i social network si facevano portavoce di campagne contro la disinformazione, contro l’hate speech e per il fact-checking. Oggi, in un contesto profondamente mutato, con il vento elettorale che torna a soffiare forte a favore dei repubblicani, si assiste a una ritirata strategica, a una riabilitazione opportunistica dell’uomo che avevano contribuito a demonizzare.
L’atteggiamento ondivago delle big tech le qualifica come autentici voltagabbana del dibattito pubblico, pronte a piegare i propri principi in nome del business. Non si tratta solo di neutralità perduta, ma di una forma subdola di cooptazione, in cui il potere economico si fonde con quello politico e annulla ogni possibile spazio di critica o resistenza.
La domanda che dobbiamo porci, davanti a questa evoluzione, è se sia ancora accettabile delegare alle piattaforme private – per quanto globali e pervasive – la gestione dei nostri diritti fondamentali. Il caso americano dimostra che queste aziende non sono né arbitri imparziali né garanti di pluralismo, ma attori politici a tutti gli effetti, capaci di incidere profondamente sull’opinione pubblica e di manipolarla secondo logiche di mercato. In questo scenario, l’idea di affidare loro la regolazione della libertà d’espressione appare non solo miope, ma anche pericolosa. È evidente che serve una risposta politica all’altezza, una legislazione sovranazionale che stabilisca criteri certi di neutralità tecnologica e impedisca alle piattaforme di agire come braccio armato – o strumento di seduzione – del potere politico di turno.
La democrazia non può più permettersi di essere ostaggio degli algoritmi, né dei cambi d’umore dei consigli di amministrazione della Silicon Valley. Occorre un sistema di regole condivise, capace di proteggere gli utenti da derive autoritarie o servili, e soprattutto di ristabilire un equilibrio che oggi appare del tutto compromesso. Il caso Trump è emblematico, ma non è isolato: è solo l’ultimo segnale di un sistema in cui le logiche commerciali dettano l’agenda politica e determinano ciò che è visibile, accettabile, condivisibile.
In un contesto simile, la libertà d’espressione è ridotta a slogan pubblicitario, e i diritti diventano merce di scambio. La politica deve riprendere il controllo, altrimenti il prossimo a fare la fila non sarà un gigante del web, ma la nostra stessa coscienza democratica.