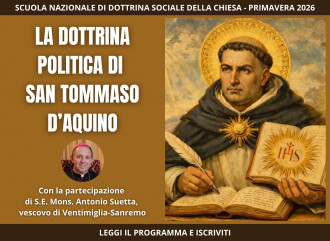Tomismo per tutti, per chi non si accontenta della modernità
L'obiettivo è ben più ambizioso di una "semplice" esposizione dell'opera dell'Aquinate: imparare a pensare come san Tommaso per non conformarsi alla mentalità (e alla filosofia) di questo secolo. Un altro pensiero è possibile.
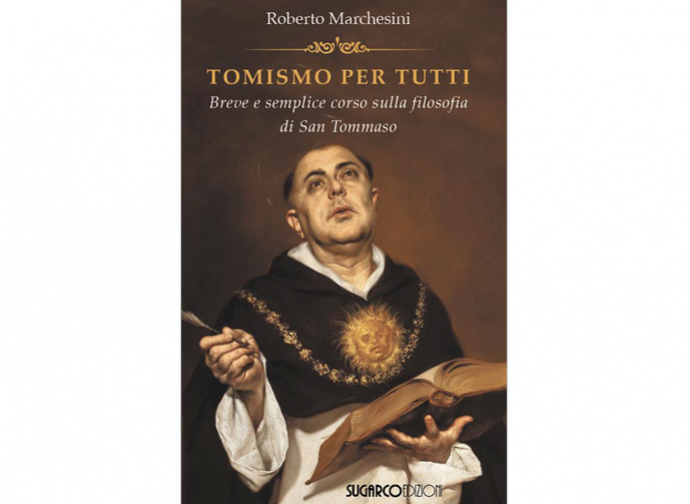
Un libro dedicato «a tutti gli insoddisfatti della modernità, a tutti coloro che si sentono fuori posto nel mondo contemporaneo»: tra le pagine di Tomismo per tutti (Sugarco, Milano 2025) Roberto Marchesini si propone di guidare il lettore «per le vie diritte della mente di Aristotele e Tommaso», mostrando che «un altro pensiero è possibile». Ed è tutt'altro che sorpassato, come sottolinea nella Premessa il teologo domenicano Giovanni Cavalcoli: Tommaso d'Aquino nacque otto secoli fa, eppure «il tomismo non è un ricordo del passato, ma una consegna per il presente», anzi (citando mons. Antonio Livi) «il futuro del pensiero cristiano».
«Sempre nei momenti di crisi e di confusione intellettuale e spirituale qualcuno si sente di dover tornare a san Tommaso d'Aquino e a riproporne il pensiero e il metodo» osserva Fontana. Marchesini è in buona compagnia, con Gilbert K. Chesterton, Cornelio Fabro e il già citato mons. Livi, e lo fa in modo estremamente divulgativo, andando dritto al cuore del pensiero dell'Aquinate, un pensiero – come lo stesso autore scrive nell'introduzione – decisamente antitetico a quello moderno in cui siamo immersi, fondato sulla «filosofia del divenire», anche se «magari non ci piace, ma siamo convinti che non ci sia alternativa». L'alternativa c'è, ed è la «filosofia dell'essere» di Tommaso.
Attenzione, però: il tomismo è per tutti ma «questo libro non è per tutti», avverte Marchesini. «Non è per "dotti, medici e sapienti"; piuttosto è per i "piccoli"» di evangelica memoria, che grazie a queste pagine non saranno spaventati dalla mole del «bue di Sicilia» (come veniva soprannominato Tommaso) e dalle sue opere, ma potranno familiarizzare con la sua mente, tra le più grandi nella storia dell'umanità. L'obiettivo del libro, infatti, «non è quello di conoscere quello che san Tommaso ha scritto, come in un qualunque corso di filosofia medievale. Noi vogliamo imparare a pensare come lui, per “non conformarci alla mentalità di questo secolo” (Rm 12,2)». Il che, forse, è ancora più difficile per i nostri contemporanei, «perché in genere non siamo abituati a un certo modo di pensare», che precede Tommaso e affonda le radici in Aristotele e ancora più indietro: «pensiamo ai più antichi manufatti umani, come Göbekli Tepe in Turchia o Stonehenge in Inghilterra: essi hanno una funzione metafisica, non materiale».
Già, la prima constatazione che abbiamo perso di vista è che «l'uomo è naturalmente metafisico, nasce metafisico». Una dimensione ben presente nel mondo classico, dove il teatro greco e il diritto romano costituivano ambiti «in cui il mondo materiale e quello metafisico entravano in contatto». Così la filosofia di san Tommaso è metafisica: «si occupa cioè (anche) di quella parte di realtà – quella più importante – che non cade sotto i nostri sensi». Tutto il contrario della modernità che, all'inizio ignorandola, ha finito per negare la realtà metafisica, «ossia considera reale solo la realtà materiale».
Antitetica alla modernità è anche la visione teleologica di Tommaso, per il quale la realtà è orientata a un fine (dal greco telòs), che «è, per gli antichi, il Logos; per il cristianesimo, la Provvidenza divina». Dal fine dipendono anche le scelte morali (e immorali) e la stessa domanda sul senso della vita, che quando è insoddisfatta «è alla base della nevrosi moderna». Come è allergica alla metafisica, la modernità è allergica anche al fine, così che uno vale l'altro... anzi no: «La società aperta è una società tollerante con qualunque pensiero... tranne uno»: quello che crede «in un senso della vita e della storia» e di conseguenza «che ci sia una morale, cioè un giusto e uno sbagliato», e che non si accontenta di spiegare la realtà con le sole leggi di inerzia e gravità, ma crede che tutto ciò sia mosso dall'«amor che move il sole e l'altre stelle», per dirla con Dante.
San Tommaso ci guida non a una "sua" idea sulla realtà, ma a leggere la realtà stessa partendo dalla primordiale presa d'atto che «c'è qualcosa», e quindi: «cos'è questo qualcosa che c'è?». Per capirlo occorre distinguere «l'ente (ciò che è) da tutti i suoi attributi; cioè separare la sostanza (dal latino sub stare, ciò che sta sotto) dagli accidenti»: per intenderci, una camicia è sempre una camicia, a prescindere che sia di lino o di cotone, rossa, bianca o gialla. Il passo in avanti sarà separare la materia dalla forma, che ce ne rivela l'essenza e il fine: «Anche l'uomo è un ente (…). La materia è, ovviamente, il corpo; e la forma? Cosa ci dice quale sia l'essenza dell'uomo e il suo fine? L'anima!». E la seconda è legata al primo così strettamente che «se litighiamo con i colleghi sul lavoro, ci verrà il mal di stomaco; se abbiamo mal di testa, saremo facilmente intolleranti».
Però le cose (e le persone) si trasformano e questo ci conduce a una distinzione successiva, identificata da Aristotele: potenza e atto. «Un uovo è pura potenza, può diventare diverse cose: una frittata, una gallina...»; realizzare, cioè tradurre in atto una di esse significa necessariamente sacrificare le altre. Ma è il prezzo della realtà: l'alternativa sarebbe tenersi un guscio perennemente chiuso. Ancora una volta, la distinzione vale anche per l'uomo: diventando adulto, il bambino sviluppa un determinato carattere, una visione del mondo, esercita una professione, diventa qualcuno e non qualcun altro. Per non sacrificare nessuna potenzialità oggi si preferisce non tradurre niente in atto e rimanere eterni «ragazzi» e «ragazze», anche dopo aver oltrepassato gli -anta.
Allo stesso tempo, le potenzialità non sono infinitamente realizzabili: un bambino può diventare un uomo adulto, non un cane o un gatto: «C'è un principio, insito in ogni cosa, che guida il cambiamento da potenza ad atto: la natura» (che «per potersi sviluppare ha bisogno di una cultura»). E rieccoci di nuovo a potenza e atto: «La natura è l'identità della cosa... in potenza», ciò che la cosa – o la persona! – è destinata a essere, il che «in termini religiosi» si chiama «vocazione». Termine spesso frainteso o ridotto a condizioni esteriori, o al solo stato di vita o alla consacrazione religiosa, ma che indica molto di più e più profondamente radicato nel nostro... essere: «la vocazione riguarda la nostra piena realizzazione, la nostra natura, il nostro progetto; il nostro fine, cioè il motivo per cui siamo al mondo».