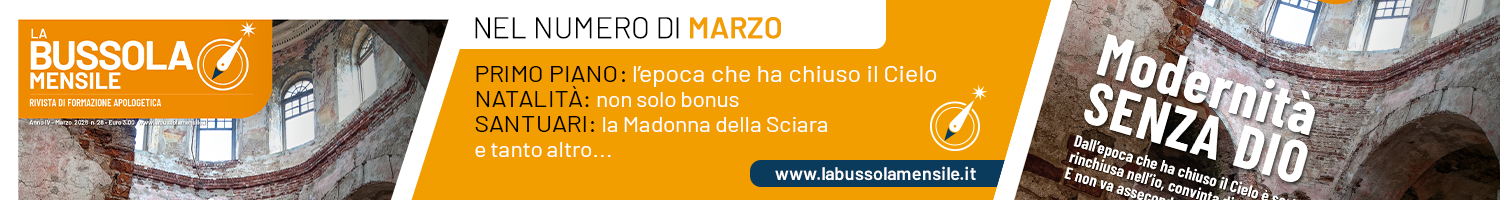Montanelli, rispetto per un peccatore prevedibile
La damnatio memoriae si abbatte su un mostro sacro del giornalismo. Colpa della furia di un collettivo di femministe che gli rimprovera di aver preso per moglie una ragazzina in epoca coloniale. L'incapacità ideoligica di riuscire a considerare il lascito culturale di una persona in luogo della sua vita privata, a meno di non voler considerare Caravaggio un ubriacone e Cellini un assassino.

Indro Montanelli non trova pace neanche da morto. “Stupratore di bambine” è la frase che le “Indecorose” (collettivo femminista Lgbtq) il 30 aprile scorso hanno attaccato alla statua del giornalista nei giardini milanesi di Piazza Venezia. Frase e comunicato stampa annesso (in cui definiscono Montanelli “fascista, revisionista, conservatore e colonialista”) fanno riferimento al suo “matrimonio” con una giovanissima abissina. Era il ’36 e Montanelli era sottotenente in Eritrea. Il 28 giugno scorso, poi, sulla testata online “The Vision” esce un lungo articolo a firma di Jennifer Guerra dal titolo inequivocabile: “É tempo di rimuovere la statua dedicata a Montanelli”. Insomma, l’offensiva contro il principe dei giornalisti, partita da tempo, sembrava ora voler diventare operativa. Peccato che oltre ad apparire a molti un attacco strumentale (come sostiene la Fondazione Montanelli-Bassi qui e qui), rappresenti anche un colossale boomerang per il pensiero turbo-progressista. Ma andiamo per ordine.
Via Mao Tse Tung? No problem.
he Montanelli non sia stato uno stinco di santo è cosa a tutti risaputa, ma se si dovessero dedicare vie o piazze sulla base dell’integrità morale si farebbe prima a intitolarle tutte per numero. Tiriamo a indovinare: scometteremmo che a quelle femministe per le quali Montanelli non merita una statua né giardini a lui dedicati (in una Milano, poi, che al giornalista deve moltissimo) vadano invece benissimo le varie “Via Stalin” e “Via Tito” sparse per l’Italia. Nessunissimo flash mob per “Piazza Lenin” (per la cronaca: a Cavriago, Reggio Emilia) e nessuna scritta di protesta per “Via Mao Tse Tung” (a Palma di Montechiaro, Agrigento).
Se questa nuova polemica un merito ce l’ha (e ce l’ha) - oltre quella di smentire una delle più amare sicurezze di Montanelli: non è vero, cioè, che «in questo Paese quando uno muore, muore per sempre» - consiste nel fare luce sull’ingarbugliata coscienza di un gigante della scrittura. Un gigante, però, dalle coronarie di cartavelina e dal cuore afflitto; un lato di Montanelli su cui si è soliti glissare, appigliandosi, al massimo, alla diagnosi ufficiale fornita dai medici: “disturbo maniaco depressivo”.
A chi gli chiedeva se degli altri uomini si sentisse fratello, Montanelli rispondeva con un sarcastico: «Io sono figlio unico». Ed era solito aggiungere: «Se c’è un Aldilà, non potrà essere il Padreterno a chiedermi perché non ho creduto, ma sarò io a esigere spiegazioni da lui». Insomma, va bene «il brutto carattere delle persone di carattere» (altra celebre sua espressione) ma qui saremmo a un passo dall’indifendibile se non fosse chiarissimo che dietro la spavalderia di certe parole si nascondeva la fragilità dell’uomo.
«Dormire avvinghiato ad un mostro»
Per toccare con mano la coscienza tormentata del giornalista di cui si invoca la damnatio memorie, è utile riprendere un passo della sua autobiografia uscita postuma (“I conti con me stesso”, Rizzoli). Alla notizia che suo zio Bibi, colpito da trombosi, è in coma, Montanelli – in una descrizione impressionante e definitiva sugli angusti anfratti del suo animo – si descrive così. «Ora è lì, e non lo riconosco, tanto l’agonia lo stravolge. Invidio il dolore di mia madre, che lo accarezza e lo bacia in fronte: è un dolore semplice, autentico e disinteressato, come tutti i suoi sentimenti. Il mio, no. Non ho pena per lui. Ho pena per me, che non so come fare a meno della sua adorazione senza riserve. Ed è su di me che mi accorgo a un tratto di piangere, e mi odio».
Il giornalista toscano non avrebbe potuto declinare con altrettanta potenza il senso delle parole dell’Apostolo: «Io faccio non quello che voglio ma quello che detesto». Eppure a nessuno verrebbe in mente di sottoporre alle Indecorose (provenienti – leggiamo dal loro sito - «dall’attivismo LGBTQIA*», e dal «transfemminismo queer») quelle che, per quanto cupe, sono le umane stravaganze del cuore dell’uomo. Proviamo a chiederci perché. «Nel pomeriggio – continua Montanelli nel suo Diario curato da Sergio Romano – scrivo un articolo per il “Corriere”. Lo scrivo con l’abituale concentrazione, che non s’incrina nemmeno quando mi telefonano che zio è spirato. Colette ha ragione quando dice che sono un mostro. Ma stanotte… Stanotte sarà una delle tante notti in cui mi sveglio di soprassalto, per l’improvvisa coscienza di dormire avvinghiato a un mostro». In questa autodescrizione – una dolorosa lezione di onestà intellettuale – c’è tutto il tormento che il mondo, specie quello gaio, si affretta instancabilmente (e strategicamente) a censurare.
“Un animalino docile”
Lungi, però, dal difendere Montanelli. Destà (o Milena oppure Fatìma, a seconda delle versioni di volta in volta raccontate) aveva solo 12 anni (o 14, anche qui il giornalista ha dato più versioni), e il fatto che l’allora sottotenente avesse 25 anni e che nella stagione del colonialismo fascista quella fosse da considerarsi prassi, non avrebbe dovuto certo consentirgli di definirla “un animalino docile”, «comprata a Saganeidi insieme a un cavallo e un fucile, a 500 lire». Che Montanelli - prima in un’intervista televisiva del 1972 a Gianni Bisiach (qui) e poi in una seconda, dieci anni dopo, a Enzo Biagi (dal min. 10, qui) – abbia sempre ammesso candidamente tutto, non lo solleva dall’atto riprovevole. Il punto non è quello di contestualizzare storicamente un episodio (gli italiani non sono stati sempre “brava gente”) bensì quello di scegliere se considerare il lascito culturale di una persona in luogo della sua vita privata, a meno di non voler considerare Caravaggio un ubriacone e Cellini un assassino.
“L’amore vince”. Anzi no.
La lezione che in questi giorni riemerge dal “caso Montanelli” va però ricercato altrove. E precisamente nella violenza a senso unico di certe testate turbo-progressiste e di certe femministe fuori tempo massimo, le quali, a dispetto dell’amato arcobaleno, vedono la realtà solo in bianco e nero, pretendendo l’abbattimento di una statua che, nelle more, non esitano ad imbrattare. In tanto dogmatismo rabbioso (che reclama rispetto) non c’è spazio per il cor inquietum, per le cadute e le risalite. Peccato, Grazia e Redenzione sono per costoro parole vuote, fuori da ogni orizzonte di riferimento. Chiamate in causa, semmai, solo per essere derise o disprezzate (le croci rovesciate e gli insulti ai cattolici che si sono visti in questi giorni di Gay pride ne sono un’eloquente conferma). E allora via con le aggressioni allo “stupratore di bambine”, un uomo morto da anni, perché “l’amore vince” solo quando decidono loro (mentre, magari, si inneggia a quella pratica dell’utero in affitto che ogni giorno fa nuove schiave).
Un peccatore prevedibile
Solo la Chiesa, con Montanelli, è volata alto. «Se era originale come giornalista – disse con un colpo di genio il vescovo Alessandro Maggiolini – come peccatore era prevedibile e normale fino alla desolazione». Avevano tifato per lui praticamente tutti: da padre Gheddo al cardinal Ersilio Tonini, e prima ancora l’arcivescovo di Milano Schuster, insieme alla sua assistente suor Errichetta Alfieri, l’“Angelo di San Vittore”, beatificata nel 2011 e a cui Montanelli deve la fuga dal carcere. Perfino Papa Wojtyla lo invitò a pranzo. E poi Maddalena, la madre amata, che non smise mai di pregare per lui. Eppure, nulla. Nessun ripensamento, almeno all’apparenza. Indro Montanelli non è un Agostino, lo abbiamo detto, ma che dei collettivi ideologizzati e violenti, nel silenzio generale, attentino alla sua statua e alla sua memoria, è l’ennesimo (indecoroso) segno dei tempi.