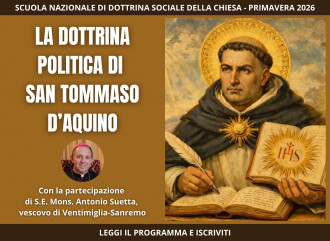Manovra finanziaria 2026: tanto rumore per nulla
Ascolta la versione audio dell'articolo
Praticamente definitivo il testo della Legge di Bilancio predisposta dal governo italiano. Pochi cambiamenti, ma gestione oculata dei conti pubblici. Si poteva fare di più? Difficile, anche perché siamo ingessati dall'Ue.

Prima di giudicare il “testo”, e dare una valutazione di merito della manovra finanziaria 2026, occorre previamente prendere in considerazione il “contesto” in cui si inserisce.
Con quasi 3.100 miliardi di euro di debito pubblico, l’Italia è il Paese dell’Unione europea con il più elevato rapporto debito/PIL, a ridosso del 136%. Il deficit annuale, sempre in relazione al PIL, appare invece sotto controllo, nell’intorno del 3%: se non fosse per l’impatto negativo degli interessi passivi sul debito, che ammontano a circa 80 miliardi di euro annui, il Bilancio pubblico sarebbe addirittura in positivo, in cosiddetto “avanzo primario”. L’obiettivo del Governo è quello di riportare tale rapporto al di sotto del 3% nel 2026, consentendo così una risoluzione anticipata della procedura europea di infrazione per deficit eccessivo: ciò consentirebbe al Tesoro di finanziarsi a tassi inferiori, avviando un percorso virtuoso di stabilizzazione e progressivo rientro del debito. Rimane, tuttavia, il problema cronico di una crescita economica asfittica, sempre dello zero virgola, recentemente minacciata anche dall’introduzione dei dazi sulle esportazioni verso gli Stati Uniti.
Una prima considerazione che si può fare è la seguente: le cattive gestioni delle finanze pubbliche nei decenni passati (fino ai “fuochi d’artificio” finali del famigerato superbonus edilizio del 110%) ora gravano sulle tasche di tutti i contribuenti, attuali e futuri. I governi che si succederanno alla guida del Paese non potranno quindi permettersi di allargare i cordoni della borsa, né oggi né domani: la responsabilità fiscale resterà imprescindibile per potere rifinanziare il proprio debito a condizioni non eccessivamente onerose. E sotto questo aspetto il governo Meloni e in particolare il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, stanno sicuramente facendo molto meglio dei governi precedenti e di altri Paesi, come la Francia, che sotto la leadership del Presidente Emmanuel Macron è divenuta invece il nuovo malato d’Europa.
Una seconda considerazione riguarda il vincolo esterno: l’Italia fa parte dell’Unione Europea, e della Nato. Le politiche comunitarie, all’insegna del centralismo e dirigismo tecnocratico, stanno portando alla crisi energetica, economica e sociale: regolamentazioni sempre più stringenti, politiche energetiche suicide, transizione green e, ultimamente, il nuovo keynesismo grigio-verde comprometteranno la produttività e la crescita economica, già minacciate dal macigno del debito e dalla desertificazione demografica. La libertà economica nell’Europa liberal-socialista è solo più un miraggio, altro che capitalismo.
Quali sono gli spazi di manovra all’interno di tale contesto? Ridottissimi, senza alcuna possibilità visibile di potere prossimamente invertire la tendenza pluridecennale di declino. Solo una profonda revisione del ruolo e del perimetro pubblico, e della relativa spesa, consentirebbero di abbassare una pressione fiscale confiscatoria, a ridosso del 43%, rilanciando così l’imprenditorialità nel Paese. Il governo italiano, tuttavia, non gode del sufficiente consenso per fare riforme incisive, alla Milei, sia per le resistenze che incontrerebbe all’interno sia perché siamo inseriti in un’Unione Europea sempre più centralistica e dirigistica.
Che cosa può fare, quindi, il governo italiano? Realisticamente, niente di più che manovre di piccolo cabotaggio, che preservano lo status quo ed evitano la crisi fiscale, il che è un bene; mantenendo però il Paese in una situazione di progressivo declino, il che è un male. Il problema non è però che il governo “faccia poco”, come lamentato da molti: quando i governi “fanno molto”, in genere “fanno troppo e male”, attuando politiche redistributive di tipo clientelare che distorcono la concorrenza e fanno lievitare i debiti pubblici, anticipando così ulteriori gravami fiscali. In realtà, la strada giusta sarebbe “fare meno”, recuperando il principio di sussidiarietà e contrastando prima il centralismo di Bruxelles e poi anche quello di Roma, deregolamentando e tagliando le spese e quindi anche l’imposizione fiscale: mission impossible.
Entrando nel merito della manovra finanziaria 2026, la cui portata complessiva è pari a circa 19 miliardi di euro, per le famiglie si prevede un abbassamento dell’aliquota IRPEF dal 35% al 33% per i redditi tra 28.000 e 50.000 €. Ciò consentirebbe un risparmio medio stimato da 200 € a 440 € annui per contribuente, in termini nominali. In termini reali sarebbe un recupero solo parziale della perdita di potere d’acquisto dell’euro negli ultimi 4-5 anni. Per le casse statali il costo potrebbe essere di circa 4 miliardi di euro.
Sono poi previsti bonus e detrazioni familiari per figli a carico rafforzate, soprattutto per spese scolastiche e libri, oltre a misure di sostegno al welfare aziendale: i benefit ai dipendenti (es. buoni spesa, buoni pasto digitali fino a 10 €) diventano parzialmente esenti da tasse. Sono poi previsti anche incentivi per chi adotta formule di lavoro flessibile o smart working familiare. Viene inoltre introdotta una parziale detassazione per straordinari, tredicesime e turni festivi nel settore privato, con l’obiettivo di far salire la retribuzione netta in busta paga senza però gravare sul bilancio delle imprese. Sul fronte delle politiche abitative si ipotizzano nuovi fondi per mutui “prima casa” e affitti ai giovani, riconfermando i bonus ristrutturazioni e mobili. Viene anche istituito un “Fondo contro il caro-libri” per famiglie con ISEE basso.
Sul fronte fiscale, è stata introdotta la possibilità di sanare vecchie cartelle esattoriali fino a 5.000 € e la rateizzazione fino a 10 anni per debiti fiscali maggiori, insieme a semplificazioni nelle verifiche IVA e riduzione degli adempimenti burocratici.
Per le imprese, invece, sono previsti incentivi per investimenti e transizione verde (purtroppo, vien da dire, ma su questo siamo legati mani e piedi alle follie ideologiche della Commissione Europea). Si prevede inoltre un “super-ammortamento” 2026 per acquisti di beni strumentali e digitali e un potenziamento dei crediti d’imposta per la ricerca, lo sviluppo e la (famigerata) sostenibilità ambientale. Si introducono anche semplificazioni per l’accesso ai fondi PNRR destinati alle PMI innovative. Per quanto riguarda il cosiddetto “cuneo fiscale e contributivo” proseguirà il taglio dei contributi previdenziali per i dipendenti a carico delle imprese, in misura variabile (fino al 6%), con l’obiettivo di ridurre il costo del lavoro e favorire nuove assunzioni. A tal fine, sono previsti anche sgravi contributivi per chi assume giovani, donne e lavoratori svantaggiati. Vengono anche introdotte misure di sostegno finanziario, come un fondo di garanzia rafforzato per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale. Per chi opera in settori stagionali è prevista l’estensione dei termini di pagamento delle imposte.
Sul fronte delle coperture, non è ancora chiaro come verranno finanziati tutti gli interventi annunciati. Vi è quindi il rischio che alcune misure rimangano poi sulla carta per la mancanza di risorse, dato il vincolo di rientro del deficit.
La manovra finanziaria 2026, insomma, non ci cambierà certamente la vita. Se non altro, tuttavia, non dovrebbe neppure peggiorarla. Ed è già qualcosa.