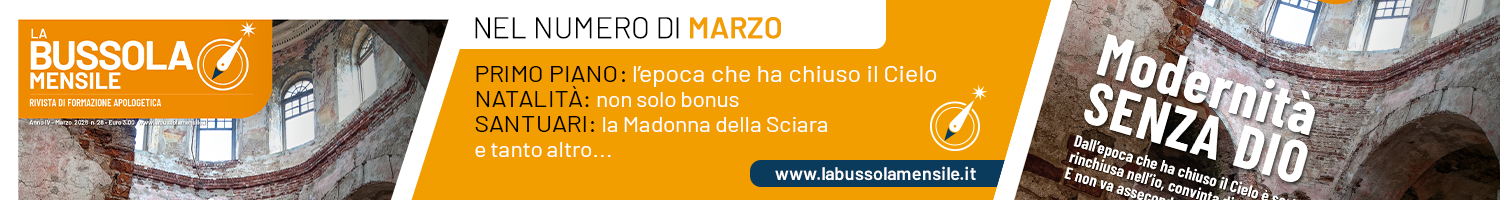L'ANNIVERSARIO
Le lettere dimenticate di Giovanni Pascoli
Cent'anni fa moriva il poeta romagnolo. Ignorate da sempre le lettere sul rapporto con i suoi cari, il ruolo della poesia, l'amore per la vita.
Cultura
06_04_2012

«Io sento che a lei [a mia madre] devo la mia abitudine contemplativa, cioè, qual ch’essa sia, la mia attitudine poetica. Non posso dimenticare certe sue silenziose meditazioni in qualche serata, dopo un lungo giorno di faccende, avanti i prati della Torre. Ella stava seduta sul greppio: io appoggiavo la testa sulle sue ginocchia. E così stavamo a sentir cantare i grilli e a veder soffiare i lampi di caldo all’orizzonte». Così scrive Giovanni Pascoli nella «Prefazione» ai Canti di Castelvecchio, raccolta dedicata alla madre Caterina Allocatelli Vincenzi, scomparsa nel 1868, quando Giovanni aveva solo tredici anni. Il 6 aprile 1912 moriva Giovanni Pascoli. Sono passati cent’anni dalla morte.
Cent’anni in cui sono avvenuti tanti cambiamenti, anche nel modo stesso di percepire la poesia e il ruolo del poeta. Pensiamo che pochi mesi prima di morire, il 21 novembre 1911, Pascoli tenne un discorso al Teatro comunale di Barga per parlare dell’impresa di Libia, discorso che venne poi pubblicato su La Tribuna del 27 novembre. A lui, poeta, è affidato il compito di spronare l’esercito nell’impresa. Certo, non si vuole qui riflettere sull’efficacia del discorso, né tantomeno sulla sua opportunità. Preme, invece, sottolineare il fatto che a distanza di un secolo la considerazione sul poeta all’interno della società è completamente cambiata. Oggi le figure a cui è attribuito un ruolo chiave sono altre. Mi sembra, poi, che gli anniversari abbiano perso importanza in un mondo in cui non viene più riconosciuta la funzione della memoria. Molto facilmente si dimentica chi ci ha preceduto e ci ha lasciato qualcosa di importante o, in qualche modo, ha contribuito alla trasmissione o alla innovazione della tradizione. Oggi si vuole partire ex nihilo, non riconoscere debiti di gratitudine al passato.
Così, quando si commemora una ricorrenza, è spesso un’occasione formale di celebrazione del presente più che un sentimento di gratitudine per quanto ci hanno lasciato gli antichi. Domina l’ingratitudine e, quando accade questo, si rischia di perdere le conquiste già raggiunte. S. Agostino commentando la frase del Vangelo «A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha che ha» spiega: «Chi è consapevole da dove ci derivano le cose, otterrà sempre più, chi non riconosce la provenienza di ciò che possediamo perderà tutto». Con questo sentimento di gratitudine per la grande poesia di Pascoli vogliamo oggi commemorare la ricorrenza del centenario della sua morte. Ci vogliamo soffermare per l’occasione proprio sulle lettere prefatorie alle raccolte, molto interessanti per capire la poesia di Pascoli, eppure poco studiate e mai riportate sulle antologie scolastiche. Ci raccontano molto del rapporto che Pascoli vive con i suoi cari (il papà, la mamma, le sorelle), ma ci descrivono anche che cosa sia poesia per Pascoli.
Nella prefazione alla prima raccolta Myricae (1891), dedicata al padre Ruggero Pascoli, assassinato il 10 agosto 1967, esordisce: «Rimangano rimangano questi canti su la tomba di mio padre!». Il poeta esorta il lettore «a benedire la vita, che è bella, tutta bella; cioè sarebbe; se noi non la guastassimo a noi e agli altri». Il mysterium iniquitatis, il mistero del male, oscura la gioia della vita e trasforma il pianto umano che è «rugiada di sereno» in «scroscio di tempesta». Pascoli riprende il vangelo di san Giovanni: «Gli uomini amarono più le tenebre che la luce, e più il male altrui che il proprio bene» La seconda raccolta Primi poemetti (1897) è dedicata alla sorella Maria. La frase incipitaria della prima raccolta «Arbusta iuvant humilesque myricae» («ci piacciono gli arbisti e le umili tamerici») è sostituita dall’espressione «Paulo maiora» («argomenti un po’ più alti»). La lunga lettera che in introduce la raccolta affronta tra gli altri temi la natura della poesia quando Pascoli scrive: «Il ricordo è del fatto come una pittura: pittura bella, se impressa bene in anima buona, anche se di cose non belle. Il ricordo è poesia, e la poesia non è se non ricordo. Quindi noi di poesia ne abbiamo a dovizia».
Forte è la somiglianza con la poetica della rimembranza di Leopardi: la memoria edulcora e trasforma quanto è accaduto nel passato, rendendolo più bello. Poi, il poeta parla attraverso una parabola, attraverso la dimensione del racconto che diventa fondamentale in questa seconda raccolta. Riporta la parabola del rondone, che forse non ha da fare, non ha ancora compagno o compagna, ma per non stare in ozio offre aiuto a una rondinella. Con questo esempio fanciullesco e anche un po’ sentimentale Pascoli vuole parlare della carità. Questo è l’invito: «Uomini, dirò come in una favola per bimbi: uomini, imitate quel rondone. Uomini, insomma contentatevi del poco […], e amatevi tra voi nell’ambito della famiglia, della nazione, dell’umanità». Pascoli spiega che «assai» significa nell’etimo latino «sì abbastanza e sì molto». Questa è la «filosofia della lingua», la potenza del linguaggio! La raccolta Nuovi poemetti (1909) è dedicata ai suoi scolari, ai quali il poeta deve molto di più di quanto non abbia dato: «Vi devo l’abitudine di supporre sempre avanti me che scrivo, come ho avanti me che parlo, anime giovanili, che è dovere e religione non abbassare, raffreddare, violare». L’insegnamento è per Pascoli «l’esercizio umano che più con la poesia si accorda».
Della prefazione a I canti di Castelvecchio si è già parlato in apertura. Nella lettera che introduce I poemi conviviali (1904-1905) dedicati all’amico Adolfo de Bosis, che l’aveva invitato a scrivere sulla rivista Convito, improntata all’estetismo allora imperante nella letteratura europea, Pascoli insiste sul «pregio del poco», che lui ha avuto modo di apprezzare sia perché gli è stato rubato tutto sia perché è riuscito a recuperare «di quel poco un pocolino». Il poeta nei Miei pensieri di varia umanità a cui fa riferimento in nota spiega che in maniera erronea la poesia viene divisa in «arcadica, romantica, classica, veristica, naturalistica». «In verità la poesia è tal meraviglia, che se voi fate una vera poesia, ella sarà della stessa qualità che una vera poesia di quattromila anni or sono. […] L’uomo […] comincia con far gli stessi vagiti e guaiti in tutti i tempi e luoghi. La sostanza psichica è uguale nei fanciulli di tutti i popoli. Un fanciullo è fanciullo allo stesso modo da per tutto. E, quindi, né c’è poesia arcadica, romantica, classica, né poesia italiana, greca, sanscrita; ma poesia soltanto, soltanto poesia, e … non poesia». Nella raccolta Pascoli riprenderà alcuni grandi del passato, trasfigurati nel mito, come Solone, Achille. Tra questi c’è anche Omero, presentato nella poesia «Il cieco di Chio». Il poeta è come un cieco, come già appare nella poesia «Il cieco» (tratta dai Primi poemetti), un uomo che sa di non sapere, che si chiede donde venga e dove vada, che si domanda chi possa ascoltare il suo pianto e comprendere il suo dolore. Allora la parola del cieco si fa preghiera che il Mistero possa entrare in rapporto con l’uomo: «Chi che tu sia, rivela/ chi sei: dimmi se il cuor ti si compiace/ o si compiange della mia querela! […] Chi che tu sia, che non vedo io, che vedi/ me, parla dunque: dove sono?».
L’uomo di fronte al Mistero, di fronte all’insostenibile vertigine dell’Infinito, domanda che si manifesti, che renda visibile la sua evidenza e il suo abbraccio misericordioso. All’uomo non basta un Dio, se questo è percepito come distante dal nostro «atomo opaco del male». All’uomo corrisponde solo quell’Infinito che si è reso compagnia umana, strada per il centuplo quaggiù e per l’eternità.