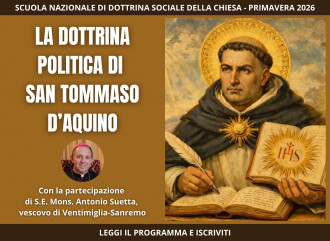La risurrezione di Cristo – Il testo del video
Gesù è il primo a risuscitare dai morti in modo perfetto, cioè definitivo, senza dover né poter morire più. Cinque ragioni di convenienza della sua risurrezione. E perché la scelta del terzo giorno.

Proseguiamo le nostre lezioni sui misteri della vita di Cristo come vengono presentati da san Tommaso nella terza parte della Summa Theologiæ. Oggi vediamo la quæstio 53, che è la prima di una serie di quaæstiones dedicate alla risurrezione di Cristo. La q. 53 è quella più centrata sul senso, su che cosa è stata la risurrezione di Cristo. Le questioni 54-56, invece, trattano altri temi legati alla risurrezione, cioè la qualità del corpo risuscitato di Cristo, le manifestazioni del Risorto, la causalità della risurrezione, cioè di che cosa la risurrezione è stata causa.
Oggi appunto ci concentreremo sulla quæstio 53, che ha quattro articoli. Iniziamo la nostra analisi dall’art. 3, perché ci aiuta a focalizzare il che cosa è stata la risurrezione di Cristo. San Tommaso si domanda se Cristo sia stato effettivamente il primo a risorgere dai morti. La domanda ha un senso, perché – se ci pensiamo – non solo nel Nuovo Testamento (ad opera di Cristo stesso), ma anche nell’Antico Testamento abbiamo testimonianze di risurrezione dai morti. Quindi, prima della risurrezione di Cristo, abbiamo dei risorti dai morti.
Ancora, un’altra obiezione che Tommaso si pone è la citazione del capitolo 27 del Vangelo di Matteo, quando, alla morte di Cristo, i sepolcri si aprono e i corpi di santi morti risuscitano (cfr. Mt 27, 52-53). Dunque, anche in questo caso abbiamo delle risurrezioni prima della risurrezione di Cristo, perché queste avvengono nel momento della morte del Signore, non nel momento della sua risurrezione.
Allora san Tommaso pone una distinzione importantissima, cioè quella tra la risurrezione perfetta e la risurrezione imperfetta. La risurrezione imperfetta, ci dice Tommaso, è una risurrezione sui generis, cioè una risurrezione di chi ancora dovrà morire: «Si può essere sottratti alla morte in due modi. Primo, con la liberazione dal solo dominio attuale dalla morte, cioè tornando a vivere in qualsiasi modo» (III, q. 53, a. 3). È appunto una vita di nuovo mortale; si pensi a personaggi come Lazzaro, la figlia di Giairo, il figlio della vedova di Nain, le risurrezioni che vediamo nell’Antico Testamento ad opera di Elia e di Eliseo: tutti questi personaggi risorti hanno dovuto riaffrontare la morte.
Continua Tommaso: «Secondo, [si può essere sottratti alla morte] con la liberazione non solo dalla morte, ma anche dalla necessità e perfino dalla possibilità stessa di morire. E questa è la risurrezione vera e perfetta» (ibidem). La risurrezione perfetta implica non solo la liberazione dalla morte ritornando alla vita, ma la liberazione dalla necessità di dover nuovamente morire, e dalla possibilità di dover nuovamente morire, a motivo della nuova condizione assunta dalla persona risorta. Dunque, san Tommaso dice: «Se parliamo della risurrezione perfetta, Cristo è il primo dei risorti, poiché egli risorgendo raggiunse per primo la vita assolutamente immortale secondo l’affermazione di san Paolo: “Cristo risuscitato dai morti non muore più” (Rm 6, 9). Invece con la risurrezione imperfetta alcuni risuscitarono anche prima di Cristo, quasi a prefigurare la sua risurrezione» (ibidem). Cristo è il primo a risorgere in assoluto quanto alla risurrezione perfetta, quindi è il primo non solo a tornare alla vita, ma a tornare ad una vita che lo sottrae definitivamente dalla necessità e dalla possibilità di morire. Le altre risurrezioni imperfette sono figure di questa risurrezione perfetta e in qualche modo manifestazione della potenza divina.
Nell’art. 4, san Tommaso si domanda se Cristo sia stato causa della propria risurrezione. Perché questa domanda? Perché nelle Scritture abbiamo dei testi che sembrano affermare il contrario.
Apro e chiudo la parentesi: Tommaso e altri autori della Scolastica sono molto attenti a esaminare con intelligenza il testo delle Scritture, senza soffermarsi a un’apparente interpretazione immediata dei testi, che è ciò che nella storia ha generato la lacerazione delle eresie.
Torniamo alla nostra catechesi: perché Tommaso si fa la domanda di cui sopra? Perché noi leggiamo, per esempio negli Atti degli Apostoli, che «Dio lo ha risuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte» (At 2, 24). E ancora: «Colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali» (Rm 8, 11). Dunque, si fa riferimento a Dio che ha risuscitato Cristo e a Colui che ha risuscitato Cristo; da ciò sembrerebbe discendere che Cristo non sia risorto per virtù propria.
Una seconda obiezione che si pone san Tommaso è tratta dalla citazione del Salmo 40, 11, in cui – secondo l’interpretazione cristologica dei Salmi, che è l’interpretazione cattolica – è Cristo stesso che parla: «Ma tu, Signore, abbi pietà e risuscitami». Dunque, è il Signore che domanda al Padre: «Risuscitami». Attenzione, perché qui riprendiamo il grande tema dell’unione ipostatica sul quale ci siamo soffermati a lungo e di cui abbiamo visto diverse volte le implicazioni. Sappiamo che la morte di Cristo ha significato la separazione della sua anima dal suo corpo; eppure sia l’anima che il corpo permanevano uniti alla divinità. Questo significa – ed è il passaggio in più – che l’anima e il corpo di Cristo morto possono essere considerati sia dal punto di vista della divinità, in quanto uniti alla divinità, sia dal punto di vista della natura umana, della natura creata.
Fatta questa premessa, san Tommaso spiega: «In virtù della divinità che gli era unita, il corpo di Cristo riassunse l’anima che aveva deposto; e l’anima riprese il corpo che aveva abbandonato. (…) Se invece consideriamo il corpo e l’anima di Cristo dopo la sua morte, secondo la virtù della natura creata allora essi non potevano riunirsi tra loro ma era necessario che Cristo venisse risuscitato da Dio» (III, q. 53, a. 4). Dunque, se io guardo l’aspetto della divinità che permane unita al corpo e all’anima di Cristo, è la divinità di Cristo che fa risuscitare Cristo dai morti. Se invece guardo il lato della natura creata, allora non posso dire che siano stati l’anima e il corpo di Cristo a resuscitare per virtù propria, ma sono risorti per virtù della divinità a cui erano congiunti.
San Tommaso risponde poi più in dettaglio alle obiezioni che abbiamo visto all’inizio di questo articolo: «La virtù e l’operazione divina del Padre e del Figlio sono identiche» (III, q. 53, a. 4, ad 1). Perché sono identiche? Perché Dio è uno e dunque tutte le operazioni divine, tutte le virtù divine si predicano e si attribuiscono a ciascuna delle tre Persone. Prosegue Tommaso: «Perciò le due affermazioni secondo cui Cristo da una parte venne risuscitato dalla virtù divina del Padre, e dall’altra risuscitò da se stesso, si implicano a vicenda» (ibidem). In sostanza, è corretto affermare che il Padre ha risuscitato Cristo, ma è altrettanto corretto affermare che Cristo è risuscitato per virtù propria in quanto ci riferiamo chiaramente alla sua divinità, che è la stessa del Padre. L’operazione di risorgere Cristo dai morti è comune al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. E dunque è corretto affermare che il Padre risuscita Cristo, com’è anche corretto affermare che Cristo risuscita sé stesso per virtù propria quanto alla sua divinità.
Quanto invece alla sua natura umana, non possiamo dire che è in virtù di questa natura che risorge dai morti; anzi Tommaso ci dice che «Cristo chiese e meritò la propria risurrezione in quanto uomo, non in quanto Dio» (III, q. 53, a. 4, ad 2). Dunque, in quanto uomo, la merita e la chiede, ma non è in quanto uomo che Cristo risuscita sé stesso.
Questi temi sono molto importanti e ci permettono di gettare luce sulle Scritture, sul mistero di Cristo e dell’unione ipostatica, che è il mistero centrale della nostra fede unito a quello della Santissima Trinità.
Adesso vediamo i primi due articoli della quæstio 53, dove Tommaso si occupa delle ragioni di convenienza della risurrezione di Cristo e del suo risorgere al terzo giorno. Per quanto riguarda la convenienza della risurrezione di Cristo in quanto tale, san Tommaso dà almeno cinque argomenti che corroborano questo aspetto. «Primo, per l’affermazione della giustizia divina, alla quale spetta esaltare coloro che per Dio si umiliano, secondo le parole evangeliche: “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha esaltato gli umili”» (III, q. 53, a. 1). Abbiamo visto che, nella sua umanità, Cristo ha realmente meritato la risurrezione. E dunque la risurrezione è un atto di giustizia, perché c’è un merito reale di Cristo. E la ragione la troviamo nel fatto che in virtù della misura del suo abbassamento, della sua umiliazione fino alla morte e alla morte di croce, in obbedienza al Padre e per amore del Padre e degli uomini, Egli viene esaltato. Gesù è il primo a incarnare il principio insegnato da Lui stesso: «chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato» (cf. Lc 14, 11). Questa è la prima ragione di convenienza per la risurrezione.
Prosegue Tommaso: «Secondo, per l’istruzione della nostra fede. Perché dalla sua resurrezione viene confermata la nostra fede nella divinità di Cristo. Come infatti dice san Paolo: “Egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio”. Da cui anche le altre parole dell’Apostolo: “Se Cristo non è risuscitato, allora vana è la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede”» (ibidem). Questo è un testo che dovremmo scolpire dappertutto, soprattutto quando ci troviamo di fronte a predicatori e sedicenti teologi che mettono in dubbio la risurrezione reale di Cristo. Ma san Paolo è chiarissimo: se Cristo non è risorto, la nostra fede è vana, è pura vanità. Il perché ce lo spiega Tommaso nel testo che abbiamo letto: è la potenza di Dio che si manifesta nella risurrezione di Cristo ed è quindi qui che la nostra fede nella divinità di Cristo viene confermata, più che in ogni altro miracolo compiuto da Cristo nella sua vita e raccontato nei testi dei Vangeli. Più di ogni altra cosa, è la risurrezione stessa di Cristo che ci dice la sua divinità, che ci corrobora nella fede nella sua divinità.
«Terzo, a sostegno della nostra speranza. Poiché vedendo risuscitare Cristo che è il nostro capo, anche noi speriamo di risorgere. Da cui le parole di san Paolo: “Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti?”» (ibidem). Se Cristo non è risorto, non solo è vana la nostra fede, ma è vana anche la nostra speranza. È perché Cristo è risorto dai morti che noi abbiamo la speranza di risorgere con Lui. E san Paolo anche qui è categorico: chi nega la risurrezione dei morti nega la risurrezione di Cristo; ed è altrettanto vero che chi nega la risurrezione di Cristo nega la risurrezione dei morti. Dunque, la risurrezione di Cristo è il fondamento della nostra speranza, intesa come virtù teologale, basata sulla certezza della fede, non sul “ma chissà se…”.
«Quarto, per la formazione morale dei fedeli in base all’affermazione di san Paolo: “Come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova”. E ancora: “Cristo risuscitato dai morti non muore più, (…) così anche voi consideratevi morti al peccato ma viventi per Dio”» (ibidem). Noi, in quanto membra di Cristo, non siamo innestati nel Cristo che deve morire, ma siamo innestati nel Cristo che è risorto da morte; ed è per questo – e non solo per una questione di imitazione delle virtù del Signore, il che ovviamente non è da biasimare – che dobbiamo camminare in una vita nuova. E dunque tutto ciò che appartiene all’uomo vecchio ostacola la vita nuova, quindi ostacola la vita di Cristo in noi. In questo senso, la formazione morale dei fedeli non è semplicemente un insegnamento teorico sulle virtù, ma – come mostrano queste citazioni di san Paolo scelte da san Tommaso – indica qualcos’altro: noi siamo innestati nel Cristo risorto. Dunque, il principio di vita che sgorga dal Cristo risorto in noi è un principio di vita nuova.
«Quinto, per il completamento della nostra salvezza. Poiché come morendo portò i nostri mali per liberarci da essi, così volle essere glorificato con la risurrezione per assicurarci il bene» (ibidem). In che senso «il completamento della nostra salvezza»? Nel senso che la morte di Cristo ci ha riscattati dal male, ci ha liberati dal male, dal dominio del Maligno, ma mancava l’altro versante: con la glorificazione della risurrezione, Egli ci dà la giustificazione, ci dà la vita nuova, ci assicura il bene della risurrezione, di una vita risorta e della risurrezione reale della carne. Questi sono i due “movimenti” del mistero di Cristo: un movimento di riscatto e un movimento di conferimento dei beni.
Nell’art. 2, abbiamo invece le ragioni di convenienza per cui Cristo dovesse risorgere il terzo giorno. San Tommaso qui affronta alcuni temi. Il primo: perché non è risorto immediatamente, cioè perché – una volta calato dalla croce – non è risorto subito davanti agli occhi dei suoi crocifissori? Oppure: perché non è risorto alla fine dei tempi, quando risorgeranno i nostri corpi? E perché il terzo giorno e non il secondo, il quarto o il quinto?
San Tommaso ricorda il principio chiave: la nostra fede si fonda sulla Trinità e sulla divino-umanità di Cristo, cioè sull’unione dell’umanità e della divinità di Cristo nella sua unica persona. Precisamente per mostrarci questa verità e per corroborare la fede in questa verità, senza la quale non ci si può salvare, la risurrezione avviene il terzo giorno. Spiega Tommaso: «Per confermare la fede nella sua divinità, era necessario che egli risorgesse presto senza aspettare la fine del mondo» (III, q. 53, a. 2). In altre parole: se Cristo non fosse ancora risorto, ma avremmo l’annuncio della sua risurrezione futura, la nostra fede nella sua divinità vacillerebbe tremendamente. Invece, poiché Cristo è realmente risorto, la nostra fede nella divinità di Cristo è collocata sulla roccia.
Ma abbiamo anche il versante dell’umanità, perché a salvarci non è solo la fede nella sua divinità, ma anche la fede nella sua umanità. Spiega Tommaso: «Per confermare invece la fede nella realtà della sua umanità e della sua morte, bisognava che ci fosse un intervallo tra la morte e la risurrezione» (ibidem). La fede nella divinità è corroborata dal fatto che Cristo non risorgerà alla fine dei tempi ma è già risorto; ma se Cristo fosse risorto immediatamente dopo la morte, si sarebbe potuto dubitare che si trattasse di una vera morte; si sarebbe potuto pensare a una morte apparente, a uno stato comatoso, ma non a una morte definitiva. Invece Cristo è morto ed è stato posto in un sepolcro e non per mezz’ora: questo ci dà la prova della sua reale umanità, perché se non ci fosse stata l’umanità non ci sarebbe stata la morte.
Dunque, vedete come la fede nella risurrezione di Cristo nel terzo giorno, come proclamiamo nella professione della nostra fede, è importante di nuovo in funzione dell’unione ipostatica delle due nature.
Poi san Tommaso dà alcune ragioni molto pregnanti sul perché del terzo giorno. Perché il terzo? «Ciò sta a significare che con la risurrezione di Cristo cominciava la terza era. La prima fu anteriore alla legge; la seconda sotto la legge; la terza sotto la grazia» (ibidem). Il terzo giorno indica una terza fase della storia. La prima fase, ci dice Tommaso, fu anteriore alla legge; dunque, va dalla creazione dell’uomo fino alla rivelazione di Dio sul Sinai e alla consegna della legge a Mosè. La seconda fase è quella che va da Mosè fino a Cristo ed è la fase sotto la legge. La terza fase è quella dell’adempimento, del superamento della legge nella grazia, da cui il terzo giorno, a indicare la vita nuova che caratterizza questa terza era, questa terza fase della storia dell’umanità.
Dice ancora Tommaso: «Con la risurrezione di Cristo inizia anche il terzo stato dei santi. Infatti il primo si svolse sotto le figure della legge; il secondo nella verità della fede; il terzo sarà nell’eternità della gloria, alla quale Cristo diede inizio con la sua risurrezione» (ibidem). Cioè, la risurrezione di Cristo indica una terza condizione dei santi, cioè di coloro che si salvano. La prima era stata nell’economia della figura, della prefigurazione, della preparazione. La seconda è quella della fede, della verità della fede e questo è interessante: non delle ipotesi, dei dubbi della fede, ma della verità della fede, perché la fede è una luce di verità; ed la condizione in cui noi che siamo in questo mondo ci troviamo.
Ma c’è una terza fase, inaugurata da Cristo: l’eternità della gloria. Eternità della gloria che Egli ha già iniziato, insieme alla Santissima Vergine, sia nell’anima che nel corpo; una vita nella gloria che già tutti i beati del Paradiso hanno iniziato nelle loro anime e che si completerà con la risurrezione dei corpi. Tutti coloro che si salvano saranno chiamati a questa gloria eterna che si riverbera nelle anime e nei corpi nuovamente congiunti dopo la morte.
Dunque, vedete il senso mistico del tre: la terza fase della storia, la fase della grazia, ma anche la terza condizione della vita dell’uomo, la prefigurazione, la fede e la gloria, che viene appunto inaugurata con la risurrezione di Cristo.
La prossima volta indagheremo degli articoli molto interessanti della quæstio 54 sulle qualità del corpo di Cristo risorto, quindi del corpo glorioso del Signore.