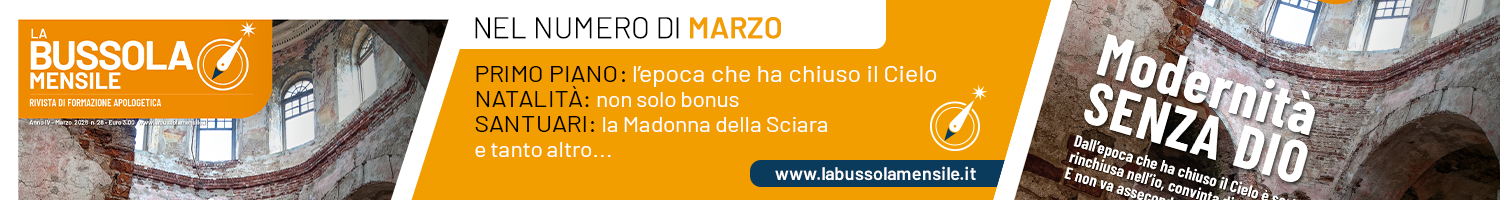Il Bianco Valentino, vetrina di un mondo che non vive la morte
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’asettico total white della camera ardente dello stilista è in fondo l’epifania del modo in cui oggi la fine più che “vissuta” è neutralizzata. E tutto quel bianco sembra coprire l’imbarazzo della contemporaneità senza escatologia.

È elegantissima, e non poteva essere diversamente visto il defunto, ma per essere una camera ardente si direbbe che “arde” poco, anzi appare piuttosto glaciale. Per due giorni la bara con le spoglie mortali di Valentino Garavani, scomparso a Roma lunedì 19 gennaio all’età di 93 anni, ha ricevuto l’omaggio del pubblico immersa nel total white di PM23, lo spazio espositivo della Fondazione intitolata a Garavani e a Giancarlo Giammetti. «È una classica camera ardente, sarebbe stato ridicolo farla rossa», ha dichiarato quest’ultimo (che con lo stilista condivise la moda e per vari anni anche la vita). Di sicuro una camera ardente in “Rosso Valentino” sarebbe stata eccessiva, ma anche questa, per altri versi, stona con la drammaticità della morte.
Quel postumo “Bianco Valentino”, lo si volesse o meno, simboleggia l’atteggiamento della contemporaneità di fronte all'ineluttabile dipartita. È, sì, «una classica camera ardente», ma forse più nel senso di esemplare, paradigmatica. Di per sé sarebbe poco comune un siffatto allestimento funebre in total white, anzi è fuori dal comune (se non forse in quale sala del commiato), eppure – al di là delle intenzioni del defunto e di chi lo piange – è epifania visiva del comune sentire, del modo in cui la morte viene vissuta, ma più spesso non vissuta. Bianchi i fiori, bianche le sedie, bianco il cavalletto con su la foto dello stilista, bianchissime le pareti di quello spazio che si trasfigura in un non-spazio, tanto quel bianco sembra volerne riempire le arcate e livellare i volumi. Il defunto avrà esequie cattoliche, ma qui non si vede nemmeno una croce, o forse è mimetizzata anch’essa.
Se un tempo si diceva: “pallido come la morte”, qui non c’è pallore né candore. Non è nemmeno assimilabile al bianco del lutto di alcune culture orientali. A prevalere è piuttosto l’asettico, come a voler sommergere e igienizzare la morte che, tuttavia, incurante di tanta eleganza prosegue la sua opera di disfacimento sul corpo che giace in attesa della sepoltura. In breve, l’immagine è di impatto (oltre che di stile) ma non è che una naturale “vetrina” della contemporaneità che il decesso deve in qualche modo mascherarlo e renderlo “inoffensivo” se non può più rimuoverlo. In altre parole è una summa delle tendenze della società odierna quando si trova alle prese con l’escatologia.
Quel bianco così neutro riassume in sé tutte le sfumature del nuovo “apparecchio alla morte”: dal carro funebre con la croce sempre più stilizzata da scambiarla per un logo a quell’aldilà che, dimenticati i novissimi e la risurrezione della carne, si fa sempre più vago e indistinto. Indistinto come quell’“ovunque tu sia” di certe espressioni di lutto in cui il caro estinto sembra disperso in mare più che vivere nell’eternità. Come quelle esequie in cui i suffragi vengono travolti dal profluvio di parole su quanto era bravo il defunto, così che persino certi funerali religiosi finiscono per somigliare a cerimonie laiche. Rimossa la croce, restano solo la foto e il ricordo destinato a sbiadire con essa e il massimo della consolazione è il classico “la vita deve andare avanti”. Rimossa la morte, si perde anche la risurrezione e con essa l’unica concreta speranza quando si guarda al destino di ogni uomo.
Il pensiero corre a quel mondo di forti passioni e violenti contrasti descritto da Johan Huizinga nel suo Autunno del Medioevo, in cui «tutti gli eventi della vita avevano forme ben più marcate che non abbiano ora» e «i grandi avvenimenti: la nascita, il matrimonio, la morte, partecipavano, per mezzo del sacramento, allo splendore del mistero divino; ma anche i casi meno importanti, un viaggio, un lavoro, una visita, erano tutti accompagnati da mille benedizioni, cerimonie, formule, usi».
In quei secoli lontani quel dramma non lo si aggirava, addirittura lo si dipingeva, se ne facevano capolavori, come Danze macabre e Trionfi della morte tra i quali però albergava la consapevolezza che «l’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte» (1Cor 15,26) e lo sguardo si levava al di sopra, al Giudizio e al Giudice giusto, «Iuste judex», invocato nel Dies irae di Tommaso da Celano, la sequenza che fino a qualche decennio fa si levava in tutte le esequie e le Messe da requiem. Quei versi non temono di mostrare insieme la giustizia e la misericordia, nel «Rex tremendae maiestatis» che al tempo stesso è «fons pietatis». Nel bene e nel male, nelle gioie e nel lutto in quel mondo a “tinte forti” vigevano una schiettezza e a tratti una crudezza che oggi ci urterebbero. Ma leggendo le pagine di Huizinga e poi guardando all’oggi pare che insieme alla morte si sia fatta un po’ asettica anche la vita.
La preghiera per i defunti e il desiderio di una morte santa
L'ottavario dei defunti ci ricorda l’importanza di offrire suffragi per le anime del Purgatorio, la migliore carità verso di loro. La pace di chi muore in grazia di Dio. E lo sprone per noi stessi: convertirci e aspirare a una morte santa.
Il giudizio è arrivato e a Orvieto si può leggere
La cappella di San Brizio si apre lungo il transetto nord del Duomo di Orvieto. Deve la sua fama agli affreschi che Luca Signorelli, pittore cortonese annoverato tra i grandi maestri del Rinascimento, vi realizzò tra il 1499 e il 1502: il ciclo apocalittico ed escatologico è meglio noto come le Storie degli ultimi giorni.