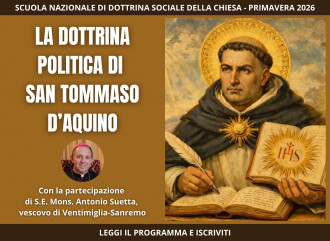Governatori in rivolta. Zaia e De Luca fanno tremare le loro coalizioni
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il limite dei due mandati impedisce a Luca Zaia di candidarsi in Veneto e a Vincenzo De Luca in Campania. I due leader scartati non ci stanno a farsi mettere da parte e, forti del loro sostegno popolare, diventano spine nel fianco dei loro partiti.

Non c’è nulla di più esplosivo, nel panorama politico italiano, dell’incrocio tra ambizione personale e limiti istituzionali. Ecco perché la ribellione dei governatori uscenti, impossibilitati a ricandidarsi dopo due mandati consecutivi, si sta trasformando in una polveriera politica di portata nazionale. La questione non è semplicemente giuridica o regolamentare: è profondamente politica, culturale e in parte anche etica.
Da un lato, la norma che impedisce più di due mandati consecutivi è nata per evitare le incrostazioni di potere, per garantire un ricambio della classe dirigente e per limitare il rischio che le Regioni diventino regni personali. Dall’altro lato, non si può ignorare come questi stessi governatori, proprio perché forti di un consenso popolare solido e duraturo, si sentano estromessi non dal giudizio degli elettori, ma da un meccanismo rigido che non lascia spazio a valutazioni più flessibili. È il caso di Luca Zaia in Veneto e di Vincenzo De Luca in Campania, due figure che, pur agli antipodi per stile, linguaggio e visione politica, si ritrovano accomunate dal medesimo destino: quello di non poter più candidarsi, pur rappresentando ancora — stando ai sondaggi e alle piazze — un punto di riferimento per larghi settori dell’opinione pubblica.
La posizione di Zaia è paradossale: è talmente popolare da essere ancora considerato l’unico in grado di ridurre il gap tra Lega e Fratelli d’Italia in Veneto, eppure la stessa Lega sembra pronta a voltargli le spalle, negandogli perfino la possibilità di mettere il suo nome su una lista d’appoggio. Il suo nome, infatti, «tira troppo», e ciò rischierebbe di mettere in ombra il candidato ufficiale del partito, oppure creare dinamiche incontrollabili nella gestione del potere locale. Zaia ha reagito da combattente: ha promesso di “vendere cara la pelle” e ha lanciato segnali chiari al centrodestra, arrivando a dire che da oggi sarà lui il problema. Pertanto le indiscrezioni su un suo possibile ingresso al governo — magari al posto di Schillaci alla Salute — sembrano più che altro tentativi maldestri di placarne la furia.
Lo stesso si può dire, mutatis mutandis, per Vincenzo De Luca in Campania. Da settimane il governatore uscente ha avviato una campagna di delegittimazione sistematica nei confronti di Roberto Fico, l’ex presidente della Camera, ora candidato per il centrosinistra. De Luca lo attacca su tutto: sulla visione moralistica, sull’appartenenza al Movimento 5 Stelle, sull’idea di voler reintrodurre a livello regionale il reddito di cittadinanza. Ogni giorno sembra buono per una nuova bordata. Non si tratta solo di schermaglie politiche, ma del tentativo palese di dimostrare che, anche se fuori dai giochi formali, De Luca vuole continuare a dettare la linea, a condizionare la scelta del successore, a preservare una parte del potere conquistato in due mandati di gestione forte e centralizzata della Regione.
Ed è proprio questa dinamica — la tentazione dei governatori di non farsi da parte — che apre un fronte di riflessione molto più ampio. È giusto vietare una terza candidatura a chi ha governato bene, con consenso diffuso e risultati apprezzabili? Non si rischia così di alimentare una contraddizione profonda nel nostro sistema politico, dove i governatori devono fermarsi dopo due mandati, mentre in Parlamento c’è chi è presente da decenni, accumulando ruoli, incarichi, ministeri, senza che nessuno osi proporre un tetto alla loro longevità politica? Il cittadino comune potrebbe chiedersi: perché a De Luca o a Zaia non è concesso di ricandidarsi, mentre ci sono deputati e senatori che stanno lì da trent’anni senza mai passare da una verifica diretta dell’elettorato, visto che con le liste bloccate sono le segreterie dei partiti a stabilire nei fatti chi deve entrare in Parlamento? La risposta non è semplice, ma il problema è evidente. E il rischio che tutto questo produca effetti destabilizzanti è reale. I governatori esclusi potrebbero decidere di non sostenere i candidati ufficiali dei loro partiti, o peggio ancora di promuovere movimenti civici, liste personali, esperimenti autonomi che andrebbero a minare l’unità delle coalizioni.
I primi segnali ci sono già. E non è escluso che proprio attorno a questi leader in uscita — ma non rassegnati — si possano coagulare nuove forze politiche, nuove identità ibride tra territorio e ideologia, tra pragmatismo e ribellione. L’Italia è già stata teatro di fenomeni più o meno simili. Basti pensare alla parabola di Toti in Liguria o alle esperienze precedenti di Formigoni, Cuffaro, Bassolino. Non sempre questi esperimenti hanno avuto fortuna, ma il contesto attuale, fatto di partiti fragili e sempre più leader-centrici, rende lo scenario ancora più fluido. In fondo, se i partiti non sono più in grado di valorizzare il merito e la leadership costruita sul campo, è naturale che i leader cerchino nuove strade per restare protagonisti. E allora forse il problema non è nemmeno solo la legge sul limite dei mandati, ma la difficoltà della politica di conciliare regole uguali per tutti, perché ci sono momenti in cui il principio dell’alternanza può scontrarsi con la volontà popolare, e allora il rigore istituzionale rischia di trasformarsi in ottusità.
Non è detto che la soluzione sia abolire il limite dei due mandati, ma di certo serve un dibattito più onesto e trasparente sul tema. Anche perché le prossime elezioni regionali rischiano di spaccare i fronti, accendere conflitti interni e alimentare quella deriva personalistica che da anni mina la tenuta dei partiti. E così, mentre De Luca e Zaia si preparano alla battaglia da fuori campo, la politica nazionale osserva, preoccupata ma anche impacciata, incapace di gestire una transizione che non doveva essere così traumatica. Perché se è vero che nessuno è indispensabile, è anche vero che chi ha consenso, idee e radicamento sul territorio non può essere trattato come un peso da eliminare. Ignorare questa realtà potrebbe rivelarsi un errore fatale.