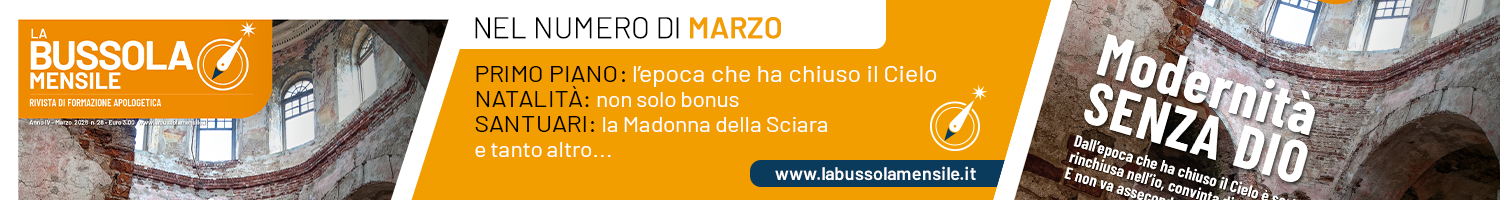Eutanasia chiama eutanasia: cosa spiega il boom canadese
Ascolta la versione audio dell'articolo
Oltre 16mila morti per eutanasia in Canada nel 2024: significa che un decesso su venti avviene con questa pratica. Il dato choc dimostra che più si diffonde una legislazione di depenalizzazione, più crescono le domande.

16.499. Sono i decessi per eutanasia avvenuti in Canada nel 2024 secondo il Sesto rapporto annuale sull'assistenza medica al suicidio (MAID). Dal 2016, anno di legittimazione del suicidio assistito, ad oggi i decessi per MAID ammontano ad oltre 76mila. 16.499 decessi per eutanasia corrispondono al 5,1% di tutti i decessi. Ciò vuol dire – dato ancor più amaramente interessante – che un decesso su 20 in Canada avviene a causa di trattamenti eutanasici. Il report ci informa che le richieste respinte ammontavano a 6.036.
Rispetto al 2023 c’è stato un aumento di decessi per suicidio assistito del 6,9%, un aumento che numericamente è sempre in crescita dal 2019, primo anno di rilevazione. La maggior parte delle persone morte per MAID, il 95,6%, aveva poco tempo da vivere. Quel 4,4% di persone suicidatesi sebbene non fossero sul punto di morire sembra una percentuale da poco ma corrisponde a 732 persone, segnando un +17,12% rispetto al 2023, persone perlopiù affette da disabilità.
Come spiegare questi numeri? E, più in generale, come spiegare il fenomeno dell’eutanasia che nel mondo, seppur a velocità diverse, sta sempre più dilagando? Le motivazioni sono plurime. Qui accenniamo solo ad alcune.
In primo luogo si fa sempre più fatica a considerare la persona custode di una preziosità intrinseca incommensurabile al di là della maggiore o minore perfettibilità fisica, al di là delle patologie da cui può essere affetta, al di là della sofferenza patita, al di là della capacità di svolgere alcune funzioni quali il linguaggio, la coscienza di sé e del mondo intorno a sé, l’autonomia etc. Il giudizio morale viene calibrato secondo il criterio della qualità della vita, non secondo il criterio della dignità intrinseca della persona, dignità che è assoluta, ossia svincolata da parametri come salute ed efficienza.
Queste categorie qualitative, invece, sono state fatte proprie in modo profondo dalla coscienza collettiva tanto che gli stessi pazienti non solo giudicano le proprie esistenze malate ormai non più degne di essere protratte nel tempo, ma reputano le stesse come un fardello insopportabile da far portare a parenti ed amici, i quali, loro stessi, non sono più disposti a sopportare tale carico di sofferenza ed assistenza ed a supportare il proprio caro fino alla fine. Il secondo nodo quindi è dato dall’individualismo radicale, ambiente asfittico in cui siamo immersi tutti noi ogni giorno. La concentrazione dell’universo nel nostro ombelico ci fa percepire gli altri o come nemici del nostro benessere, se ci possono danneggiare, o come alleati per il nostro benessere, se possono tornarci utili. Ovvio che il nonno morente non può che rientrare nella prima categoria. L’eutanasia diventa quindi risorsa per tutelare il nostro dorato egoismo: la morte anticipata significa anticipare altresì il ritorno alla nostra vita, ai nostri agi, ai nostri progetti, ai nostri divertimenti, etc.
L’eutanasia è sempre preceduta dall’abbandono affettivo, ancor prima che clinico. Chi sta morendo, ma è circondato da affetto, aspetta la morte, non le corre incontro. Chi si sente solo già si sente morto. C’è un dato nel report canadese che ce lo conferma: quasi tre quarti (74,1%) delle persone decedute per MAID hanno ricevuto cure palliative. Una certa propaganda pro-life, anche italica, afferma che più si estendono le cure palliative meno richieste di eutanasia avremo. Bisogna capirsi. Se per cure palliative si intende – come si dovrebbe – le terapie antalgiche, ossia contro il dolore, e la cura totale della persona, comprendendo anche la vicinanza affettiva, allora quella dinamica inversamente proporzionale prima descritta è vera: più cure palliative significa meno eutanasia.
Ma qualora per cure palliative si intendessero solo le somministrazioni di oppiacei o similia, allora le richieste di morire non diminuiranno. Ed infatti sebbene la quasi totalità dei richiedenti MAID si fosse sottoposta a cure palliative, ossia a terapie antalgiche, ciò non ha impedito di anticipare la loro morte con l’eutanasia. Perché gli oppiacei tolgono il dolore fisico, ma per il dolore dell’anima, che è quello che ti fa desiderare di morire, servono gli abbracci e sguardi in cui tu riconosci ancora il tuo valore perché ti senti amato. Dobbiamo poi ricordarci di quel quasi 26% che ha voluto morire e non ha avuto bisogno di cure palliative, ciò a testimonianza che il dolore fisico non è il discrimen vero, bensì è la sofferenza psicologica a fare la differenza.
L’eutanasia sta crescendo in Canada come nella coscienza di molti anche grazie al cosiddetto fenomeno del contagio sociale. Più se ne parla, più si pratica. Più si pratica, più persone prenderanno esempio da chi ha compiuto queste scelte. La diffusione di un costume porta alla sua normalizzazione sul piano morale.
Un altro fattore adiuvante la pratica dell’eutanasia è sicuramente la sua legalizzazione. Ogni norma educa o diseduca il cittadino. Il ragionamento è tanto semplice quanto erroneo: se c’è una legge sul suicidio assistito, vuol dire che questa pratica è anche moralmente praticabile. La depenalizzazione di una pratica – dunque nel nostro caso evitare di mandare in carcere chi aiuta qualcuno a togliersi la vita – non fa che incentivare la pratica stessa. È contraddittorio quindi affermare che per debellare un certo fenomeno è necessario depenalizzarlo o addirittura legittimarlo.
Un penultimo motivo, tra i diversi, che qui vogliamo rammentare in merito all’incentivazione della pratica dell’eutanasia è da rinvenirsi nella perdita del senso della sofferenza. Scriveva nel 2016 il cardinal Elio Sgreccia: «La risposta del mondo secolarizzato di fronte alla sofferenza è ben preciso: quello del rifiuto. Ciò vuol dire che la sofferenza deve essere combattuta e dominata in tutti i modi e, quando non è più suscettibile di guarigione, deve essere rifiutata la vita provocando la morte. […] L’atteggiamento di rifiuto della sofferenza, a modo di negazione, porta così la cultura ad eliminare il sofferente come portatore di sofferenza, destituendolo della sua dignità di persona» (Sofferenza e morte nella cultura contemporanea, in Congregazione per la Dottrina della Fede, Sull’eutanasia, LEV, pp. 50 e 55). La sofferenza può acquistare valore solo se intendiamo l’uomo un essere spirituale, solo se la prospettiva è metafisica. Unicamente uno sguardo trascendente può assegnare significato a ciò a cui la ragione non riesce per sue sole forze a dare senso. Il dolore può essere accettato e offerto al fine di diventare prezzo di riscatto per i propri peccati e per i peccati altrui. Anche il dolore altrui inconcepibile e umanamente devastante come quello dei bambini può essere offerto a Dio e comunque anche in esso c’è sicuramente un valore, perché nulla esce dalle mani provvidenziali di Dio. Tutto egli vuole o permette per un bene maggiore.
Ma l’uomo contemporaneo, e così arriviamo all’ultimo motivo della diffusione dell’eutanasia, è ateo per definizione. La sofferenza, chiusa nella prospettiva immanente del mondo, è di per sé insensata. Se poi Dio non c’è, il senso di questa esistenza termina con la nostra morte e dunque una esistenza che reca con sé più affanni che benedizioni, più angustie che soddisfazioni è una esistenza che non vale più la pena di vivere. È una vita già morta in sé.
Per approfondire: Tommaso Scandroglio è autore di Appuntamento con la morte. Eutanasia, accanimento terapeutico e Dat (I Libri della Bussola: clicca qui per acquistarlo)