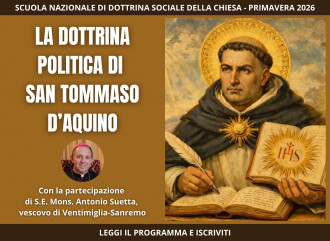Dalla routine alla meraviglia. Una nuova visione per la primaria
Ascolta la versione audio dell'articolo
La scuola primaria è inutile se diventa un mero accumulo di conoscenze, o una serie di nozioni da imparare a memoria. La riforma possibile deve trasformare i primi anni di istruzione in un periodo in cui si aprono orizzonti e si stimola la mente.

Dopo trent’anni di insegnamento e vent’anni da genitore, sento il bisogno di soffermarmi su una realtà che molti vivono quotidianamente, ma che raramente viene affrontata con la necessaria profondità: la scuola primaria italiana, oggi, mostra segnali di affaticamento nel suo ruolo di fucina di curiosità, pensiero e futuro. In diversi contesti, si è trasformata in un luogo dove il tempo si accumula senza generare vera conoscenza, competenza o cultura. I bambini trascorrono ore tra i banchi, ma ne escono con abilità sempre più fragili. Più tempo non equivale a maggiore cultura; più attività non garantiscono un pensiero più ricco.
Queste osservazioni non vogliono mettere in discussione l’impegno dei docenti, che ogni giorno affrontano con dedizione sfide complesse. Al contrario, intendono offrire uno spunto di riflessione su un sistema che, troppo spesso, non valorizza il loro lavoro, non li accompagna nella formazione continua e non fornisce gli strumenti necessari per rendere la scuola un ambiente vivo e generativo.
Una didattica che non spalanca
La scuola dovrebbe essere il luogo dove si aprono orizzonti, si accendono domande, si stimola la mente. Quante volte un bambino torna a casa entusiasta per ciò che ha vissuto tra le mura scolastiche, desideroso di raccontare, condividere, approfondire? L’età tra i sei e gli undici anni è quella in cui il desiderio di conoscere è ancora vivo, come ci ricordano Aristotele, Dante e tanti altri pensatori che hanno descritto la natura umana come intrinsecamente curiosa. Quando viviamo qualcosa di significativo, la prima reazione è raccontarla, come accade dopo un bel film, una visita coinvolgente, la lettura di un libro appassionante o l’incontro con una persona speciale.
Ogni genitore può partire dall’esperienza dei propri figli. In molte scuole, la didattica tende a chiudersi in percorsi lenti e ripetitivi, che finiscono per perdere di vista il senso profondo dell’apprendere. Prendiamo la storia: anziché affascinare con il racconto del passato che illumina il presente, si indugia a lungo su dinosauri e uomini primitivi, arrivando alla fine del ciclo solo allo studio dei Romani. Così, la contemporaneità resta ai margini. I bambini non imparano a leggere il mondo, ma si trovano a seguire un programma che fatica a dialogare con la realtà. Come potranno comprendere il significato della Giornata della memoria o dell’Anniversario della liberazione se il Novecento viene affrontato solo all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado? A quel punto, il tempo per aprire la categoria storica potrebbe essere già scaduto.
La geografia, che dovrebbe insegnare a orientarsi nel mondo, si riduce spesso a schede e definizioni. Manca l’esplorazione del territorio, lo stimolo a conoscere altri Stati, culture, tradizioni. Quanti ragazzi sanno collocare città, capitali, fiumi, Stati? Queste conoscenze, considerate talvolta superflue, vengono accantonate come semplice nozionismo. Ma davvero conoscere l’alfabeto della geografia è inutile? Trasmettere contenuti e, al tempo stesso, suscitare curiosità è possibile. Cultura e contenuti non sono sinonimi di noia: è il modo in cui vengono proposti a fare la differenza.
La matematica, invece di essere scoperta, viene spesso eseguita. Si insegna il meccanismo, ma non la logica che lo sostiene. Si fanno operazioni, ma non si sviluppa il pensiero. Eppure, la matematica è bellezza, intuizione, gioco mentale. È uno strumento per comprendere il mondo, per affinare il pensiero critico, per allenare la mente.
Secondo i dati INVALSI, tra il 2019 e il 2025 si è registrato un calo del 4–5% nei punteggi medi. Le difficoltà maggiori riguardano proprio la logica e il problem solving. Non è solo una responsabilità dei docenti, ma anche di un impianto didattico che non sempre consente loro di mostrare la matematica come linguaggio del pensiero.
Lingua italiana: grammatica senza parola
L’italiano, in molte classi, viene ridotto a esercizi grammaticali privi di contesto. I bambini leggono poco, scrivono meno, parlano raramente. Dopo anni di studio, arrivano alle superiori senza padroneggiare la lingua. I temi sono sempre più rari: capita che gli studenti affrontino le superiori avendo scritto pochissimi elaborati. Le verifiche scritte, spesso a crocette o di completamento, sono rapide da correggere ma poco efficaci nel far acquisire capacità di esposizione e rielaborazione. Le interrogazioni tradizionali, ormai sporadiche, vengono considerate superate.
Le Prove INVALSI 2025 confermano che la comprensione del testo è l’area più critica. Molti alunni faticano a cogliere significati impliciti, relazioni logiche, a esprimersi con chiarezza. Il vocabolario attivo è spesso limitato, soprattutto nei contesti più fragili. Ripartire dalla parola viva, dalla narrazione, dal dialogo è fondamentale. Alcuni insegnanti lo fanno già, con passione e creatività, ma è necessario che il sistema li sostenga e li incoraggi.
Insegniamo ai bambini a scrivere, a raccontare e raccontarsi, a tenere un diario. Così imparano a conoscersi, a descrivere emozioni, esperienze, pensieri.
Inglese: una lingua da vivere, non da elencare
L’insegnamento dell’inglese, in molte situazioni, si limita a un esercizio mnemonico: colori, numeri, oggetti. Una lingua frammentata in vocaboli isolati, priva di contesto e relazione.
Le Prove INVALSI 2025 restituiscono un quadro disomogeneo:
· listening: difficoltà nella comprensione di dialoghi semplici;
· writing: debolezza nella produzione scritta;
· forti divari legati al contesto socio-culturale.
Per questo è essenziale che l’insegnamento sia affidato a chi parla esclusivamente in inglese durante l’intera lezione. Anche solo un’ora settimanale vissuta interamente in lingua può offrire un’esperienza immersiva, autentica, capace di stimolare ascolto, comprensione e comunicazione. Molti insegnanti ne sono consapevoli e si impegnano in questa direzione, ma spesso mancano risorse, formazione, tempo. È il sistema che deve metterli nelle condizioni di trasformare l’inglese in una finestra aperta sul mondo.
Il cambiamento possibile
Le nuove Indicazioni Nazionali 2025 promettono una svolta: didattica esperienziale, interdisciplinare, inclusiva. Matematica come logica, italiano come espressione, storia come chiave per leggere il presente. Bambini protagonisti, non spettatori.
Il pericolo, però, è che le riforme si traducano in cambiamenti di facciata, senza incidere realmente sulla vita scolastica. Gli insegnanti con più esperienza hanno visto alternarsi metodi e criteri di valutazione che, troppo spesso, non hanno portato benefici concreti. Occorre evitare che le riforme si fermino alla superficie. Serve il coraggio di riconoscere gli errori del passato e di intervenire con decisione.
Un esempio? La riduzione dello studio della storia alla sola fase pre-romana. È tempo di riaprire la prospettiva storico-geografica, tornando a esplorare i popoli antichi fino al Novecento già nella scuola primaria. A queste conoscenze vanno affiancate quelle geografiche: regioni, Stati, continenti. È proprio in questa fascia d’età che si può avviare il percorso verso la consapevolezza del tempo e dello spazio.
Bisogna poi già dalla primaria insistere su alcuni aspetti fondamentali:
· scrivere in corsivo, tenere diari, sviluppare elaborati;
· potenziare la memoria, anche attraverso lo studio delle poesie, come suggerito dal Ministro dell’Istruzione;
· allenare la logica e il problem solving;
· promuovere l’uso di una lingua straniera;
· coltivare una cultura che non si chiuda in definizioni, ma apra alla ricerca, alla domanda, alla scoperta.
La scuola primaria può e deve tornare a essere un luogo di meraviglia, scoperta della realtà e crescita. Un ambiente dove il tempo non si misura in ore, ma in pensiero. Dove l’apprendimento non è accumulo, ma trasformazione. Dove ogni bambino può trovare la propria voce, il proprio ritmo, il proprio cammino.
Molti maestri lo fanno già, con passione e intelligenza. A loro va il nostro sostegno, la nostra fiducia, il nostro impegno. È da qui che può partire il cambiamento: non da slogan, ma da scelte coraggiose, da visioni lungimiranti, da una rinnovata alleanza tra scuola, famiglia e società. Solo così la scuola tornerà a essere ciò che dovrebbe sempre essere: un luogo dove si impara a pensare, a sentire, a crescere.