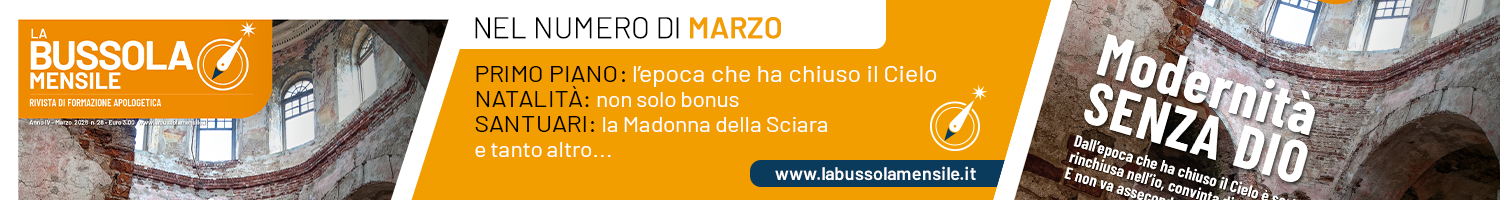Bimba morì, ma era in affido. Per il giudice la sofferenza della madre è inferiore
Ascolta la versione audio dell'articolo
Forlì: bimba morì per errore medico a 5 anni. Il giudice aveva già condannato l'Asl a risarcire la famiglia affidataria per 800mila euro, mentre oggi alla madre vanno appena 70mila euro: «Ha sofferto di meno perché non era in un contesto ordinario di convivenza». La denuncia del legale alla Bussola: «Pericolosa discriminazione e gerarchia dei dolori».

La bambina era in affido, quindi la mamma ha sofferto di meno per la sua morte. E pertanto il risarcimento economico deve essere inferiore rispetto a quello della famiglia affidataria che viveva con lei. Quanto? 800mila euro agli affidatari contro appena 70mila per la madre naturale alla quale non sono state riconosciute neppure le spese legali. È vero che le sentenze si rispettano, ma certi pronunciamenti dei giudici sembrano essere scritti per suscitare più di una perplessità. E soprattutto alimentano il sospetto che ci sia una tendenza radicata da parte dello Stato a risolvere a sfavore della famiglia naturale ogni tipo di controversia.
Il tribunale di Forlì ha emesso il 14 gennaio una sentenza a seguito del procedimento per la morte della piccola Teresa Berni, una bambina di 5 anni morta nel 2017 per una peritonite mal diagnosticata dai sanitari dell’ospedale dove era in cura. Il procedimento penale a carico della dottoressa che scambiò l'appendicite per un'infezione alle vie urinarie, si era concluso in primo grado con una condanna per omicidio colposo e in secondo grado con la sua assoluzione e una transazione a favore delle parti civili che si erano costituite,cioè la famiglia affidataria, per 800mila euro.
Sembrava un triste caso di malasanità, ma il successivo processo in sede civile lo ha trasformato in un processo alla famiglia naturale, che si era inserita solo in sede civile. Al momento della quantificazione del danno subito, il giudice ha riconosciuto il vincolo affettivo della madre, ma lo ha nettamente sminuito mentre precedentemente era stato riconosciuto a favore della famiglia che da un anno e mezzo aveva accolto la piccola in casa.
Andiamo con ordine.
La piccola all’età di un anno viene ospitata in una comunità con la madre, una ragazza fragile, con un passato problematico anche a causa della situazione di estrema povertà della sua famiglia di origine, con un padre in carcere e situazioni di violenza. La ragazza, che non aveva problemi di droga o alcol, ma di estrema fragilità e immaturità di fronte al compito genitoriale richiesto, entra così in una comunità al Cav di Forlì con la piccola dove trascorre il primo anno di vita.
Successivamente però, la ragazza sente il bisogno di uscire dalla comunità e di rendersi maggiormente indipendente, ma nella condizione di essere una persona bisognosa di aiuto lei per prima, le difficoltà di gestione sono così emerse ancor più chiaramente.
A quel punto entrano in campo i servizi sociali che regolamentano le visite della mamma alla bimba, rimasta in comunità. Così spiega alla Bussola il legale della donna, l’avvocato Francesco Minutillo: «Quando la mamma è rimasta incinta una seconda volta, i servizi sociali hanno prima cercato di impedire alla donna di vedere la figlia, perché il vedere la mamma col pancione, a detta loro, avrebbe turbato la serenità della piccola e poi hanno intrapreso la pratica per l’adottabilità di Teresa e contemporaneamente avviato la pratica dell’affido presso una famiglia resasi disponibile».
«Il tribunale dei minorenni di Bologna - ha proseguito - ha sentenziato che non c’erano i requisiti di adottabilità proprio perché la madre voleva stare con la bambina. Era presente agli incontri e la bambina stava bene con lei e questo è attestato anche dalle relazioni dei servizi sociali, che hanno messo nero su bianco il legame della piccola con la madre, con la quale giocava e nei cui confronti non aveva mai manifestato alcun segno di disagio. Il giudice, così, respinse la richiesta di adottabilità proprio perché c’erano le condizioni sia di un rapporto genitoriale, pur difficoltoso vista la situazione, sia di una volontà della mamma di volersi ristabilire pienamente». Anche il rapporto con la nonna – si nota – emerge in maniera altrettanto chiara e strutturata. Dunque la piccola Teresa, semplicemente non era stata abbandonata dal contesto famigliare, che comunque era presente agli incontri e a lei si interessava pienamente.
La donna vedeva infatti la figlia anche nella nuova situazione di bambina data in affido ad una famiglia locale. Fino a che, raggiunti i cinque anni, non si è verificato il terribile episodio che l’ha portata alla morte, avvenuta nel 2016.
La sentenza di lunedì è, dunque, la lunga coda di una vicenda giudiziaria iniziata con il decesso della bambina e proseguita con il risarcimento ottenuto dai genitori affidatari. Solo la madre è stata riconosciuta titolare di un rapoorto affettivo e non gli altri famigliari che si sono costituiti. Ma secondo l’avvocato Minutillo quel processo va appellato e per questo presenterà ricorso per rivedere la decisione del giudice.
«Il Tribunale in sentenza – spiega il legale - ha dato esplicitamente atto della effettività della posizione della madre naturale “per la quale – si legge nel dispositivo - non è possibile escludere in toto il danno per la perdita del rapporto parentale, in considerazione del legame comunque instaurato tra madre e figlia nei primi anni di vita”.
Ma il pugno nello stomaco arriva subito dopo quando il giudice afferma che “fatte tali precisazioni, va nondimeno rilevato che in un tale contesto non può ritenersi, facendo ricorso alle ordinarie presunzioni, che la morte di Teresa abbia ingenerato in lei la medesima profonda sofferenza, prostrazione e senso di perdita che ben può immaginarsi si sarebbero verificate in un ordinario contesto familiare di convivenza, senza peraltro escludersi la perdita di un vincolo affettivo, seppur non particolarmente intenso. Di ciò deve, dunque, tenersi conto in sede di liquidazione equitativa del danno».
Questo è il punto contestato da Minutillo perché emerge la «abnormità della decisione che sta proprio nell’uso della regolamentazione istituzionale come parametro svalutativo del dolore. Qui non siamo di fronte a una semplice riduzione del quantum risarcitorio, ma a un passaggio concettuale estremamente pericoloso: l’idea che una madre debba soffrire di meno perché il suo rapporto con la figlia non è ‘ordinario’ ma gestito dal servizio sociale».
Ma c’è di più. Il legale ha rimarcato però che «quel rapporto non è stato ridotto per scelta della madre: è stato regolamentato dallo Stato, attraverso il servizio sociale, nell’esercizio dei suoi poteri come ormai sempre più spesso stiamo assistendo in numerosi casi anche clamorosi».
Secondo Minutillo è «inaccettabile che lo Stato prima intervenga nel rapporto tra madre e figlia, lo disciplini, lo limiti, lo sposti altrove, e poi utilizzi quella stessa limitazione – che non è stata voluta dalla madre – per affermare che la sua sofferenza vale meno. Questo significa trasformare un intervento di tutela in un criterio di discriminazione».
Questa decisione apre a scenari davvero problematici perché se passa il principio che la sofferenza di un genitore naturale è minore perché il rapporto era regolamentato, allora si introduce una gerarchia dei dolori. Si finisce per dire che soffrono davvero solo le famiglie senza interventi dei servizi, senza fragilità, senza conflitti mentre tutte le altre valgono meno.
Siamo di fronte ad una autoassoluzione dello Stato che non può non far riflettere: «Lo Stato – ha concluso l’avvocato della donna - prima decide come deve funzionare il rapporto genitoriale, poi utilizza quella decisione per svalutare il dolore che deriva dalla sua definitiva perdita. È un cortocircuito istituzionale che pone seri problemi di equità e di tutela dei diritti fondamentali».