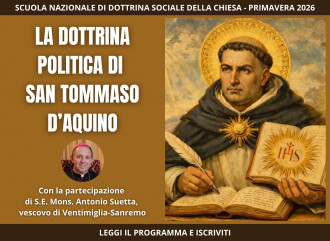Meloni vuole "pieni poteri"? Per ora li hanno solo le toghe
Ascolta la versione audio dell'articolo
La sinistra accusa il governo Meloni di cercare di ottenere "pieni poteri" con la riforma della magistratura. Ma come spiega Alfredo Mantovano (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e magistrato) si tratta di un riequilibrio di poteri necessario.

La polemica sui “pieni poteri” è tornata prepotentemente al centro del dibattito politico nazionale in vista della campagna referendaria per il voto di primavera sulla riforma della giustizia, approvata in via definitiva dal Parlamento e ora pronta ad essere sottoposta al giudizio degli italiani. Il tema, già di per sé sensibile, ha assunto toni accesi dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che nei giorni scorsi ha voluto replicare con fermezza alle accuse provenienti dalle opposizioni, chiarendo che non è la premier Giorgia Meloni ad ambire a “pieni poteri”, ma semmai è la magistratura a volerli conservare.
La polemica ha riacceso il confronto su un tema che da decenni segna la dialettica tra politica e giustizia nel nostro Paese. Secondo Mantovano, e secondo buona parte della maggioranza, la riforma appena approvata non rappresenta affatto un tentativo di sottomettere la magistratura al potere esecutivo, ma un passo necessario per riequilibrare i rapporti tra i poteri dello Stato dopo anni in cui, a loro giudizio, la magistratura avrebbe esercitato un’influenza sproporzionata sulla vita politica.
La memoria collettiva torna inevitabilmente ai tempi di Tangentopoli, quando l’azione giudiziaria di Mani Pulite travolse partiti, leader e intere classi dirigenti, ridisegnando di fatto la geografia politica del Paese. Da allora, sostengono in molti nella maggioranza, la magistratura avrebbe continuato a condizionare la politica, influendo sulle carriere e sul destino dei governi attraverso inchieste e fughe di notizie, talvolta più con il potere mediatico che con quello giudiziario. La riforma della giustizia, al centro della prossima consultazione popolare, introduce due elementi cardine: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, ciascuno eletto con un sistema misto che prevede una quota di componenti estratti a sorte tra i magistrati.
Un meccanismo, quest’ultimo, pensato per ridurre l’influenza delle correnti interne alle toghe, che negli anni hanno acquisito un peso crescente nelle dinamiche di nomina, promozione e trasferimento dei magistrati, dando luogo a un sistema di potere parallelo spesso criticato anche dall’interno della stessa magistratura. La sinistra e gran parte dell’opposizione, tuttavia, vedono nella riforma un pericoloso tentativo di subordinare la funzione giudiziaria al controllo politico. Le accuse di “golpe bianco” e di violazione dello spirito della Costituzione si moltiplicano, con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra che denunciano il rischio di un’ingerenza dell’esecutivo nell’attività delle procure e di un indebolimento dell’indipendenza dei magistrati.
Secondo i critici, la separazione delle carriere – pur presentata come un principio di garanzia – in realtà potrebbe trasformare il pubblico ministero in una sorta di “avvocato dell’accusa” alle dipendenze del governo, il che snaturerebbe il ruolo di equilibrio che la magistratura ha sempre svolto.
Dal fronte opposto, il centrodestra ribatte che proprio la commistione tra giudici e pm ha alimentato negli anni una pericolosa confusione di ruoli e una spirale di autoreferenzialità che ha minato la fiducia dei cittadini nella giustizia. Meloni e i suoi ministri insistono sul fatto che la riforma non è contro i magistrati, ma a favore di una giustizia più trasparente, efficiente e imparziale, capace di distinguere nettamente tra chi accusa e chi giudica, come avviene in molte democrazie europee. Mantovano ha sottolineato che la polemica sui “pieni poteri” è una forzatura retorica: “Non è il governo che vuole i pieni poteri, ma chi teme di perderli dopo averli esercitati per decenni senza controllo democratico”. Parole che hanno suscitato nuove reazioni indignate tra le opposizioni, ma che fotografano con chiarezza l’impostazione politica della maggioranza: quella di una riforma che vuole restituire equilibrio e limitare le “zone grigie” di potere dentro la magistratura.
La battaglia referendaria, dunque, si preannuncia aspra e polarizzata, con un forte valore simbolico oltre che istituzionale. Da un lato, chi difende la necessità di “modernizzare” la giustizia per liberarla dalle incrostazioni corporative; dall’altro, chi teme che dietro il richiamo alla “riforma” si nasconda la volontà di ridurre gli spazi di autonomia della magistratura e di concentrare il potere decisionale nelle mani dell’esecutivo. In mezzo l’opinione pubblica, spesso disorientata da anni di scandali, di scontri tra procure e politica e di lentezze croniche del sistema giudiziario.
Il referendum offrirà agli elettori l’occasione di pronunciarsi su una materia complessa ma cruciale per l’equilibrio democratico del Paese. Quale che sia l’esito, la discussione sui “pieni poteri” difficilmente si esaurirà con il voto di primavera: essa tocca il nodo profondo del rapporto tra magistratura e politica, tra indipendenza e responsabilità, tra controllo e sovranità popolare. Una partita che, a oltre trent’anni da Tangentopoli, continua a dividere l’Italia, riflettendo una frattura che non è solo istituzionale ma anche culturale.