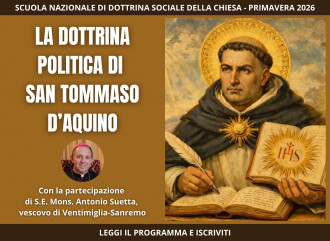La tela di Trump ridisegna il fronte euro-russo
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con il summit di Washington, Trump ha ottenuto il doppio obiettivo di incardinare ulteriormente il progressivo avvicinamento delle posizioni di Mosca e di Kiev, e nel contempo di "disciplinare" Ue e paesi Nato europei al suo progetto di gestione del dopoguerra.

Il coro dei media europei e global-progressiti, compattamente ispirato al più ostinato ed impermeabile anti-trumpismo, aveva dipinto il vertice di Anchorage tra Donald Trump e Vladimir Putin come un fallimento annunciato, o come un atto di sottomissione del presidente statunitense allo "zar" russo. E aveva previsto parimenti un esito inevitabilmente catastrofico per l'incontro di Washington tra Trump e Volodymyr Zelensky, allargato ai leader europei che avevano aderito. I più arditi si spingevano a pronosticare uno scontro al calor bianco in cui questi ultimi facevano da "pretoriani" al presidente ucraino, difendendolo strenuamente dalla "bullizzazione" da parte dell'inquilino della Casa Bianca e ponendosi di traverso rispetto alla presunta "svendita" dell'Ucraina alle mire degli invasori.
In realtà le cose in entrambi i casi sono andate in maniera molto diversa. I due meeting hanno costituito tappe di un robusto percorso diplomatico che non è affatto il frutto di un approccio velleitario, estemporaneo e guascone – secondo le letture caricaturali che spesso vengono date malevolmente della politica estera di Trump – ma risponde invece ad una visione complessiva di stabilizzazione non solo del fronte russo-ucraino, ma di tutto il contesto euro-asiatico e mediterraneo, che tiene in debito conto tutte le sue complessità, faglie conflittuali e intersezioni tra geopolitica, cultura ed economia.
Il vertice con Putin in Alaska è stato in tal senso non soltanto un punto di svolta nell'approccio a un possibile compromesso sul conflitto Kiev-Mosca, ma, molto più ampiamente (come sottolineato dalla "scenografia" dell'evento e dai suoi aspetti simbolici) l'inizio della ricostruzione di un sistema di relazioni tra Stati Uniti e Mosca: una ricostruzione ispirata dall'idea dell'esistenza di un campo di interessi politici ed economici comuni, e dall'aspirazione ad una regolare consultazione tra due potenze che, in un mondo divenuto decisamente multipolare, rappresentano ancora il cuore della deterrenza nucleare. Tale disegno viene perseguito da Trump non certo per "sudditanza" psicologica o condiscendenza nei confronti del leader russo, ma nella convinzione che allontanare la Russia dalla sottomissione alla Cina costituisce un obiettivo primario per gli interessi statunitensi e occidentali (inclusi quelli degli alleati europei) nell'ottica della polarizzazione mondiale Washington-Pechino, e un presupposto essenziale per l'edificazione di un sistema di pace, sicurezza comune e relazioni economiche sullo scacchiere euroasiatico, mediorientale e mediterraneo.
In tale contesto, come avevamo anticipato su queste pagine, la convocazione del faccia a faccia con Putin lasciava pensare che i due capi di Stato avessero già raggiunto un'intesa di massima sul compromesso possibile per porre fine al conflitto: riconoscimento di fatto alla Russia dei territori occupati, e forse di qualcuno tra quelli rivendicati, in cambio dell'accettazione da parte di Mosca di garanzie di sicurezza per l'Ucraina attraverso una sua sostanziale affiliazione occidentale, con l'ingresso nell'Ue e un apparato di difesa gestito da Stati Uniti e alleati Nato continentali. Una soluzione, quest'ultima, già da tempo suggerita proprio dalla premier italiana Giorgia Meloni – come a Washington la stessa non ha mancato di ricordare - attraverso la proposta di dotare l'Ucraina di uno scudo simile a quello dell'articolo 5 della Nato sulla mutua garanzia di difesa da parte dei membri contro aggressioni esterne.
Proprio la convergenza su quel criterio di fondo – pur con molti aspetti non secondari ancora da approfondire e definire – da parte di Putin e di Zelensky è stata la base su cui Trump ha potuto convocare il presidente ucraino a Washington una settimana dopo, accettando di buon grado la presenza di alcuni tra i principali leader europei. Alla Casa Bianca, in più momenti, è andata in scena non la rissa che i detrattori di Trump speravano di vedere, ma il secondo, importante segmento di avvicinamento all'intesa.
Da un lato, Zelensky ha pubblicamente convenuto sul fatto che le garanzie di sicurezza americane e occidentali rappresentino il punto cardine di una possibile pace "duratura" e sostenibile, pur mantenendo ancora comprensibilmente resistenze all'accettazione di qualsiasi cessione di territori, tanto più se non già militarmente occupati dalle truppe di Mosca.
Dall'altro, i leader europei – collocati in una scenografia che evidenziava la loro condizione di subalternità – hanno aderito complessivamernte, pur con varie sfumature, allo stesso schema, e hanno garantito la loro disponibilità a svolgere la loro parte. Alcuni, come Emmanuel Macron e Friedrich Merz, non hanno mancato di manifestare un atteggiamento più intransigente: il primo insistendo in una linea contraria alla logica dello "scambio di territori", il secondo continuando a chiedere un cessate il fuoco come premessa di ogni trattativa di pace. Ma si tratta di voci rimaste complessivamente marginali rispetto al clima di generale comunanza emerso tra le due sponde atlantiche dell'alleanza occidentale. E ancora più marginale è apparsa la presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ridotta quasi a un formale atto di presenza.
Sui prossimi passaggi del processo di pace permangono molti punti interrogativi: in particolare riguardo al previsto bilaterale tra Putin e Zelensky, e alle possibili impuntature dell'uno e dell'altro sullo statuto dei territori contesi. D'altro canto, però, ogni passaggio rende più costoso e rischioso per i contendenti far saltare il tavolo e tornare al punto di partenza, e cioè a una guerra ad oltranza e alle conseguenze pesanti di eventuali reazioni punitive da parte di Washington.
Con il summit di Washington, insomma, Trump ha ottenuto il doppio obiettivo di incardinare ulteriormente il progressivo avvicinamento delle posizioni di Mosca e di Kiev, e nel contempo di "disciplinare" Ue e paesi Nato europei al suo progetto di gestione del dopoguerra. Da tale punto di vista, le "garanzie" prospettate a Kiev nel vertice rappresentano anche la terza fase di un processo dialettico tra Stati Uniti e vecchio continente in cui il secondo ha dovuto sostanzialmente accettare le condizioni imposte dal primo su più fronti decisivi.
Nel giro di pochi mesi Trump ha ottenuto dagli alleati l'impegno ad aumentare le spese militari fino al 5% (acquistando dagli Stati Uniti anche armi da destinare all'Ucraina); ha siglato un accordo sui dazi che accoglie sostanzialmente le richieste americane; e ora prevede di devolvere ai paesi europei il "lavoro sporco" di spese e logistica della possibile tutela "simil-articolo 5" per Kiev, mantenendo la supervisione e la responsabilità politica dell'operazione. Contrariamente alle speranze di tutti gli "eurolirici" antitrumpiani, i leader del vecchio continente hanno fatto atto di vassallaggio, ottenendo come contropartita soltanto (ma non è poco) la conferma di una presenza attiva degli Usa sul teatro europeo e di una riproposizione, più realista ma più solida rispetto al recente passato, dell'alleanza occidentale.