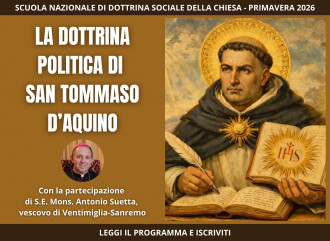In che modo i presocratici possono aiutare gli uomini d’oggi
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pur nei limiti di alcune tesi, questi filosofi ebbero il merito di voler rintracciare l’archè. Una lezione che può essere un farmaco per la società odierna votata al non senso e a digiuno di metafisica. Intervista al professor Fulvio Di Blasi, autore de L’invenzione della razionalità filosofica.
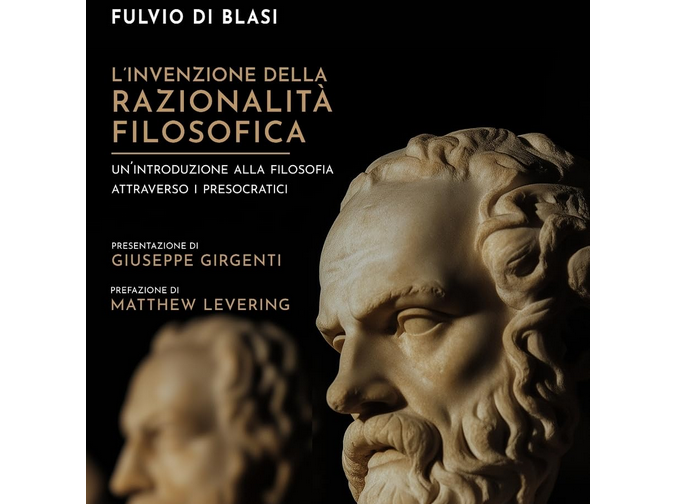
Ce lo ripetiamo spesso e da tempo. La gente ha perso il buon senso (che oggi non è il senso comune). Lo ha perso, aggiungiamo, perché non è capace più di ragionare. E non è capace più di ragionare perché non è più capace di leggere il reale per quello che è, di riconoscere la realtà nei suoi tratti essenziali evidenti e dunque nei suoi principi primi. In questo senso ci potrebbero aiutare i presocratici, filosofi greci vissuti tra il VI e il V secolo a.C., prima dunque di Socrate e Platone. Ebbero il merito, pur nei limiti evidenti di alcune tesi, di voler rintracciare l’archè, ossia il principio primo dell’universo, il logos che tutto governa e che dà unità formale e razionale a tutto. Filosofi che, potremmo dire oggi, indagarono la fisica del mondo e la metafisica che lo informa e lo trascende per comprenderne il senso profondo.
Capirete bene che i presocratici sono per certi versi antitetici allo spirito collettivo delle società occidentali, votate al non senso perché prive di visioni razionali e in specie metafisiche. E dunque, in tal prospettiva, la loro lezione può essere un farmaco efficace per i nostri contemporanei così smarriti, confusi ed emotivi. Ad averlo intuito è il professor Fulvio Di Blasi che ha dato alle stampe un volume dedicato proprio ai presocratici dal titolo L’invenzione della razionalità filosofica (Phronesis). Di Blasi è filosofo del diritto, membro del Comitato scientifico della Società italiana di medicina e ha insegnato filosofia in diverse università americane ed europee. È autore di centinaia di pubblicazioni.
Guerre, migrazioni, attacchi alla vita di ogni genere, disgregazione della famiglia, totalitarismo dei social, ateismo diffuso e pure la Chiesa non ha goduto di ottima salute nell'ultimo periodo. E lei scrive un libro sui presocratici. Non ci sono problemi ben più importanti e urgenti da affrontare anche per un filosofo?
Noi filosofi dobbiamo parlare di filosofia e raccoglierne i semi dove il terreno è più fecondo per trapiantarli poi con successo nel nostro giardino. Il mio non è un libro di storia né un modo per fuggire dai problemi che ci circondano. Anzi, uno dei leitmotiv del testo è l’approccio critico alla scienza e al nostro modo di rapportarci alla cultura. Al mondo di oggi servono bravi maestri e io ritengo che possiamo trovarli nei presocratici. Leggendoli nel modo giusto si iniziano a vedere in sovrimpressione i limiti e difetti della nostra società e possibili soluzioni. E lo si fa anche col piacere del fascino dei miti greci e di immagini suggestive che hanno impregnato l’intera civiltà occidentale. Ho dedicato il libro a mio figlio perché è il testo che spero leggerà con cura e passione appena avrà l’età giusta per il pensiero riflessivo. A me sarebbe piaciuto avere un libro così quando ero al liceo, perché può aiutare a riscoprire un approccio razionale, olistico, aperto ed etico alla realtà, e affrontare con spirito rinnovato le cose urgenti di cui lei parla. Più i problemi sono grandi più bisogna prendersi il tempo che serve per riflettervi su.
Leggendo il libro si potrebbe pensare che alla fine tutti noi siamo un po' presocratici ogni volta che ci poniamo alcune domande di fondo sulla nostra vita: è d'accordo oppure ritiene che anche questo minimo filosofare tra la gente sia ormai scomparso?
Non credo che l’uomo di oggi sia in grado di porsi le domande giuste e nel modo corretto. Tutti percepiamo le domande di fondo, certo, e tutti siamo un po’ filosofi cercandone le risposte, ma saper porre bene una questione, saper vedere dove sta il problema, spesso è già un trovarne la soluzione. Gli occhi delle persone di oggi è come se avessero perso alcuni decimi essenziali. Il pensiero lavora con immagini e bisogna riuscire a visualizzare i problemi attraverso immagini adeguate. Io cerco di fare vedere soprattutto che i primi pensatori, nonostante le differenze concettuali delle loro risposte filosofiche, erano capaci di osservare le questioni osservando la natura circostante, ed erano d’accordo su dove stesse il problema logico da risolvere. Se si riesce a vedere coi loro occhi, si riuscirà a partecipare all’impresa razionale che è la filosofia, che è come una droga positiva di cui non si riesce più a fare a meno. Bisogna riprendere un approccio alle domande di fondo che non sia solo poetico o intuitivo ma che accetti a 360 gradi la sfida del pensiero razionale e scientifico. Questa è la filosofia che dobbiamo imparare dai presocratici.
A cosa serve la filosofia all'ingegnere, all'imprenditore e all'impiegato? E a monte: ma serve a qualcosa la filosofia?
In parte ho già risposto. Tutti siamo oggi vittime di un approccio riduttivo alla realtà e al pensiero che ha investito negativamente e pesantemente le nostre discipline e attività. Noi siamo come pennelli che, muovendoci nelle nostre famiglie, nei nostri laboratori e uffici, nelle nostre aziende e parlamenti o aule di tribunale, lasciamo sotto di noi il dipinto di quello che portiamo nella nostra mente e nel nostro cuore. I nostri limiti e difetti toglieranno prospettiva e bellezza a quel dipinto, e i nostri amici e le persone che lo vedranno non vi troveranno lo stupore estatico positivo che avrebbero potuto vedere. Il rapporto con l’arte, la tecnica e la scienza e i difetti epistemologici della cultura di oggi sono temi di fondo del libro, ma i colori più importanti che esso può fornire a ingegneri, imprenditori o impiegati per dipingere meglio con le loro vite è proprio l’acquisizione di un approccio davvero razionale e scientifico alla realtà che il laboratorio dei presocratici può indubbiamente offrire.
Nel testo si parla della "logica del divenire". È un concetto solo filosofico oppure potrebbe avere anche una ricaduta pratica? Insomma si potrebbe dire che anche noi siamo immersi in questo flusso del divenire?
Tutti siamo immersi nel flusso del divenire. La natura è dinamica, non si ferma mai, e comprendere la logica e il senso di questo movimento è precisamente l’inizio del pensiero filosofico. Il divenire è la realtà, non appartiene alla filosofia. Comprenderne la logica, però, è compito della filosofia. Saperlo fare ci rende filosofi e ci rende migliori scienziati, ingegneri o professionisti perché ci insegna a pensare meglio, senza limiti ideologici o pregiudiziali. La ricaduta di questo concetto è assolutamente pratica, quanto lo è la mente per la vita umana.