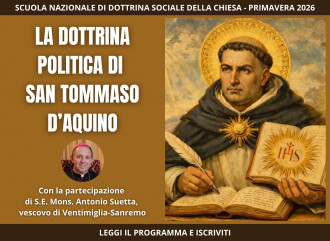Il caso Cavallari non è l'eccezione: aumentano le evasioni dal carcere
Ascolta la versione audio dell'articolo
Andrea Cavallari, condannato in via definitiva per aver provocato la strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (2018), si laurea, festeggia e sparisce. Non è l'unico caso di evasione. Vanno rivisti i metodi di rieducazione e reinserimento.

Ogni tanto succedono episodi disarmanti che alimentano la sensazione di vivere nella “Repubblica delle banane”. Andrea Cavallari, 26 anni, originario di Bomporto in provincia di Modena, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo – dove la notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018 morirono sei persone, tra cui cinque minorenni, per il panico scatenato dopo la spruzzata di spray al peperoncino durante un concerto di Sfera Ebbasta – risulta irreperibile da quasi cinque giorni.
La fuga, ingiustificata e allarmante, è iniziata al termine di un permesso di necessità concesso dal magistrato di sorveglianza del carcere della Dozza di Bologna, finalizzato a permettere a Cavallari di discutere la laurea in Scienze giuridiche presso l’Università di Bologna. Il permesso, ottenuto per la prima volta, era motivato come un evento eccezionale: la tesi, la proclamazione, un traguardo che faceva parte di un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale. In quella circostanza, il giovane è uscito senza scorta, accompagnato dai familiari: una scelta coerente con l’indirizzo giuridico che regola l’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, che mira a favorire la rieducazione dei detenuti tramite momenti di vita esterni controllati.
All’evento – come ha precisato il rettore dell’ateneo Giovanni Molari – le lauree fuori dal carcere avvengono raramente con scorta: di solito gli studenti studiano e discutono la tesi in strutture penitenziarie o online, ma la decisione spetta all’autorità giudiziaria. Nonostante la cornice formale della cerimonia, terminata con la proclamazione, mentre la compagna era in attesa e i familiari presenti, Cavallari si allontanava e scompariva nel nulla, facendo perdere ogni traccia. La famiglia, in particolare il patrigno, ha raccontato che durante la serata Andrea avrebbe detto di dover andare dalla fidanzata, ma poi non si è più visto né rintracciato.
«Sarebbe stato giusto avere almeno un poliziotto, in borghese o in divisa – ha dichiarato –, ma noi non riusciamo a gestirlo. Dopo quello che ha fatto non ci si può fidare di lui. Dico ad Andrea che se vuol tornare noi lo accoglieremo come prima. Meglio che torni». Dopo quasi cinque giorni, autorità e avvocati moltiplicano gli appelli pubblici, il più significativo dei quali arriva da Irma Conti, membro del collegio del Garante dei detenuti: «Dimostri che il suo è stato un atto di debolezza e non il fallimento del suo percorso trattamentale». Da più parti si rivendica, infatti, il valore del permesso come strumento di riabilitazione, ma con avvertenze: il caso Cavallari ha acceso i riflettori sull’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, una norma che prevede i permessi premiali per i detenuti ritenuti idonei a iniziare un percorso trattamentale e a reinserirsi. Come ha osservato la Conti, nel 2024, su oltre 35mila permessi concessi, le evasioni sono state appena 29: percentuale minima, ma sufficientemente significativa da alimentare un dibattito pubblico.
È una riflessione importante, perché il successo dei permessi non può essere messo in discussione da episodi negativi, ma nemmeno ignorato: serve equilibrio fra fiducia e controlli. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha subito richiesto una relazione alla Dozza, al fine di verificare modalità, eventuali omissioni o procedure non correttamente adottate e far luce sulla gestione della sorveglianza durante la cerimonia. Il report, atteso entro poche ore, sarà esaminato dal ministero della Giustizia per eventuali modifiche procedurali. Al contempo, il sindacato di polizia penitenziaria non ha risparmiato dure critiche, affermando che si tratta “solo dell’ultimo caso di fuga”, denunciando un aumento vertiginoso delle evasioni, con un incremento del 700% rispetto all’anno precedente: circa 340 casi solo nell’ultimo anno, includendo evasioni dal carcere e altri tipi di fuga. Il dato è preoccupante: seppure i permessi restino numeri strettamente minoritari rispetto alle evasioni, l’aumento globale solleva nuovi interrogativi sul sistema di sicurezza penitenziaria, sulle risorse umane e strumentali, sulla formazione e motivazione del personale e sulla fragilità di un equilibrio fra diritti da garantire ai detenuti e rischio di recidiva o fuga. In altri termini, se il percorso di studio, lavoro, applicazione di corsi trattamentali è un argomento credibile per una riabilitazione, l’esperienza di Cavallari dimostra come fragili possano essere i dispositivi di prevenzione, a meno di investire in formazione degli operatori, valutazioni individuali più stringenti o presidi di sorveglianza anche quando le direttive sembrano ridondanti.
L’assenza di una scorta, in presenza di una persona con condanna confermata per strage, è oggetto di critiche, pur nel rispetto delle competenze del magistrato. Il bilancio fra umanizzazione della pena, reinserimento sociale e tutela della sicurezza pubblica resta insomma critico: è necessario ritrovare un punto di sintesi che non mortifichi la normativa trattamentale, ma renda il regime di uscita più robusto.
Infine, la vicenda mette in discussione la fiducia nei canali di rieducazione e reinserimento. Di fronte a numeri che crescono, il legislatore, gli operatori, i giudici di sorveglianza e i garanti devono confrontarsi su come migliorare protocolli, formazione e strumenti di valutazione. In definitiva, la fuga di Andrea Cavallari è una vicenda singolare per la natura del reato, i tempi e le modalità del permesso e la laurea ottenuta, ma allo stesso tempo è il sintomo di un malessere sistemico: la rieducazione penitenziaria deve restare un valore, ma per sopravvivere deve dotarsi di controlli efficaci e selettività rigorosa, altrimenti ogni buon risultato terapeutico può trasformarsi in uno strumento di rischio.