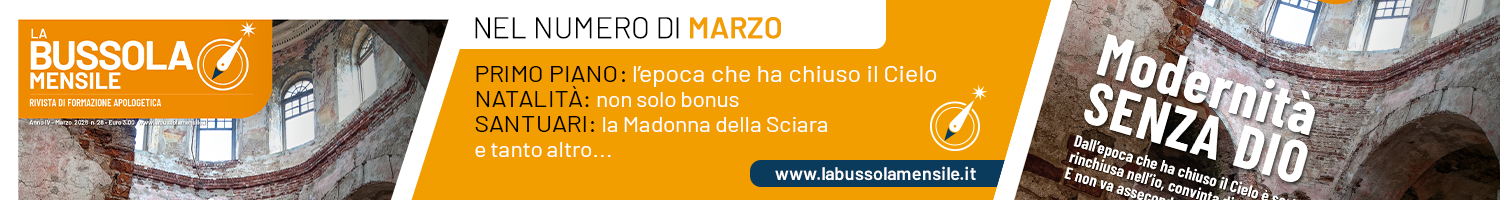I Promessi Sposi. Dietro le quinte del grande romanzo
Due antenati del Manzoni implicati in misfatti del Seicento, con due destini diversi: da un lato Bernardino Visconti (l’Innominato), dall’altro Giacomo Maria Manzoni, morto dopo l’accusa dell’ennesimo delitto. Ciò influì sulla nascita del capolavoro manzoniano? Il libro “I Promessi Sposi. Dietro le quinte del grande romanzo” avanza delle ipotesi.

I Promessi Sposi riesumano un Seicento che vide due antenati del Manzoni implicati in misfatti dell’epoca, due antenati che ebbero due destini ben diversi: Bernardino Visconti (nel romanzo l’Innominato) si convertì e si dedicò ad opere buone per espiare il male compiuto; Giacomo Maria Manzoni, proprietario della villa di Lecco ereditata dallo scrittore e impenitente fino alla fine, morì nel 1642, ancora sotto processo, accusato di un ennesimo delitto. Manzoni provava vergogna per i suoi antenati? Sentiva l’esigenza di espiare il male compiuto da Giacomo Maria? La scoperta delle origini infami della sua famiglia potrebbe essere la scaturigine della composizione del romanzo e della scelta del Seicento come epoca congeniale all’ambientazione della storia. E allora potrebbero sorgere alcune domande: se il manoscritto ritrovato alludesse in realtà ai documenti relativi alla storia dell’antenato lecchese? Oppure se il manoscritto fosse davvero esistito come testimonierebbe una lettera di Manzoni inviata all’amico Grossi (di cui non ci è rimasto l’autografo), pubblicata sulla rivista «La scintilla» nel 1888? Sono solo supposizioni non dimostrabili o anche realtà? Forse queste domande possono offrire un terreno nuovo d’indagine sul capolavoro manzoniano. Un fatto è certo: non sono pochi gli spunti che le vite dell’Innominato e di Giacomo Maria Manzoni offrono alla storia.
Pubblichiamo di seguito il 33° capitolo del libro di Giovanni Fighera, I Promessi Sposi. Dietro le quinte del grande romanzo (Sugarco).
***
L’UNTORE E MANDANTE DI OMICIDI GIACOMO MARIA MANZONI E LA STORIA DELLA COLONNA INFAME (capitolo 33)
Milano, 1630.
Nel 1818 Alessandro Manzoni vendette i possedimenti lecchesi e la villa Caleotto a Giuseppe Scola per stabilirsi definitivamente a Milano nella casa di via Morone. Scrive Barbiera ne Il salotto della Contessa Maffei:
Uno dei motivi della vendita fu che il Manzoni voleva sottrarsi alla dipendenza da un amministratore impostogli dal padre nel lasciargli, morendo, quei beni. Il Manzoni si pentì amaramente di avere venduto la tomba di colui del quale portava il nome. Egli soffriva, tutte le volte che ripensava al Caleotto. Quando l’ingegner Scola, nuovo proprietario del palazzo, si recò a Milano e a Brusuglio per avere dal Manzoni chiarimenti sopra certi diritti d’acqua, gli disse ossequioso che, se avesse voluto ritornare a dimorare qualche tempo al Caleotto, sarebbe stato un grande onore per lui ospitarlo.
La villa di Lecco era da due secoli proprietà dei Manzoni. Il primo a stabilirvisi fu Giacomo Maria Manzoni, vissuto tra il 1576 e il 1643, parente dell’autore dei Promessi sposi. Accumulò un vasto patrimonio costituito da fucine, opifici, altiforni e divenne il maggiore imprenditore siderurgico nel ducato di Milano.
Signorotto prepotente che amava attorniarsi di bravi, subì numerosi processi come mandante di omicidi. Durante la peste del 1630 fu accusato di aver pagato due monatti per ungere le porte dei suoi concorrenti per diffondere la peste. Se i due monatti furono condannati a morte, Giacomo Maria Manzoni fu scagionato nel processo condotto dal Senato di Milano. Morì nel 1642, di nuovo implicato in un processo come mandante di un omicidio.
L’antenato del Manzoni aveva combattuto per tanti anni contro i concorrenti nell’ambito della siderurgia avvalendosi di bravi, di sicari e di avvocati.
Nel XVIII secolo i Manzoni indirizzarono maggiormente i propri interessi sulle rendite fondiarie acquistando terre ed esaltando così la condizione nobiliare della famiglia.
La vicenda dell’antenato di Manzoni sintetizza in sé due importanti motivi dei Promessi sposi: la prepotenza dei signori che abitavano quel territorio nel Seicento e la caccia agli untori che caratterizzò quel periodo.
Potrebbe essere proprio la storia dell’antenato ad aver ispirato ad Alessandro Manzoni il tema conduttore del romanzo.
Nei Promessi sposi vengono riportati diversi racconti sull’origine della credenza sugli untori. Il primo di cui parlano il medico Tadino e lo storico Ripamonti (relativo addirittura al 1629) riferisce di quattro francesi «ricercati come sospetti di spargere unguenti velenosi». Manzoni riporta un dispaccio sottoscritto addirittura dal re Filippo IV con l’obiettivo di mettere in cattiva luce i francesi in Lombardia. Recenti studi hanno dimostrato che tale dispaccio non è mai esistito, nato dalle dicerie popolari in seguito all’arresto di due frati francesi (febbraio 1629).
Il secondo episodio racconta che persone spargevano unguento su un assito che divideva gli spazi per uomini e donne nel Duomo di Milano la sera del 17 maggio 1630. Il presidente della sanità, accorso per verificare i sospetti, non trovò nulla che li confermasse.
Terza circostanza è la vista di porte e muraglie imbrattate, «intrise di non so che sudiceria». Lo storico Ripamonti, che non crede alla superstizione degli untori, afferma però di aver visto con i suoi stessi occhi «quell’impiastramento»:
Queste macchie erano sparse e sgocciolanti in diversi modi, come se qualcuno avesse imbevuta una spugna di marcia, appiccicandola alle mura. Anche le porte delle casi e gli usci si spargevano qua e là bruttate. Funesto delitto di recente commesso quasi per insultare il popolo, e che io pure andai a vedere.
Probabilmente ci furono persone che cercarono di diffondere il terrore e ciò accrebbe dicerie e superstizioni sugli untori. La credenza che ci fossero gli untori non era certo nata nel Seicento, era già presente nei secoli precedenti:
I processi che ne vennero in conseguenza, non eran certamente i primi d’un tal genere: e non si può neppur considerarli come una rarità nella storia della giurisprudenza. Chè, per tacere dell’antichità, e accennar solo qualcosa de’ tempi più vicini a quello di cui trattiamo, in Palermo, del 1526; in Ginevra, del 1530, poi del 1545, poi ancora del 1574; in Casal Monferrato, del 1536; in Padova, del 1555; in Torino, del 1599.
Nel 1630 il tribunale della sanità arrivò ad emanare una grida in cui si prometteva un premio a chi avesse reso noti gli autori di quei misfatti, in pratica a chi avesse denunciato gli untori.
Il popolo si divideva tra coloro che credevano alla loro esistenza e che li additavano come colpevoli di propagare il contagio e chi ancora non dava credito alla peste. Per togliere ogni dubbio il tribunale della sanità espose alla vista di tutti una famiglia morta di peste durante una processione nelle feste della Pentecoste.
Il cambiamento del lessico per designare la peste in quei mesi mostra la graduale presa di consapevolezza della sua esistenza: all’inizio non si poteva pronunciare il vocabolo, poi si fece riferimento a febbri pestilenziali, poi ancora si disse che si trattava non di una vera peste, poi di peste, ma in un certo senso, infine di peste senza dubbio.
Nel Fermo e Lucia Manzoni racconta tutta la vicenda del processo agli untori in maniera attendibile rifacendosi a documenti storici.
Nei Promessi sposi l’autore elimina la lunga digressione, ritenendo che appesantisca la lettura del romanzo, e fa un rapido riferimento a quell’iniquo processo solo nel capitolo XXXII. Manzoni anticipa che del processo agli untori tratterà in altra sede nel trattato storico La storia della colonna infame in cui ricostruisce le tragiche vicende capitate a Milano a Guglielmo Piazza, commissario di sanità, e a Giangiacomo Mora, barbiere, accusati di essere untori, torturati e condannati a morte nel 1630.
Nell’introduzione del trattato Manzoni spiega come nacque la colonna infame:
Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati d’aver propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d’aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de’ supplizi, la demolizion della casa d’uno di quegli sventurati, decretaron di più, che in quello spazio s’innalzasse una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame, con un’iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia dell’attentato e della pena. E in ciò non s’ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile.
Manzoni riconosce di aver preso spunto dalle Osservazioni sulla tortura di Pietro Verri, il cui intento è, però, differente:
Pietro Verri si propose, come indica il titolo medesimo del suo opuscolo, di ricavar da quel fatto un argomento contro la tortura, facendo vedere come questa aveva potuto estorcere la confessione d’un delitto, fisicamente e moralmente impossibile. E l’argomento era stringente, come nobile e umano l’assunto.
Manzoni non condivide in maniera integrale l’impostazione del discorso di Verri. Il romanziere è, infatti, uno strenuo difensore della libertà umana, fermamente convinto che esista una responsabilità personale dei giudici, che non sono immuni da colpe, anche se vissuti in un’epoca d’ignoranza e di superstizione come il Seicento, perché ogni uomo è libero, in qualsiasi contesto culturale viva e malgrado tutti i condizionamenti esterni. Verri individua talvolta l’errore personale dei giudici, ma non sottolinea che è esso è in realtà il vero responsabile dell’ingiustizia commessa nel processo.
Come mai vennero accusati Piazza e Mora? Cosa accadde? Leggiamo ne La storia della colonna infame:
La mattina del 21 di giugno 1630, verso le quattro e mezzo, una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi, per disgrazia, a una finestra d’un cavalcavia che allora c’era sul principio di via della Vetra de’ Cittadini, dalla parte che mette al corso di porta Ticinese (quasi dirimpetto alle colonne di san Lorenzo), vide venire un uomo con una cappa nera, e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, sopra la quale, dice costei nella sua deposizione, metteva su le mani, che pareua che scrivesse. Le diede nell’occhio che, entrando nella strada, si fece appresso alla muraglia delle case, che è subito dopo voltato il cantone, e che a luogo a luogo tirava con le mani dietro al muro. […] Presa da un tal sospetto, passò in un’altra stanza, che guardava lungo la strada, per tener d’occhio lo sconosciuto, che s’avanzava in quella; et viddi, dice, che teneua toccato la detta muraglia con le mani.
Anche un’altra donna, che era alla finestra, affermava di aver visto quell’uomo ungere il muro. Si chiamava Ottavia Boni. Diffusasi la voce, venne arrestato Guglielmo Piazza, commissario di sanità, deputato al controllo dell’igiene delle strade, venne bruciato e di nuovo imbiancato il muro su cui l’untore avrebbe sparso la sostanza pestifera.
 Interrogato dai giudici, indotto a contraddizioni, Piazza non riconobbe la sua colpa, all’inizio. Solo dopo la promessa dell’impunità, con l’inganno gli venne estorta la confessione, purché rivelasse i complici. Gli venne l’idea di incolpare il barbiere Giangiacomo Mora, noto per i suoi antidoti alla peste. In casa sua vennero ritrovate sostanze untuose e la loro ricetta. Arrestato il barbiere, Mora venne sottoposto a tortura insieme a Piazza. Le loro confessioni furono contrastanti. Dopo settimane di tortura, i due furono condannati a morte. L’esecuzione, fissata per il primo agosto 1630, fu terribile e venne incisa su un’epigrafe apposta alla colonna infame:
Interrogato dai giudici, indotto a contraddizioni, Piazza non riconobbe la sua colpa, all’inizio. Solo dopo la promessa dell’impunità, con l’inganno gli venne estorta la confessione, purché rivelasse i complici. Gli venne l’idea di incolpare il barbiere Giangiacomo Mora, noto per i suoi antidoti alla peste. In casa sua vennero ritrovate sostanze untuose e la loro ricetta. Arrestato il barbiere, Mora venne sottoposto a tortura insieme a Piazza. Le loro confessioni furono contrastanti. Dopo settimane di tortura, i due furono condannati a morte. L’esecuzione, fissata per il primo agosto 1630, fu terribile e venne incisa su un’epigrafe apposta alla colonna infame:
Qui dove si apre questo spiazzo sorgeva un tempo la bottega di barbiere di Giangiacomo Mora che, con la complicità di Guglielmo Piazza commissario di pubblica sanità e di altri scellerati nell’infuriare più atroce della peste aspergendo di qua e di là unguenti mortali procurò atroce fine a molte persone. Entrambi giudicati nemici della patria il Senato decretò che issati su un carro e dapprima morsi con tenaglie roventi e amputati della mano destra avessero poi rotte le ossa con la ruota e intrecciati alla ruota fossero. Trascorse sei ore, scannati quindi inceneriti e perché nulla restasse di uomini così delittuosi stabilì la confisca dei beni, le ceneri disperse nel fiume.
La colonna fu eretta nel luogo dove c’era la casa del Mora, abbattuta dopo il processo. Venne distrutta solo nel 1778. A ricordo di questa storia rimase solo l’epigrafe ancora ben conservata al Castello Sforzesco di Milano.