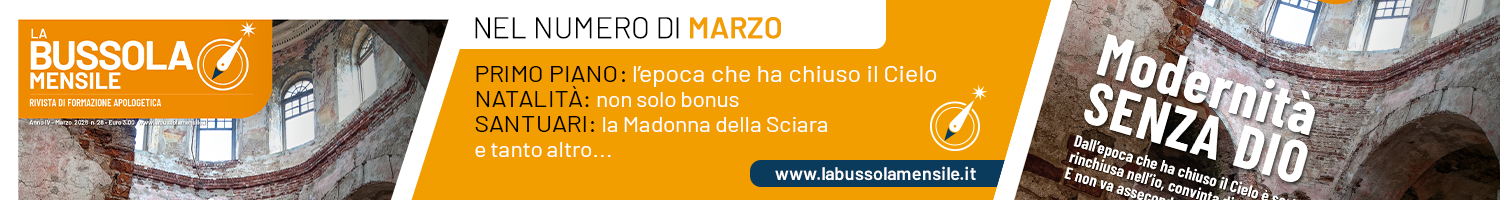Fra gli alawiti in Libano in fuga dalle persecuzioni siriane
Mentre in Francia, Macron incontra l'auto-nominato premier al Sharaa, in Siria continuano le uccisioni, i rapimenti, gli stupri di massa a danno delle minoranze religiose. La Nuova Bussola Quotidiana ha incontrato nel nord del Libano i profughi alawiti in fuga dal governo di Damasco.

Sin dalla conquista del potere in Siria l'8 dicembre scorso, i fondamentalisti islamici di Hayat Tahrir al Sham guidati da Ahmed al Sharaa hanno rassicurato a parole, minacciato nei fatti le minoranze religiose, fino a mettere in atto un'operazione francamente genocidaria a partire dal marzo scorso. L'espressione "operazione genocidaria" non è qui usata a caso, ma rispecchia fedelmente la realtà dei fatti: in poco meno di tre mesi le milizie appoggiate da HTS si sono concentrate sullo sterminio su base etnico-religiosa di migliaia (non c'è una stima esatta, alcune fonti parlano di quasi ventimila) di uomini, donne e bambini di fede alawita, drusa e cristiana. Non c'è regione della Siria che sia stata risparmiata da omicidi, torture, rapimenti, stupri, riduzione in schiavitù: dalle aree alawite dell'ovest del Paese a quelle druse del sud est, ai villaggi cristiani disseminati un po' ovunque sul territorio siriano, non c'è comunità che non abbia pianto vittime. I fortunati che sono riusciti a sfuggire alla mattanza rifugiandosi nei boschi hanno avuto le proprietà confiscate, le case distrutte, i luoghi di preghiera profanati e resi inutilizzabili.
Dalla regione di Latakia e Tartous, sulla costa ovest, centinaia di persone di fede alawita scampate alla morte stanno attraversando illegalmente il confine con il Libano per raggiungere la vicina Tripoli, seconda città del Paese dei Cedri e capoluogo del Governatorato del nord. A netta predominanza sunnita, Tripoli accoglie fin dal sedicesimo secolo la maggior parte dei centocinquantamila alawiti presenti in territorio libanese.
 In un caffè nel centro di Tripoli incontriamo Ali, trentasettenne alawita libanese vicepresidente dell'associazione AICA (Alawite Islamic Charity Association), che si sta prodigando per accogliere i correligionari in fuga da HTS. Ali ci porta a conoscere i "newcomers", come dice, appena giunti dalla Siria con i soli abiti che indossano. La prima tappa è una moschea di Jabal Mohsen, al momento adibita a rifugio per i profughi. Il piano inferiore è riservato agli uomini, quello superiore alle famiglie. Ci troviamo davanti a persone di ogni età, che occupano ciascuna lo spazio di un sacco a pelo; hanno poca voglia di parlare, ma per loro parlano gli occhi pieni di stanchezza e disperazione. Ognuno di loro ha perso almeno un membro della famiglia: chi la madre, chi il padre, chi entrambi, chi i fratelli, i figli, i cugini, i nonni, gli zii. La moschea accoglie un centinaio di persone; chiediamo ad Ali come è organizzata la macchina dell'assistenza:
In un caffè nel centro di Tripoli incontriamo Ali, trentasettenne alawita libanese vicepresidente dell'associazione AICA (Alawite Islamic Charity Association), che si sta prodigando per accogliere i correligionari in fuga da HTS. Ali ci porta a conoscere i "newcomers", come dice, appena giunti dalla Siria con i soli abiti che indossano. La prima tappa è una moschea di Jabal Mohsen, al momento adibita a rifugio per i profughi. Il piano inferiore è riservato agli uomini, quello superiore alle famiglie. Ci troviamo davanti a persone di ogni età, che occupano ciascuna lo spazio di un sacco a pelo; hanno poca voglia di parlare, ma per loro parlano gli occhi pieni di stanchezza e disperazione. Ognuno di loro ha perso almeno un membro della famiglia: chi la madre, chi il padre, chi entrambi, chi i fratelli, i figli, i cugini, i nonni, gli zii. La moschea accoglie un centinaio di persone; chiediamo ad Ali come è organizzata la macchina dell'assistenza:
«La comunità alawita ha messo a disposizione la moschea, la Caritas i pasti, che vengono recapitati due volte al giorno» risponde. «Via via che le persone arrivano da noi le segnaliamo alla Croce Rossa, che le iscrive in un elenco». E la polizia e la municipalità di Tripoli non registrano i nuovi arrivati? Ali sembra stupito dalla domanda: «Si tratta di arrivi illegali, che le istituzioni libanesi tollerano ma non registrano. È la stessa modalità che il governo ha adottato con le centinaia di migliaia di siriani arrivati in Libano a partire dalla guerra civile del 2011 e con i loro figli nati qui: nessuna registrazione, di fatto la maggioranza di queste persone è "stateless" e se ne occupano solo le ONG».
Dalla moschea ci dirigiamo verso la sede di un gruppo scout adibita a rifugio per gli sfollati; si tratta di un seminterrato, in questo caso riservato a soli uomini, un altro centinaio. Anche qui non occorre fare domande per percepire la disperazione nell'aria. Un uomo mi parla delle figlie rimaste in Siria, Angela e Malak, i cui nomi ha tatuati sulle braccia.
Lasciamo la sede scout per dirigerci verso un centro rifugiati in allestimento, situato al piano inferiore della principale  moschea alawita di Jabal Mohsen. «Il terreno per costruire la moschea fu acquistato dalla comunità grazie all'aiuto di un sunnita», commenta Ali. Accediamo ad un'ambiente ben più spazioso di quelli visitati prima; c'è luce che filtra dalle finestre e nell'aria si sente un buon odore di legno. «Grazie a Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati che ci ha fornito i materiali, e al lavoro di tanti volontari, stiamo dividendo l'ambiente in stanze separate da assegnare alle famiglie. Stiamo costruendo i bagni per gli uomini e per le donne, ci sarà posto per tante persone». Ad accoglierci con trapano e seghetto c'è Abbas (nome di fantasia), un giovane che fino a poco tempo fa studiava ingegneria biomedica all'Università di Tartous, rifugiato qui con i genitori. Ha lo sguardo perso di chi ne ha viste tante, ma si vede che lavora volentieri. «La sua famiglia era molto ricca», mi racconta Ali. «Ora ha dovuto interrompere gli studi e ci dà una mano qui».
moschea alawita di Jabal Mohsen. «Il terreno per costruire la moschea fu acquistato dalla comunità grazie all'aiuto di un sunnita», commenta Ali. Accediamo ad un'ambiente ben più spazioso di quelli visitati prima; c'è luce che filtra dalle finestre e nell'aria si sente un buon odore di legno. «Grazie a Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati che ci ha fornito i materiali, e al lavoro di tanti volontari, stiamo dividendo l'ambiente in stanze separate da assegnare alle famiglie. Stiamo costruendo i bagni per gli uomini e per le donne, ci sarà posto per tante persone». Ad accoglierci con trapano e seghetto c'è Abbas (nome di fantasia), un giovane che fino a poco tempo fa studiava ingegneria biomedica all'Università di Tartous, rifugiato qui con i genitori. Ha lo sguardo perso di chi ne ha viste tante, ma si vede che lavora volentieri. «La sua famiglia era molto ricca», mi racconta Ali. «Ora ha dovuto interrompere gli studi e ci dà una mano qui».
La nostra visita si conclude presso la sede dell'associazione, dove alcuni giovani volontari stanno accogliendo i nuovi arrivati. Mentre parliamo si presenta un ragazzo riccioluto, magro, dall'aria spaurita; si vede che è stanchissimo, quasi non si regge in piedi. «I rifugiati continuano ad arrivare senza sosta», chiosa Ali. «Finché le cose in Siria stanno così è impensabile che possano ritornare a casa, dunque stiamo organizzando programmi rivolti almeno ai bambini, per sopperire in parte alla mancanza della scuola».