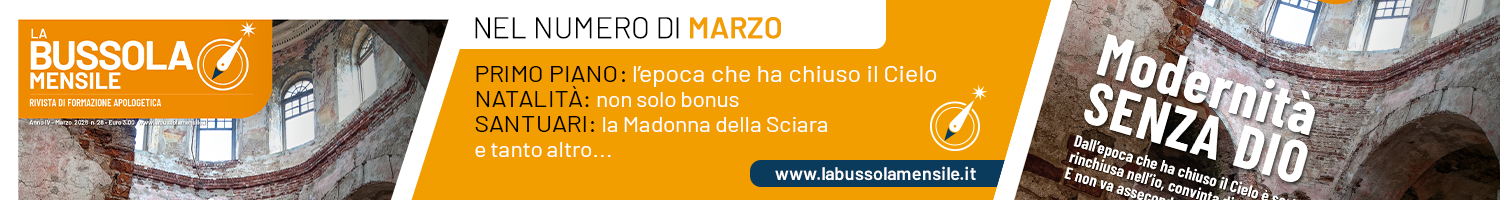Danni ai minori, storico processo ai social
Ascolta la versione audio dell'articolo
Per la prima volta Facebook, Instagram, TikTok e YouTube si trovano sul banco degli imputati con l’accusa di aver progettato consapevolmente tecnologie capaci di generare dipendenza e di danneggiare la salute mentale degli utenti più giovani.

Negli Usa, davanti alla Corte di Los Angeles si è aperto ieri un processo destinato a segnare un passaggio decisivo nel rapporto tra cittadini e piattaforme digitali. Per la prima volta, Meta (proprietaria di Facebook e Instagram), ByteDance (TikTok) e Google (YouTube) si trovano sul banco degli imputati con l’accusa di aver progettato consapevolmente tecnologie capaci di generare dipendenza e di danneggiare la salute mentale degli utenti più giovani.
Al centro del procedimento c’è il caso di una ragazza di 19 anni che afferma di aver sviluppato una forma di dipendenza e sintomi depressivi proprio a causa delle dinamiche algoritmiche adottate da queste piattaforme. Secondo l’accusa, strumenti come lo scroll infinito, le notifiche continue e i sistemi di raccomandazione dei contenuti non sarebbero effetti collaterali neutri, ma componenti deliberatamente pensate per massimizzare il tempo di permanenza e l’interazione, a scapito del benessere psicologico degli utenti. Un ecosistema costruito per trattenere l’attenzione il più a lungo possibile, fino a trasformarla in merce e per ridurre l’identità personale a un prodotto.
Il processo, tuttavia, non riguarda soltanto la richiesta di risarcimenti economici, ma assume un valore educativo e culturale, visto che mette in discussione l’idea che le piattaforme possano considerarsi irresponsabili rispetto agli effetti dei propri strumenti. Se un’azienda crea degli ambienti che favoriscono dipendenza, isolamento, ansia o comportamenti autolesionistici, deve prevedere tutele, segnalazioni di rischio, limiti di utilizzo e procedure di intervento. Non si tratta di censura ma del riconoscimento di un principio elementare, ovvero che la libertà tecnologica, quando è priva di responsabilità, rischia di trasformarsi in abuso.
Negli ultimi anni, infatti, numerosi studi hanno evidenziato come diverse funzionalità dei social network, dall’autoplay dei contenuti al feedback immediato dei like, attivino nel cervello meccanismi simili a quelli delle gratificazioni intermittenti, paragonabili a quelli delle slot machine o delle dipendenze da sostanze. Dinamiche che non si riducono a un semplice uso eccessivo, ma che coinvolgono i sistemi cerebrali legati alla ricompensa, alla motivazione e all’autostima.
Tuttavia, sarebbe riduttivo leggere questo processo come una battaglia che riguarda esclusivamente i minori. È vero che bambini e adolescenti sono più esposti, ma la dipendenza digitale è un fenomeno trasversale. Il bisogno di riconoscimento, l’ansia di visibilità, la paura di essere esclusi non scompaiono con il raggiungimento della maggiore età. Gli adulti non sono immuni e spesso risultano persino più vulnerabili perché meno educati a un uso critico e consapevole delle tecnologie.
La cronaca recente offre degli esempi drammatici: genitori travolti da campagne di odio online, vittime di gogna social che distruggono una reputazione in poche ore, se non addirittura in pochi minuti. Coppie spinte a gesti estremi dopo essere state sommerse da commenti, accuse e contenuti manipolati, senza strumenti interiori o sociali per reggere la pressione. Vicende che mostrano come la violenza digitale non sia affatto virtuale, ma incida concretamente sul corpo e sulla psiche delle persone.
Il processo americano diventa così uno specchio per l’intera società. Non riguarda soltanto il diritto dei ragazzi a non essere sfruttati commercialmente, ma anche il diritto di ogni persona a non essere ridotta a bersaglio o a merce. È un invito a ripensare l’ecosistema comunicativo in cui viviamo. Non possiamo delegare alle piattaforme la formazione emotiva e relazionale delle nuove generazioni, né accettare che l’arena digitale sostituisca senza regole la società.
Inoltre, c’è un nodo educativo che interpella famiglie, scuole e comunità. Le cause legali possono imporre correttivi tecnici, ma non sostituiscono la costruzione di una coscienza critica. Se i social creano dipendenza è anche perché intercettano un vuoto di relazioni autentiche, di silenzio, di tempo libero non colmato. Contrastare la dipendenza digitale significa proporre alternative di senso, come lo sport e le relazioni reali, e insegnare che non tutto ciò che è condivisibile merita di essere condiviso, e che il valore di una persona non è misurato dai suoi follower.
Pertanto il processo apertosi ieri a Los Angeles mette in discussione un mito dominante, ovvero quello della tecnologia neutrale. Non esistono strumenti neutri quando sono progettati per orientare comportamenti, e riconoscerlo è il primo passo per restituire centralità alla persona. Se i tribunali stabiliranno una responsabilità diretta delle piattaforme per i danni prodotti, non sarà solo una vittoria giuridica ma anche antropologica perché l’uomo non è un dato da monetizzare, ma un soggetto da proteggere.
In gioco non c’è soltanto la regolazione dei social network ma c’è il tipo di società che vogliamo costruire nell’era digitale: una giungla in cui sopravvive chi urla più forte oppure uno spazio comune dove la tecnologia è al servizio della dignità umana. La vera sfida, infatti, non è solo tecnologica ma anche culturale; è necessario recuperare relazioni autentiche e una percezione di sé che non dipenda solamente da numeri, “mi piace” o visualizzazioni.
In tal senso, il processo americano può essere visto come un campanello d’allarme e, se accolto con uno sguardo critico e costruttivo, come un’opportunità per una società che sta attraversando la rivoluzione digitale senza possedere ancora una bussola.