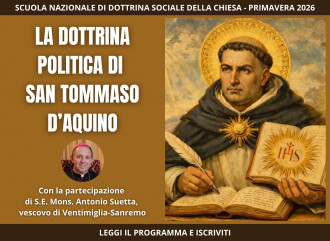Crisi Ucraina, le domande che deve farsi l'Europa
Ascolta la versione audio dell'articolo
Le fragili possibilità di un accordo tra Russia, Stati Uniti ed Ucraina per porre fine alla guerra sono l'occasione per farsi delle domande sul ruolo dell'Europa e su come potrà garantire in futuro la sicurezza. Lettera di Alberto Leoni e risposta del direttore Riccardo Cascioli.

Caro direttore,
la lettura del tuo editoriale del 19 agosto suggerisce di dare più forza a quella virtù che è la Speranza. Una speranza di pace per l’Ucraina che pare confermata dal tono degli incontri di Washington tra Trump e Zelenski con alcuni leaders europei, amichevole quasi quanto quello ad Anchorage con Putin. La missione di Trump è di difficoltà estrema ed è comprensibile come il Presidente degli Stati Uniti cerchi, con le buone maniere, di portare le parti a negoziare. D’altra parte anche i pregiudizi sulla qualità degli accordi di pace finora negoziati da Trump devono cedere il passo alla speranza di un miracolo. Secondo un detto americano “se è stupido ma funziona vuol dire che non è stupido” ed è questo che ogni uomo di buona volontà deve continuare a sperare: che Trump faccia un capolavoro diplomatico.
Questo perché, come si è detto, le difficoltà sono quasi insormontabili e nessuna delle due parti è disposta a cedere di un millimetro. E, tuttavia, perché dovrebbero cedere prima ancora di sedersi a un tavolo di trattativa? Così mentre Zelenski ha fatto statuire che nessun territorio sarà ceduto, identica cosa ha fatto Putin con le quattro regioni da lui invase, di cui solo il Luhansk conquistata totalmente, tutte integralmente dichiarate come facenti parte della Federazione russa.
Nel memorandum russo presentato a Istanbul nel giugno scorso le condizioni erano pesantissime:
1) Oltre al riconoscimento della cessione della Crimea, ritiro ucraino da Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson e cioè anche da quelle parti non ancora conquistate dai russi. Ciò equivarrebbe a rinunciare al Dnepr come linea difensiva e alle fortificazioni del Donetsk. Ed è in questo senso che Zelenski ha parlato di impossibilità di “regalare” ai russi territorio vitale e non ancora conquistato da essi.
2) Cessazione di forniture di armi occidentali e riduzione delle forze armate ucraine oltre a rinuncia ad entrare nella NATO
3) Elezioni entro cento giorni dopo la revoca della legge marziale e trattato di pace solo dopo il loro esito
4) Fine delle sanzioni
5) Ritorno del russo come lingua ufficiale dello stato ucraino
6) Restituzione di appena dieci bambini ucraini in quanto la Russia nega qualsiasi deportazione di minori
7) Nel frattempo cessazioni del fuoco limitate solo su alcuni tratti del fronte
Interessante notare come, ad Anchorage i russi hanno proposto agli ucraini di ritirarsi solo da Donetsk, congelando il fronte su Kherson e Zaporizhia. È Donetsk, infatti, il punto cruciale del fronte.
A fronte di ciò l’auspicio di pace di Leone XIV è che sia “autentica, giusta e duratura”. Ognuno sa bene come la giustizia non potrà essere raggiunta in quanto è impossibile che l’Ucraina possa riconquistare quanto perduto, impegnata com’è a non soccombere definitivamente.
Né potrà essere “autentica” se non dopo decine e decine di anni di pace futura perché il rigetto della Russia è inevitabile come lo è stato per la Germania, nei Paesi da essa occupati, dopo la seconda guerra mondiale. Ma per essere almeno duratura questa pace deve dare serie garanzie all’Ucraina. Garanzie finora scritte sulla carta oleata del Memorandum di Budapest e dei trattati di amicizia tra Russia e Ucraina nonché degli accordi di Minsk, tutti stracciati in ossequio a una politica di forza brutale che, oggi, è tornata a essere dominante senza più schermi e infingimenti.
Ed è qui il punto, caro Direttore: che senza queste garanzie gli ucraini continueranno a combattere e a morire. Perché il problema principale non è Zelenski e non è nemmeno Putin: il problema è cosa siamo disposti a fare noi europei, cosa vogliamo mettere sul tavolo per fermare questo scempio. Questa è la domanda alla quale ognuno di noi, ancor prima dei nostri governanti, deve rispondere.
Caro Leoni,
un grande uomo di pace, costruttore di ponti come si ama dire, quale fu Giorgio La Pira, soleva sempre invitare a «sperare contro ogni speranza», «spes contra spem». E questo è ciò che certamente tutti coloro che vogliono mettere fine a questa tragedia devono fare, chi con la politica, chi con l’economia, chi con la preghiera e il digiuno come papa Leone XIV ha voluto invitare tutti a fare ieri 22 agosto.
Se c’è un punto, ovviamente fragile ma che può suscitare una speranza di trovare un accordo, è il fatto che nel vertice in Alaska i presidenti Trump e Putin hanno parlato di molte altre cose oltre alla situazione in Ucraina. Ovvero, hanno posto il capitolo Ucraina all’interno di un quadro molto più ampio di relazioni tra Usa e Russia, che evidentemente è all’origine anche di questo conflitto. Se si trova un accordo sulle questioni fondamentali e si ristabilisce un clima di fiducia reciproca è più facile che anche per l’Ucraina si trovi una soluzione duratura, con garanzie per tutti.
Perché faccio molta fatica a vedere l’invasione dell’Ucraina come una crisi nata dal nulla, dove l’unica responsabile sarebbe la malvagità di Putin e la sua voglia di ricostituire l’impero sovietico. La guerra tra buoni e cattivi, del Bene contro il Male, delle democrazie contro le dittature, sono narrazioni che vanno bene per la propaganda ma sono un insulto all’intelligenza.
Certo, non possiamo ignorare l’«ideologia del mondo russo» che alimenta il desiderio di conquista, né il modo brutale e spietato del presidente russo nel gestire il potere e il ruolo della Russia; ma sappiamo benissimo che i fattori che hanno contribuito a questa situazione sono diversi e non tutti imputabili a Mosca.
Putin è anche il leader di una potenza che negli ultimi decenni alcuni leader occidentali hanno voluto umiliare, in una sorta di continuazione della Guerra fredda; e in questo schema molti ancora vivono. Bisognerebbe anche chiedersi onestamente se, soprattutto nell’Europa continentale, ci si è resi conto che oltre al popolo ucraino che ha versato un tragico tributo di sangue, a pagare cara questa guerra siamo proprio noi, politicamente ed economicamente. Paghiamo caro l’aver soffiato sul fuoco fin dall’inizio di questo conflitto alimentando l’illusione di una soluzione esclusivamente militare per sconfiggere la Russia, l’essere andati al traino degli USA di Biden rinunciando a qualsiasi tentativo di fermare la guerra. E oggi ci troviamo con il cerino in mano, spiazzati ed emarginati dalla svolta di Trump.
Dovremo anche domandarci se a proposito di sicurezza dell’Europa abbia senso oggi ritenere la Russia come la più grande minaccia quando al nostro interno abbiamo ormai una crescita dell’islam fondamentalista che in alcuni Paesi sta sovvertendo l’ordine; quando le stesse istituzioni europee tendono al totalitarismo, come preconizzato da san Giovanni Paolo II.
Ecco, credo che come europei dovremmo anzitutto chiederci chi siamo o chi vogliamo essere.
Riccardo Cascioli